Un viaggiatore svizzero di passaggio a Londra, il numismatico e antiquario Thomas Platter, ci racconta di avere assistito, nel 1599, a una rappresentazione teatrale sulla morte di Giulio Cesare. E’ l’informazione che ci permette di datare il celebre dramma di William Shakespeare (1564-1616), The Tragedy of Julius Caesar.
Fra i personaggi più notevoli dell’opera, in cui Cesare svolge un ruolo tutto sommato marginale, c’è la figura di Marco Antonio, il cui discorso ai funerali del dittatore è, credo, ben noto a tutti. Sia nelle parole dei cospiratori che gli sono ostili e lo vorrebbero morto assieme a Cesare (Cassio in prima fila), sia nella scena dei Lupercali, Antonio nel dramma è presentato come l’ottimo servitore, umile e acquiescente ai desideri del suo padrone. Quando Cesare gli chiede, nel caso che Antonio vinca la gara dei Lupercali, di toccare il grembo della moglie Calpurnia, per curarla della sua sterilità, Antonio risponde: When Caesar says ‘Do this’ it is performed. Bruto, parlando di lui con Cassio, gli riconosce qualche spirito, ma nelle discussioni circa il suo destino dopo il cesaricidio lo definisce più volte (prima in casa di Bruto stesso; poi nella curia dove il dramma si è appena consumato) una persona poco pericolosa, un semplice rampollo di Cesare, destinato a non sopravvivere una volta che sia tolta di mezzo la pianta principale. Il suo ritratto migliore lo fornisce Cesare stesso, quando lo invita a tenergli lontano Cassio (dunque, ecco di nuovo un Antonio servizievole, al punto da svolgere la funzione di ‘maggiordomo’ di “casa Cesare”). Cassio è tutto l’opposto di Antonio, il cui ritratto viene così’ fuori per contrapposizione: Cassio non ride, non scherza, non ama il teatro e la musica, legge e riflette sul mondo e sulle persone (Antonio, si intuisce, no, e vive di pura istintività). Appena ucciso Cesare, i congiurati si chiedono dove sia Antonio: Trebonio, uno di loro, li rassicura. Alle prime avvisaglie di pericolo è fuggito a casa sua, amazed, stupefatto, spaventato. Eppure, Antonio è motore della vicenda in almeno due occasioni: la prima quando, dopo avere vinto i Lupercali, pone per ben tre volte sulla testa di Cesare la corona destinata al vincitore (Not a crown, just a coronet!). Cesare rifiuta l’omaggio, ma i congiurati vedono nel gesto la materializzazione concreta del loro timore che un giorno egli possa farsi re. Dopo il cesaricidio, Antonio manda presso la Curia un servitore, che tasti il terreno; poi si presenta di persona, garantendo la propria solidarietà agli avversari, rivendicando la legittimità del proprio affetto per Cesare, suo amico e mentore, ma assicurando anche della propria disponibilità a riconoscerne i limiti storici e politici, rinunciando quindi a proseguirne l’opera o a vendicarne la morte. Com’è noto, Antonio chiede poi ai congiurati (e dopo un’accesa discussione fra di loro, ottiene di poterlo fare, grazie al favore di Bruto), la possibilità di celebrare Cesare al suo funerale – Shakespeare, qui come in altre parti della tragedia, comprime i tempi e fa avvenire in stretta contemporaneità avvenimenti che non si erano svolti in così rapida successione come vorrebbe farci credere (Cesare fu ucciso il 15 marzo; i funerali si tenenero il 20 di quello stesso mese).
Nel testo di Shakespeare, non appena gli è stato accordato il permesso di tenere questo suo discorso, Antonio, rimasto solo con il cadavere del dittatore, getta la maschera e dichiara la propria natura infernale:
O pardon me, thou bleeding piece of earth, / That I am meek and gentle with these butchers. / Thou art the ruins of the noblest man / That ever livèd in the tide of times. / Woe to the hand that shed this costly blood! / Over thy wounds now do I prophesy / (Which like dumb mouths do open their ruby lips / To beg the voice and utterance of my tongue) / A curse shall light upon the limbs of men; / Domestic fury and fierce civil strife / Shall cumber all the parts of Italy; / Blood and destruction shall be so in use / And dreadful objects so familiar / That mothers shall but smile when they behold / Their infants quartered with the hands of war, / All pity choked with custom of fell deeds; / And Caesar’s spirit, ranging for revenge, / With Ate by his side come hot from hell, / Shall in these confines with a monarch’s voice / Cry “Havoc!” and let slip the dogs of war, / That this foul deed shall smell above the earth / With carrion men groaning for burial.
Ovvero, tentandone una traduzione la più letterale possibile: “Perdonami, tu, pezzo di terra sanguinante, / perché io sono mite e gentile con questi macellai. / Tu sei ciò che resta dell’uomo più nobile / che abbia mai vissuto nella marea dei tempi. / Ma guai alla mano che ha versato questo prezioso sangue! / Sulle tue ferite ora io profetizzo / (ferite che, come bocche mute, aprono le loro labbra di rubino / per implorare la voce e l’espressione della mia lingua): una maledizione si accenderà sui corpi degli uomini; / furori domestici e feroci lotte civili / ingombreranno tutte le parti d’Italia; / sangue e distruzione saranno / così comuni, oggetti terribili e così familiari, / che le madri non potranno fare a meno di sorridere quando vedranno / i loro bambini squartati dalle mani della guerra. / Ogni pietà sarà soffocata dall’assuefazione alle azioni più crudeli; / e lo spirito di Cesare, infuriando in cerca di vendetta, / con Ate al fianco, viene ribollendo dall’inferno, / ed entro questi territori, con la voce di un monarca, / griderà ‘Distruzione e morte!’, e lascerà sfogare i cani della guerra, / al punto che questa turpe azione puzzerà sulla terra / per il gran numero di carogne umane che gemono in attesa di sepoltura”.
Un po’ come le streghe del successivo Macbeth (1606), insomma, Antonio ripromette (e si ripromette) strage, rovina e morte. Prima di presentarsi alla folla presso il cadavere di Cesare, fa infatti ancora in tempo a stringere un’alleanza con Ottaviano – altra sgrammaticatura storica del tragediografo, naturalmente – grazie al quale si ripromette di dare pieno sfogo alla propria vendetta.
Il discorso di Marco Antonio sul cadavere di Cesare è un capolavoro della retorica classica. Intervenendo subito dopo Bruto, che ha giustificato la propria azione con argomenti di fredda razionalità, Antonio progressivamente infiamma gli animi di una folla poco convinta, rievocando i meriti di Cesare verso il popolo di Roma, la sua modestia, la sua umiltà. Nello stesso tempo, con una famosa litote più volte ripetuta, usata come tormentone, Antonio celebra Bruto, l’uomo d’onore, la cui integrità e sincerità (di azione e parola) non possono essere messe in discussione. In questo modo, contrastando gli elogi di Bruto, che appaiono sempre più obbligati e di maniera, con quelli di Cesare, che appaiono sempre più numerosi e convinti, Antonio scava il terreno sotto i Cesaricidi, e spinge la folla, incosciente e incostante come sempre in Shakespeare, a decidere la morte dei congiurati. Ne fa le spese, vittima inconsapevole, il poeta Gaio Elvio Cinna, scambiato per Lucio Cornelio Cinna, il congiurato. Si realizza così quel progetto di confusione e morte cui Antonio aveva dato espressione nelle parole riportate in precedenza. Ecco ora invece il celebre discorso (elimino alcuni interventi della folla, che interrompono qua e là il flusso oratorio e indicano il progressivo mutare degli umori, e una parte relativa al testamento di Cesare):
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. / I come to bury Caesar, not to praise him. / The evil that men do lives after them; / The good is oft interred with their bones. / So let it be with Caesar. The noble Brutus / Hath told you Caesar was ambitious. / If it were so, it was a grievous fault, / And grievously hath Caesar answered it. / Here, under leave of Brutus and the rest / (For Brutus is an honorable man. / So are they all, all honorable men), / Come I to speak in Caesar’s funeral. / He was my friend, faithful and just to me, / But Brutus says he was ambitious, / And Brutus is an honorable man. / He hath brought many captives home to Rome, / Whose ransoms did the general coffers fill. / Did this in Caesar seem ambitious? / When that the poor have cried, Caesar hath wept; / Ambition should be made of sterner stuff. / Yet Brutus says he was ambitious, / And Brutus is an honorable man. / You all did see that on the Lupercal / I thrice presented him a kingly crown, / Which he did thrice refuse. Was this ambition? / Yet Brutus says he was ambitious, / And sure he is an honorable man. / I speak not to disprove what Brutus spoke, / But here I am to speak what I do know. / You all did love him once, not without cause. / What cause withholds you, then, to mourn for him? / O judgment, thou art fled to brutish beasts, / And men have lost their reason! Bear with me; / My heart is in the coffin there with Caesar, / And I must pause till it come back to me. / But yesterday the word of Caesar might / Have stood against the world. Now lies he there, / And none so poor to do him reverence. / O masters, if I were disposed to stir / Your hearts and minds to mutiny and rage, / I should do Brutus wrong and Cassius wrong, / Who, you all know, are honorable men. / I will not do them wrong. I rather choose / To wrong the dead, to wrong myself and you, / Than I will wrong such honorable men.
“Amici, romani, concittadini, prestatemi orecchio. Vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che gli uomini fanno vive dopo di loro; il bene è spesso interrato con loro. Così sia per Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Se era così, era una colpa grave, e Cesare ne ha risposto gravemente. Ecco, con il permesso di Bruto e degli altri (perché Bruto è un uomo che non mente, e lo sono tutti, tutti uomini che non mentono), vengo a parlare al funerale di Cesare. Era mio amico, fedele e giusto verso di me, ma Bruto dice che era ambizioso, e Bruto è un uomo che non mente. Cesare ha riportato a Roma molti prigionieri, i cui riscatti hanno riempito le casse generali. Sembra questo, in Cesare, ambizioso? Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha pianto con loro; l’ambizione dovrebbe essere fatta di una materia più dura. Eppure, Bruto dice che era ambizioso, e Bruto è un uomo che non mente. Voi tutti avete visto che al Lupercale gli ho presentato tre volte una corona regale, che egli ha rifiutato tre volte. Era questa ambizione? Eppure, Bruto dice che era ambizioso, e certo è uno che non mente. Non parlo per smentire ciò che ha detto Bruto, ma sono qui per dire ciò che so. Voi tutti lo amavate un tempo, e non senza motivo. Quale motivo vi trattiene dunque ora dal piangerlo? O giudizio, tu sei passato alle bestie brutali, e gli uomini hanno perso la ragione! Portami con te, Cesare; il mio cuore è nella bara con te, e devo riposarmi finché esso non torni da me. Solo ieri la parola di Cesare avrebbe potuto opporsi all’intero mondo. E ora lui giace lì, e nessuno è così povero da volergli rendere omaggio. O signori, se io fossi intenzionato a suscitare nei vostri cuori e nelle vostre menti la rivolta e la rabbia, farei torto a Bruto e a Cassio, che, lo sapete tutti, sono uomini che non mentono. Non farò loro questo torto. Preferisco fare un torto ai morti, a me e a voi, piuttosto che fare un torto a uomini così di parola”.
A questo punto, Antonio punta sulla mozione degli affetti, mostrando il mantello di Cesare lacerato dalle ferite. E’ quello stesso mantello di cui parla Cesare nel De bello Gallico, e che, con il suo colore rosso, segnala ai soldati romani la presenza del loro comandante, la condivisione da parte sua delle loro stesse fatiche, il suo essere primus inter pares. Con un’altra figura retorica, la prosopopea, Antonio dà voce e forma a ognuna delle ferite visibili sulla veste, assegnandole ora all’uno ora all’altro dei congiurati, che da “honorable” passano a “envious and traitors men”.
If you have tears, prepare to shed them now. / You all do know this mantle. I remember / The first time ever Caesar put it on. / ’Twas on a summer’s evening in his tent, / That day he overcame the Nervii. / Look, in this place ran Cassius’ dagger through. / See what a rent the envious Casca made. / Through this the well-belovèd Brutus stabbed, / And, as he plucked his cursèd steel away, / Mark how the blood of Caesar followed it, / As rushing out of doors to be resolved / If Brutus so unkindly knocked or no; / For Brutus, as you know, was Caesar’s angel. / Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him! / This was the most unkindest cut of all. / For when the noble Caesar saw him stab, / Ingratitude, more strong than traitors’ arms, / Quite vanquished him. Then burst his mighty heart, / And, in his mantle muffling up his face, / Even at the base of Pompey’s statue / (Which all the while ran blood) great Caesar fell. / O, what a fall was there, my countrymen! / Then I and you and all of us fell down, / Whilst bloody treason flourished over us. / O, now you weep, and I perceive you feel / The dint of pity. These are gracious drops. / Kind souls, what, weep you when you but behold / Our Caesar’s vesture wounded? Look you here, / Here is himself, marred as you see with traitors.
“Se avete lacrime, preparatevi a versarle ora. / Tutti conoscete questo mantello. Io ricordo perfino / la prima volta che Cesare lo indossò. / Fu in una sera d’estate nella sua tenda, / il giorno che sbaragliò i Nervii. / Guardate, in questo punto è passato il pugnale di Cassio. / Vedete che squarcio fece l’invidioso Casca. / Attraverso quest’altro squarcio l’amato Bruto lo trafisse, / e, mentre strappava via il suo maledetto pugnale, / guardate come il sangue di Cesare lo seguì, / come si precipitò fuori dalle porte per capire / se era Bruto a bussare così scortesemente, oppure no; / Perché Bruto, come sapete, era l’angelo di Cesare. / Giudicate voi, o dèi, quanto Cesare lo amava! / Questo fu il taglio peggiore di tutti. / Perché quando il nobile Cesare vide Bruto che lo pugnalava, / l’ingratitudine, più forte delle braccia dei traditori, / lo sconfisse del tutto. Allora scoppiò il suo cuore potente, / e, coprendosi il volto nel mantello, / alla base della statua di Pompeo / (che per tutto il tempo fu bagnata di sangue) il grande Cesare cadde. / Oh, che caduta fu quella, miei compatrioti! / Allora io, voi e tutti noi siamo caduti, / mentre il tradimento sanguinario fioriva su di noi. / Ora piangete, e vedo che sentite / il peso della pietà. Queste sono gocce gradite. / Anime gentili, che fate, piangete nel vedere / la veste del nostro Cesare trafitta? Guardate qui, / qui c’è lui stesso, ucciso, come vedete, dai traditori”.
Antonio ha cambiato così l’ottica con cui guardare ai fatti e, dopo un ulteriore riferimento al testamento di Cesare (che ometto, alla pari del precedente), invita i concittadini a passare all’azione. Il ritornello degli honorable men assume ora carattere decisamente sarcastico, così come fasulle sono le indicazioni di personale umiltà e la celebrazione di Bruto come bravo oratore (ma vuoto di fatti). Antonio, nel contempo, si presenta come uno della folla, che ha gli stessi gusti e gli stessi sentimenti della folla, e all’occorrenza anche gli stessi limiti. Riconosciamo qui il politico da manuale, sapendo che ogni generazione ha il suo Antonio, che dietro alla (apparente) umiltà e bonomia nasconde desiderio di caos e di potere.
Good friends, sweet friends, let me not stir you up / To such a sudden flood of mutiny. / They that have done this deed are honorable. / What private griefs they have, alas, I know not, / That made them do it. They are wise and honorable / And will no doubt with reasons answer you. / I come not, friends, to steal away your hearts. / I am no orator, as Brutus is, / But, as you know me all, a plain blunt man / That love my friend, and that they know full well / That gave me public leave to speak of him. / For I have neither wit, nor words, nor worth, / Action, nor utterance, nor the power of speech / To stir men’s blood. I only speak right on. / I tell you that which you yourselves do know, / Show you sweet Caesar’s wounds, poor poor dumb mouths, / And bid them speak for me. But were I Brutus, / And Brutus Antony, there were an Antony / Would ruffle up your spirits and put a tongue / In every wound of Caesar that should move / The stones of Rome to rise and mutiny.
“Buoni amici, dolci amici, non lasciate che io susciti una così improvvisa ondata di ammutinamento. Quelli che hanno voluto questa morte sono persone la cui parola è sincera. Non so quali ragioni private abbiano avuto, ahimè, che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto. Sono saggi e onesti, e senza dubbio vi risponderanno con buone argomentazioni. Non vengo, amici, a trascinare via il vostro cuore. Non sono un oratore come Bruto, ma, come voi tutti mi conoscete, sono un uomo semplice e schietto, che amava il suo amico, e loro lo sanno bene, se mi hanno dato il permesso di parlare in pubblico di lui. Perché io non ho né spirito, né facondia, né valore né capacità di azione, né l’espressione, né il potere della parola per smuovere il sangue degli uomini. Io parlo solo in modo corretto. Vi dico quello che voi stessi sapete, vi mostro le ferite del caro Cesare, povere, povere bocche mute, e dico loro di parlare per me. Ma se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, allora sì che ci sarebbe un Antonio capace di arruffianarsi i vostri spiriti e di dare lingua a ogni ferita di Cesare, così da muovere le pietre di Roma a sollevarsi e ammutinarsi”.
Riporto ora alcune interpretazioni celebri del discorso (la lunghezza è variabile, a seconda dei brani di partenza). Nel 2016 Damian Lewis, attore inglese di cinema (fra cui il recente Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino) e di fortunate serie televisive, ma anche molto attivo sulle scene londinesi, nel teatro di prosa e di musical, ha registrato una parte del discorso per il giornale The Guardian, espressamente perché fosse caricato su youtube (era il quarto centenario dalla morte del drammaturgo). La clip, che si interrompe alla prima battuta di commento dei cittadini, si gioca tutta sull’espressività dell’interprete, sui suoi occhi estremamente vicini allo spettatore, sulla bocca da cui vediamo letteralmente sprizzare la saliva e il veleno man mano che aumenta l’enfasi retorica del discorso – un effetto molto televisivo, che a teatro non sarebbe possibile, ma che rende coinvolgente il tutto, nonostante l’assenza di costumi, scene, qualsiasi tentativo di “ricostruire” il momento drammatico. E’ la celebrazione della pura forza dell’interpretazione. Il ritmo è veloce, serrato, a tratti forse perfino troppo (lo strumento del web impone che tutto duri pochi minuti). I concetti non si sedimentano nella mente degli ascoltatori, antichi o moderni che siano: perché non sono le idee a contare. Perfetto modello di politico, Antonio vince per la varietà sottile delle sue inflessioni e la capacità di persuasione del suo intero essere e agire, non per quello che dice, che conta solo relativamente.
La versione più classica della scena è quella contenuta nel film di Joseph L. Mankiewicz (1953). Interpreta Marco Antonio un giovanissimo Marlon Brando, non ancora trentenne, ma già aureolato dal successo ottenuto con A Streetcar named Desire di Tennessee Williams (1952). Nella clip ci sono alcune battute finali non incluse nel testo di prima, in cui Antonio insiste sul testamento di Cesare, che ha nominato suo erede l’intero popolo romano (l’argomento più forte di tutti, nella visione smaliziata e senza illusioni di Shakespeare). L’interpretazione è tutta giocata sulla forza visiva di Brando, che volutamente evita un’eccessiva varietà di accenti, per costruire piuttosto una climax di furore, che, pur insistendo ossessivamente su uno stesso tasto, riesce a fare montare a poco a poco la reazione della folla. Nel complesso, l’intera scena è un monumento plastico al personaggio e a chi gli ha dato la propria carne, versione moderna di dittatori urlanti ben noti alla prima metà del Novecento. Straordinario il gesto di Antonio alla fine della prima parte del discorso, prima che la macchina da presa si sposti sulla folla. In un momento privato, con le spalle voltate al pubblico, con un semplice sguardo Antonio/Brando rivela tutto il lato demoniaco del personaggio.
Charlton Heston interpretò curiosamente per ben due volte il personaggio di Antonio, in un film assai notevole del 1950 (ci torneremo sopra in altra sede) e in un altro del 1970, distribuito in Italia con il titolo Ventitré pugnali per Cesare. A quella data, il quarantasettenne Charlton Heston, già all’inizio della fase finale della sua carriera, non aveva forse più il physique du rôle per interpretare il trentanovenne Marco Antonio, anche perché nella immaginazione popolare e nel testo stesso di Shakespeare permane l’idea di un personaggio più giovane della sua età anagrafica. La regia del nulla più che onesto Stuart Bridge risolve il tutto puntando alla grandiosità da kolossal anni Sessanta. Heston, però, regge complessivamente bene la parte, rendendo con fluidità e varietà di accenti e di toni le battute del personaggio, risolvendone i diversi sentimenti quasi attraverso l’adozione di due voci differenti, una più roca, una più acuta. La clip è ‘ più lunga delle precedenti, e include l’intero discorso di Antonio.
Nel 2012 la Royal Shakespeare Company, una compagnia specializzata nel mettere in scena opere di Shakespeare, in inverno al Barbican Center di Londra, in estate a Stratford-on-Avon, luogo natale del poeta, presentò uno spettacolo la cui novità appare a prima vista. Siamo nel mondo del politicamente corretto e della globalizzazione. La regia di Gregory Doran e l’interpretazione di Ray Fearon (attore di teatro assai noto in Gran Bretagna, apparso anche nella saga cinematografica di Harry Potter; londinese di nascita, ma originario dell’India) vogliono sottolineare l’eterno ripetersi delle stesse storie a tutte le latitudini geografiche e cronologiche. Come effetto di questa opera di attualizzazione, finisce per emergere quale dato essenziale il legame di Antonio con Cesare, in virtù del quale Antonio, di qualunque Antonio della Storia si tratti, piange in Cesare, di qualunque Cesare si tratti, soprattutto un amico e un compagno di lotta. Fearon è decisamente bravo, a tratti è perfino ironico, ad esempio nell’ampia gestualità con la quale accompagna le parole, e soprattutto nei sempre diversi gesti con i quali scandisce e sconfessa il riferimento agli honorable men. L’impressione generale è però che, come spesso succede in queste attualizzazioni, l’attenzione del contesto si accentri più sulla trasposizione che sulla resa dei dettagli interpretativi, come avviene nella descrizione della folla o nello spazio concesso a dettagli funerari ovviamente estranei al testo originale.
Ogni rivoluzione ha la sua controrivoluzione: nel 2017, la medesima compagnia si è affrettata a tornare a uno Julius Caesar con tutte le carte in regola. La regia è di Angus Jackson; Antonio è interpretato da James Corrigan, oggi rinomato attore di cinema. Scene, costumi, reazioni attoriali sono da manuale. Corrigan adotta volutamente un tono sottomesso, nel quale risalta soprattutto l’amico che celebra l’amico, e però pur partendo da un ambito privato arriva a provocare una reazione pubblica. Nel fare così, Corrigan non sbaglia un colpo; anche la folla, per una volta tanto, non ha nulla di macchiettistico. Nel complesso, forse, il tutto risulta però meno interessante proprio dal punto di vista registico, e l’impressione mia personale è quella di un passo indietro rispetto alle provocazioni precedenti. Un Giulio Cesare che ha qualcosa di televisivo, ma ha perso qualcosa sul piano dell’epica.
La discussione è però aperta. Ringrazio Elena Sandre e Jessica Gentile per gli spunti che mi hanno offerto, e attendo i pareri di molti.
© Massimo Gioseffi, 2021
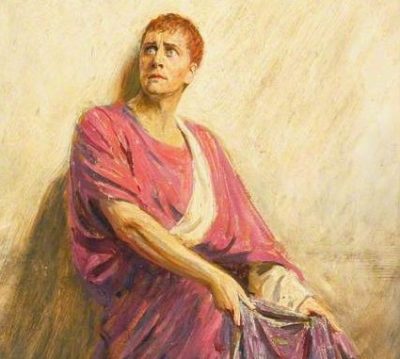
Leave a Reply