Materiali di lavoro per un corso di commento alla Ricerche Filosofiche di Wittgenstein tenuto nell'anno 1975. I testi numerati da I a VI si possono ritirare riuniti nell'unicoi file PDF intitolato "Commenti a Wittgenstein"
Data di immissione in questo archivio: dicembre 2002
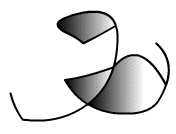
 Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
VI.
Il linguaggio ed i linguaggi
(Ric. Fil., oss. 487-535)

VI.1 - Lo scopo del linguaggio
Un tema ricorrente nelle Ricerche Filosofiche è che le parole sono strumenti o possono essere considerati come tali. Ciò naturalmente ha anche a che fare con la tematica dell’«uso» nella teoria del significato. La stessa cosa può essere detta per il linguaggio nel suo insieme. Anch’esso è uno strumento. Ma non è anche il caso che si esiga una risposta abbastanza chiara alla domanda: uno strumento per che cosa?
La risposta più naturale sembra essere: uno strumento per comunicare fra noi. Che la comunicazione sia la funzione essenziale da attribuire al linguaggio, oltre che ovvio, sembra essere in accordo con il punto di vista dei giochi linguistici. Ma vi è forse una risposta che sembra ancora più aderente a quel punto di vista: il linguaggio è un mezzo per influenzare gli altri, per agire con loro e su di loro. In modo un po’ brutale, ma molto efficace: «Senza il linguaggio... non possiamo costruire strade e macchine, ecc.». (oss. 491). Sembra che Wittgenstein pensi che in certo senso solo subordinatamente a ciò si parli poi del linguaggio come mezzo di comunicazione tra gli uomini.
Di ciò vi è qualche buona ragione che ci riporta all’orientamento filosofico generale delle Ricerche. Ovunque in quest’opera si cerca una filosofia «concreta» del linguaggio, ed il parlare semplicemente di comunicazione ci riporta forse ad una concezione del linguaggio secondo la quale esso rappresenta anzitutto una pura «esteriorizzazione di pensieri» considerata come una comunicazione possibile. In realtà un’esteriorizzazione di pensieri diventa una comunicazione effettiva forse solo quando viene calata in un contesto in cui si vuol provocare, attraverso di essa un’azione, si vuole esercitare una influenza.
In questo senso si dice una volta (oss. 304) che occorre rompere in modo radicale con l’idea che il linguaggio funzioni sempre in un unico modo, che esso serva sempre allo stesso scopo, e cioè a trasmettere pensieri, siano questi intorno a cose, a colori, al bene o al male o a qualunque altra cosa. La critica della concezione secondo cui «Scopo del linguaggio è esprimere pensieri» è del tutto esplicita nella oss. 501. Ad essa potremmo contrapporre: «Scopo del linguaggio è costruire ponti». E se questo riferimento al costruire ponti ci sembra troppo «pratico», siamo liberi di arricchire a piacere in altra direzione i nostri esempi. Quando dico di provare dolore, non vogliamo mai fare soltanto una comunicazione, ma orientare l’altro ad assumere un determinato comportamento verso di me.
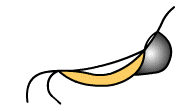
VI.2 Pluralità dei linguaggi e linguaggio ordinario
Ma qui è sottinteso un altro problema di notevole importanza per una comprensione della filosofia complessiva delle Ricerche. Stiamo parlando del linguaggio al singolare. Parliamo del linguaggio... Ma abbiamo veramente il diritto di esprimerci in questo modo? Forse vi è un solo linguaggio? Oppure impiegando il singolare si ricade nell’idea di un concetto di linguaggio nel senso di ciò che tutti i linguaggi hanno in comune?
Sappiamo già che le cose stanno diversamente. Ma è bene tornare a riflettere su questo punto. In fin dei conti il punto di vista dei giochi linguistici dovrebbe spingerci in direzione di una concezione accentuatamente «plurale», e magari suggerirci che l’espressione singolare - il linguaggio - non dovrebbe essere presa molto sul serio.
Eppure, se andiamo a rileggerci l’oss. 7 nella quale veniva introdotta la nozione di gioco linguistico, troviamo la parola linguaggio usata proprio al singolare. «Inoltre chiamerò gioco linguistico anche tutto l’insieme costituito dal linguaggio e dalle attività in cui è intessuto».
Nell’oss. 494 si spiega: «Voglio dire: ciò che chiamiamo ‘linguaggio’ è, innanzitutto, l’apparato del nostro linguaggio ordinario, del nostro linguaggio parlato; e poi altre cose, secondo la loro analogia o la loro confrontabilità con esso».
Questo riferimento al linguaggio (al singolare) ed al tempo stesso al linguaggio «ordinario» - è stato frainteso. Perciò è opportuno indugiare un poco su questo punto.
Di fronte a noi ci sono una molteplicità di linguaggi (lingue) - l’italiano, il francese, l’inglese... ed anche le lingue della scienza, il linguaggio della fisica, della biologia, ecc. Per quanto riguarda l’istituzione della nozione di linguaggio, dobbiamo attribuire una sorta di priorità al linguaggio ordinario - poiché in esso stiamo anzitutto installati. Questo linguaggio fa parte della nostra esperienza del mondo.
Ma questa precisazione rende forse ancora più urgente la domanda: di che linguaggio si tratta? Risponderei: proprio questo, quello in cui ora sto parlando. Dunque si tratta della lingua italiana? Evidentemente no! Il linguaggio ordinario non è per l’italiano la lingua italiana, per l’inglese la lingua inglese e così via: anche se naturalmente passa attraverso tutte queste lingue ed ognuna di esse può pretendere di rappresentarlo. Il punto essenziale è che il linguaggio che chiamiamo «ordinario» non deve essere concepito come uno tra i molti linguaggi, ma è ciò che chiamiamo anzitutto, appunto al singolare, il linguaggio. Ad esso attingiamo l’idea stessa di linguaggio. Poi potremo chiamare linguaggio anche altre cose «secondo la loro analogia o la loro confrontabilità con esso»: «Il gallo chiama le galline con il suo canto» (oss. 493).
La formulazione dell’oss. 494 che abbiamo citato poco fa, rammenta da vicino - proprio per quanto riguarda l’importante inciso: «e poi altre cose, secondo la loro analogia o la loro confrontabilità con esso» - altre formulazioni come le seguenti:
«Il risultato è che soltanto dell’uomo vivente, e di ciò che gli somiglia, si può dire che abbia sensazioni...» (oss. 281).
«Solo dell’uomo, e di ciò che è ad esso simile, diciamo che pensa» (oss. 360).
Questa somiglianza di formulazione non solo non è casuale, ma esprime un preciso raccordo problematico. Potremmo anzi parafrasare l’oss. 360 - «Solo dell’uomo, e di ciò che è ad esso simile, diciamo che pensa» - in questo modo: «solo dell’uomo, e di ciò che è ad esso simile, diciamo che parla». Se aggiungiamo: ed il linguaggio che parla è quello ordinario, si comprende subito che forse questa è una precisazione di troppo. L’uomo anzitutto parla - ed a questo parlare è legato il linguaggio. A partire di qui la nozione potrà diventare plurale a piacere, vi saranno le lingue naturali, i linguaggi più o meno artificiali e quelli immaginari, e tra essi non troveremo il linguaggio ordinario.
Quanto al parlare possiamo considerarlo da un duplice punto di vista: o come un comportamento - emettere suoni - da cui conseguono altri comportamenti, oppure come emissioni sonore che generano certe reazioni in quanto hanno un senso e questo senso viene compreso.
Questo problema è in realtà già presente fin dalle prime battute delle Ricerche Filosofiche. Comprendere una proposizione nel suo senso non è la stessa cosa che reagire ad essa, anche se da un punto di vista esterno non possiamo far altro che registrare che ad una certa emissione fonica è seguita una certa reazione comportamentale.
Nel bel mezzo di una conversazione, io potrei rivolgermi a qualcuno dicendo una combinazione insensata di parole, e potrei far questo per provocare stupore nel mio interlocutore, per far sì che egli mi fissi con la bocca spalancata. Qui l’aver senso e il comprendere sono chiaramente distinti dal «produrre un effetto». «Se l’effetto è che l’altro mi fissa con la bocca spalancata, io non dirò per questo che quella frase è un ordine di fissarmi, ecc., anche se avessi voluto produrre proprio questo effetto» (oss. 498).
Ciò naturalmente chiarisce anche che, quando parlavamo dello scopo del linguaggio come un «produrre effetti» non intendevamo eliminare il problema del senso, il problema dell’«anima delle parole» (oss. 503-510).
Quanto alla distinzione tra senso e nonsenso essa deve ricevere la forma più libera possibile. Affermare che una certa combinazione di parole è priva di senso significa che essa è fuori dalla circolazione (oss. 500): si tratta di una «combinazione esclusa dal dominio del linguaggio». Queste esclusioni siamo noi stessi a farle e quindi siamo noi stessi che delimitiamo i limiti del linguaggio (oss. 499).
Dentro questa concezione aperta si comprende come ogni estensione sia possibile. L’espressione «linguaggio» non deve essere necessariamente riservata alle parole. Oltre il linguaggio delle parole vi può essere il linguaggio delle rappresentazioni (oss. 512). Nel Tractatus per l’idea di un simbolismo logicamente adeguato, in realtà Wittgenstein avevo preso come modello la rappresentazione mediante figure - mentre ora, rammentando quelle posizioni egli contesta che vi sia nella rappresentazione figurale un qualche privilegio sotto il profilo logico. Certo, nel linguaggio delle parole è possibile formulare contraddizioni come «Pietro è a sinistra ed a destra di Paolo» - mentre non posso disegnare uno stato di cose corrispondente a questa frase. Ma potrebbe non essere difficile trovare esempi analoghi anche nel campo dei disegni, come raffigurazioni di corpi impossibili da realizzare (oss. 512). Di linguaggio, di senso e di nonsenso si può dunque parlare anche in rapporto a cose che non sono affatto parole. Ci troviamo di fronte ad una estensione nell’uso del termine e della problematica corrispondente.
Quando parliamo di «linguaggio pittorico» non diciamo semplicemente: esistono molti linguaggi, e fra essi vi è il linguaggio pittorico. E tanto meno ipotizziamo una superteoria del segno al quale subordinare l’universo intero. Ma cominciamo ad avviare un confronto e sulla sua base a dar senso alla possibilità di estendere la parola linguaggio anche alla pittura. Non vi è un concetto generale di linguaggio rispetto al quale tutte le cose che chiamiamo linguaggi siano specie rispetto al genere.
Possiamo così paragonare una proposizione ad una raffigurazione, e servirci di questo paragone per estendere le nostre riflessioni. Analogamente nel caso della musica. Parlando di linguaggio musicale cominciamo ad operare confronti che mettono a loro volta in moto le nostre riflessioni in direzioni che proprio da quei confronti sono suggerite. Naturalmente in questo modo potremo anche imboccare vicoli ciechi, porci domande falsamente impostate - ma la riflessione critica serve appunto ad evitare questi rischi; ed a orientarci in quelle direzioni in cui invece quei suggerimenti possono essere produttivi.
Come nel caso di un dipinto potremmo dire che il suo senso mi è mostrato dalla sua struttura cromatica e figurale, così per il senso di un tema musicale: anch’esso si mostra all’udito nella struttura, nel modo in cui i suoni sono configurati in essa (oss. 523). Anche in questo caso, come in quello delle proposizioni, si potrà distinguere tra senso e non senso, oppure parlare di un comprendere o di un fraintendere.
In effetti, chiamando in causa musica e pittura, diamo anche alcuni chiarimenti sulla tematica del comprendere. Comprendere una proposizione potrebbe voler dire saperla sostituire con un’altra che dice la stessa cosa. «Ora dillo con parole tue» - per vedere se l’altro ha veramente compreso o ripete la cosa macchinalmente. Se tuttavia consideriamo il linguaggio poetico vale l’opposto: comprendere in questo caso significa afferrare la necessità interna di una proposizione in quel determinato luogo, quindi comprendere che essa non può essere sostituita da nessun’altra. Certo, è possibile proporre una parafrasi di una poesia, ma con ciò viene chiarito solo il suo significato concettuale: il suo significato poetico non può essere parafrasato (oss. 531).
Il riferimento agli altri linguaggi può insegnarci persino qualcosa in rapporto al linguaggio delle parole.
«...il comprendere una proposizione del linguaggio è molto più affine al comprendere un tema musicale di quanto forse non si creda» (oss. 527).
Per chi «comprende» un tema musicale è molto difficile immaginarsi in quale situazioni si trovi chi, udendo un tema musicale, non lo comprende. Inversamente, chi non comprende non riesce a farsi un’idea di che cosa dovrebbe comprendere - dal momento che comunque ode quello che ode. Supponiamo allora di porci il problema di insegnare ad ascoltare - dunque di insegnare a comprendere che ciò che stiamo udendo è un «tema», una «linea melodica». Dobbiamo in qualche modo rendere avvertibile quella «curva» eventualmente in uno dei suoi possibili travestimenti. Durante l’ascolto faremo forse dei gesti, richiameremo l’attenzione su un passaggio -«vedi che cosa accade ora»... Eventualmente faremo sentire più volte quel motivo, oppure lo rifaremo al pianoforte semplificandolo, mettendone a nudo l’impalcatura. In tutto ciò ci serviremo di imitazioni gestuali, di parole, di immagini, di paragoni. Molto spesso ricorreremo certamente a termini che caratterizzano elementi del linguaggio, ad esempio frase o periodo; anche la punteggiatura potrebbe avere la sua importanza. «Qui è come se venisse aperta una parentesi... ed ora - lo senti? - la parentesi è stata chiusa...» (oss. 527). In breve: ci serviremo di materiali svariati, di svariati mezzi.
In questo modo, nello stesso tempo ovvio e complicato, cercheremo di trasmettere il senso, di «spiegarlo». Spiegare il senso non è qualcosa come una «analisi». Spieghiamo il senso nella misura in cui conduciamo qualcuno ad afferrarlo.
«Chiediti: in qual modo si conduce qualcuno alla comprensione di una poesia o di un tema? La risposta a questa domanda ti dice in qualche modo qui si spiega il senso». (oss. 533).
In tutto ciò risuona certamente ancora la antica distinzione tra dire e mostrare. L’esempio della musica è istruttivo anche da questo punto di vista, perché se qui non posso «dire» il senso, posso tuttavia mostrarlo.
Seguendo alcune regole possiamo scrivere successioni di accordi tali che essi si sviluppano secondo una logica interna che conduce ad una conclusione. Qui si parla di conclusione in senso percettivo: l’ultimo accordo risuona come ultimo - oltre di me non c’è bisogno di altro. Tuttavia non è affatto detto che chiunque, udendo una simile successione percepisca l’effetto di conclusione. Si tratta allora di insegnargli a percepirlo (oss. 535). Ma si può forse insegnare qualcuno a percepire qualcosa? Si può. Per far questo tuttavia non si tratterà di «verbalizzare» ovvero di «tradurre in parole» la percezione della conclusione: le parole possono avere una parte, ma non quella di costituire una sorta di sostituto del dato percettivo. Insegneremo a percepire la conclusione, ad esempio, facendo udire varie sequenze costruite in questo modo, accanto a sequenze che non concludono, che rimangono in sospeso. Ciò facendo, si faranno eventualmente commenti ad alta voce di vario genere. Non si tratta dunque di convertire la percezione in parole: ma di condurre qualcuno ad afferrare il senso.
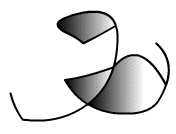
VI.3 Contesti del senso
«Udire una parola in questo significato. Come è strano che esista una cosa del genere» (oss. 534). Ma una cosa del genere comunque esiste. La parola suona ora in modo differente. Ad esempio, viene chiamato il mio nome. A seconda del contesto potrà accadere che il nome sarà circondato da un’atmosfera interamente indifferente. Ed è importante anche come viene enunciato - se esso venga chiamato ad alta voce, ed in modo brutale, o semplicemente sussurrato. Ciò vale a maggior ragione per le proposizioni. In rapporto ad esse, è importante anche il modo di enunciarle: «Fraseggiata in questo modo, accentata in questo modo, udita in questo modo, la proposizione è l’inizio di un passaggio a queste proposizioni, a queste immagini, a queste azioni» (oss. 534).
Tutto ciò non fa letteralmente parte del suo significato, così come esso ci è comunicato dalle parole di cui essa è fatta. E tuttavia la problematica della senso deve essere dilatata anche in questa direzione.
Nella oss. 525 ci cita una frase che sembra tratta a caso da un racconto. «Dopo che le ebbe detto questo, la lasciò come aveva fatto il giorno prima». Ma il racconto non c’è. Posso allora dire di aver compreso il senso di questa proposizione? In parte certamente sì. Ma si completa questo senso se conoscessi il contesto in cui essa è stata pronunciata. Ed essa potrebbe certo assumere una inclinazione differente. Nel contesto di un racconto, essa potrebbe rivelarsi come «carica di significati» inattesi e forse anche particolarmente «importanti» proprio in rapporto al suo senso.
Ciò che va subito notato è che una simile problematica può ritrovarsi anche in un ambito più vasto dei fenomeni linguistici in senso stretto. Ad esempio, potremmo dire di una risata che essa è carica di significati, e persino, secondo il contesto, di significati ben determinati (oss. 543). Qui siamo fuori dall’ambito del linguaggio delle parole ma restiamo all’interno di una problematica dell’espressione. Quest’ultimo termine potrebbe essere illustrato facendo riferimento a cose che non hanno affatto a che fare con il linguaggio - ad esempio potremmo parlare dell’espressione di un volto o dell’espressività di un gesto.
Proprio l’esempio dell’espressione di un volto svolge una parte importante nello sviluppo di questo tema (oss. 536-537 e 539). Che cosa intendiamo dire quando diciamo: «In questo volto leggo la pusillanimità?». Si tratta di una sorta di giustapposizione interpretativa, di proiezione che si aggiunge dall’esterno sui lineamenti del volto che in sé non possono esprimere né il coraggio né la vigliaccheria?
Potremmo formulare la questione nei termini di una singolare alternativa: sono io stesso responsabile della tonalità emotiva del volto che vedo, cosicché lo stesso volto potrà apparirmi espressivo ora nel senso della vigliaccheria ora nel senso del coraggio, secondo un modo di guardarlo che posso orientare a mio piacimento; oppure vi sono effettivamente in questo volto dei tratti che sono essi stessi espressivi in questa o quella direzione? La prima tesi ci sembra troppo semplice e ingenua; e la seconda genera giustificate perplessità.
Wittgenstein, muovendosi intelligentemente tra questi due poli, rifiuta anzitutto la spiegazione di un’associazione estrinseca: «... in ogni caso la pusillanimità non mi sembra semplicemente associata al volto, legata ad esso dall’esterno; ma il timore vive sui tratti del volto» (oss. 537). Dunque non siamo affatto liberi di imporre una variazione a piacere dell’espressione del volto. E tuttavia possiamo realmente sostenere che il timore sia stampato sulla faccia di quest’uomo come una impronta indelebile? A modo di prova, potremmo far valere la prima tesi e tentare di guardare questo volto in modo tale da fare apparire o trasparire qualcosa come il coraggio. La questione del resto si gioca in generale su situazioni in cui interviene appunto una variazione nell’espressione, eventualmente un suo rovesciamento di direzione. (oss. 536, 537, 539).
Intanto va chiarito che non bisogna confondere il coraggio con l’espressione di coraggio. Evidentemente effettuare una variazione espressiva non significa immaginare che «un tale con questa faccia possa, per esempio, salvare la vita di un uomo (naturalmente una cosa del genere si può immaginare di ogni volto)» (oss. 536). - L’espressione che viene colta nei tratti del volto non è il risultato di un pensiero che si aggiunga alla percezione del volto stesso e nemmeno è riducibile a dati di fatto o giustificabile attraverso dati di fatto Noi percepiamo la pusallinimità in questo volto, e in ciò nulla cambia se siamo perfettamente informati delle sue azioni coraggiose.
La stesso volto, lo stesso gesto può comunque subire una improvvisa variazione di senso. In che modo ciò possa avvenire è in realtà già stato suggerito dalla variazione del contesto, come nel caso della frase estratta a caso da un racconto ignoto. In un dipinto incompleto un volto sorride - e quel sorriso appare subito diverso che si immagina che quel volta «sorrida ad un gioco di bimbi oppure alle sofferenze di un nemico» (oss. 537). Oppure cogliamo nel volto che ci era apparso fin qui come timoroso, un’inclinazione che ce lo fa apparire come se in esso trasparisse una sorta di «indifferenza di fronte al mondo esterno». Avviene così una modificazione di «atmosfera», come accade quando, in teatro, lo stesso scenario viene illuminato con una luce di un diverso colore.
Il richiamo ai contesti ed alla variazione dei contesti istituisce un punto di raccordo con l’intera teoria del significato di Wittgenstein. E gli esempi si illustrano l’un l’altro:
«La diversa interpretazione dell’espressione di un volto può paragonarsi alla diversa interpretazione di un accordo musicale, quando sentiamo l’accordo come una modulazione ora in questa tonalità, ora in quest’altra» (oss. 536).
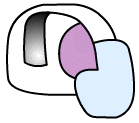
VI.4 Il linguaggio e il metodo della filosofia
Che il riferimento al linguaggio rappresenti nella concezione di Wittgenstein un riferimento che circoscrive il metodo vero e proprio della filosofia è una tesi che non ci soddisfa - abbiamo già richiamato l’attenzione su questo punto. Questo metodo consisterebbe nel mettere alla prova i problemi filosofici attraverso un’analisi degli usi ordinari delle parole. Si tratta di una formulazione che sembra ad un primo sguardo del tutto corretta, eppure io penso che vi siano molte ragioni per respingere questa caratterizzazione come capace di cogliere il centro effettivo della problematica proposta. Una concezione che subordini il riferimento al linguaggio in Wittgenstein come un riferimento al linguaggio ordinario che dovrebbe assolvere in quanto tale una funzione di metodologia analitica può essere fraintesa e rivelarsi in realtà troppo riduttiva. Ovviamente si coglie certamente qui un aspetto del problema. Ci possono citare affermazioni molto chiare di Wittgenstein che lo confermano. L’idea che i problemi filosofici sorgano da fraintendimenti relativi all’uso del linguaggio, formulata nel Tractatus è ancora ben presente nelle Ricerche filosofiche. Tuttavia ora non si tratta di dipanare le equivocità del linguaggio ordinario attraverso il modello di un linguaggio logicamente in ordine. Si tratta piuttosto del fatto che nella filosofia usiamo espressioni tratte dal discorso corrente, ma in certo senso effettuando su di esse una sorta di svisamento estraendole dalle circostanze correnti del loro impiego. Da questa operazione sorgono appunto strani problemi. Ed allora compito della ricerca consisterà proprio «nel riportare le parole, dal loro impiego metafisico, indietro al loro impiego quotidiano» (oss. 116). In linea generale si può dire che una simile metodologia venga messa in opera ogni volta che Wittgenstein indugia nell’illustrare la «grammatica filosofica» di una parola - comprendere, pensare, io, credenza, ecc. L’immagine secondo cui «quando filosofiamo siamo come selvaggi, come uomini primitivi che ascoltano il modo di esprimersi di uomini civilizzati, lo fraintendono e traggono le più strane conseguenze dalla loro erronea interpretazione» (oss. 194) compendia efficacemente questo aspetto del problema. Potremmo pensare che quando filosofiamo ci eleviamo rispetto alla vita di ogni giorno: mentre le cose stanno proprio all’opposto. Gli uomini civilizzati sono proprio gli uomini della strada rispetto al quale il filosofo appare come un primitivo. Egli deforma l’impiego delle espressioni sottraendole alle loro circostanze e inserendole in contesti che sono ad essi estranei. La stessa parola che nel discorso corrente è simile ad una ruota dentata che esplica una funzione ben determinata nel meccanismo complessivo, nel dibattito filosofico è invece una ruota dentata che non è collegata con nessun’altra ruota - gira a vuoto. Sembra che faccia qualcosa, ed invece non fa nulla.
«Le confusioni di cui ci occupiamo sorgono per così dire quando il linguaggio gira a vuoto, non quando è all’opera» (oss. 132).
«Quando i filosofi usano una parola - "sapere», «essere», «oggetto», «io», «proposizione», «nome» - e tentano di cogliere l’essenza delle cosa ci si deve sempre chiedere: questa parola viene mai effettivamente usata così nel linguaggio, nel quale ha la sua patria?" (oss. 116). Ed il linguaggio di cui qui si parla è naturalmente «il linguaggio di tutti i giorni» (oss. 120).
Si tratta di dichiarazione molto esplicite - ad esse se ne possono aggiungere numerose altre. Ma il modo di intenderle ed anche di praticarle può essere assai diverso ed una formulazione del metodo troppo elementare come è quella che abbiamo proposto in precedenza aprirerebbe la porta a obiezioni giustificate. Resterebbe ad esempio da spiegare perché il linguaggio ordinario debba avere sempre ragione. Per quale motivo al filosofo, e proprio in una concezione tanto aperta, dovrebbe essere precluso di avvalersi di una terminologia propria, fatta talora di neologismi, talaltra di parole tratte dal discorso corrente, ma in accezioni differenti? Perché ne dovrebbero risultare comunque usi falsi, e quindi strani problemi? Questo punto sembra possa essere giustificato solo sulla base dell’assunzione di principio che la filosofia (a parte la nostra) sia una sorta di malattia, di condizione anomala che si innesti come una escrescenza su quella condizione di normalità che sarebbe rappresentata dal senso comune. Seguendo questa via è toccato al pensiero di Wittgenstein l’immeritato destino di essere integrata in quella filosofia del senso comune che ha una sua tradizione nei paesi anglosassoni. In realtà a noi sembra più aderente allo spirito della ricerca di Wittgenstein ed in ogni caso più ricco di interesse un accostamento ad una posizione fenomenologica. Il rimando ai contesti correnti delle parole in un discorso fenomenologicamente orientato appare giustificato non già da qualche privilegio filosofico attribuito in linea di principio al linguaggio quotidiano come tramite del senso comune, ma dall'assunzione che in esso si possa rivelare - attraverso il filtro della riflessione filosofica - il rapporto di esperienza che noi intratteniamo con il mondo. Cosicché negli impieghi correnti può manifestarsi una sorta di concettualizzazione primitiva che ha le sue radici in operazioni, distinzioni, confronti effettuati sul piano stesso dell'esperienza. L'accento può cadere sul lato linguistico per poi scivolare su quello del dato di esperienza. Ed il chiarimento si realizza in una ricerca volta ad individuare il contenuto concettuale mettendo in evidenza le sue condizioni di applicabilità. È difficile trovare in Wittgenstein formulazioni così nettamente orientate in questa direzione; e sul lato fenomenologico non vi è certamente quel sospetto contro il linguaggio dei filosofi che affiora di continuo in Wittgenstein. Ma non vi è dubbio che in molti casi si tratta di posizioni che appaiono particolarmente vicine.
I nostri commenti mostrano quanto sia vasto ed animato il quadro del «metodo» in Wittgenstein. A cominciare dal metodo degli esempi ed alla sottolineatura che in esso non si tratta di un «metodo indiretto di spiegazione»; oppure pensiamo all’invenzione di brevi storie; ai numerosi modi messi in campo per rendere palesi nonsensi occulti; all’impiego del paradosso; alle procedure di «rimpicciolimento», che riportano un problema maiuscolo alle sue proporzioni più minuscole. Ed in questo ambito metodico dovremmo certo annoverare anche i rimandi così consistenti alle situazioni dell’apprendimento, ad una pedagogia immaginaria, ed anche ad un’antropologia immaginaria: alla libera invenzione di usanze possibili, dove la fantasticheria proposta fa parte integrante dell’argomentazione critica che si intende di volta in volta sviluppare.
Un discorso sul metodo in Wittgenstein esibirebbe dunque una notevole varietà di procedure - cosicché al suo centro noi metteremmo la frase:
«Non c’è un metodo della filosofia, ma ci sono metodi; per così dire differenti terapie» (oss. 133).
Naturalmente, un aspetto metodico è inerente anche alla nozione di gioco linguistico, che è il punto di riferimento per le tesi filosofico generali che Wittgenstein fa valere nelle Ricerche filosofiche. Se volgiamo l’attenzione in questa direzione il travisamento implicito nella tesi precedentemente proposta appare con chiarezza anche maggiore. La nozione di gioco linguistico non coincide in alcun modo con quella di linguaggio ordinario. Si tratta invece di una nozione che serve a proporre «un’immagine per la natura del linguaggio» - del linguaggio senza aggettivi. A partire da questa nozione si suggerisce senz’altro una pluralità indefinita di linguaggi possibili. Nello stesso tempo dentro questa prospettiva possiamo ancora parlare del linguaggio al singolare, e forse persino del Linguaggio con la maiuscola, e ad esso ci possiamo riferire ancora come Linguaggio Ordinario. Ma in ciò non è contenuto nessun appello al senso comune. È contenuta invece l’idea semplice secondo cui gli uomini parlano, e il linguaggio in cui parlano rappresenta la base costitutiva della nozione di linguaggio.
Pluralità dei linguaggi e impiego del linguaggio al singolare non sono affatto in contraddizione. In rapporto a questo problema occorre anche sottolineare che l’adozione del punto di vista dei giochi linguistici non suggerisce in alcun modo una contrapposizione tra linguaggio ordinario e linguaggi scientifici nel senso per cui il primo sarebbe il concreto di fronte all’astratto, il vivo rispetto al morto. Certamente Wittgenstein in certo senso difende la «perfezione» del linguaggio di tutti i giorni; più volte ribadisce che il nostro compito non è quello di riformare il linguaggio (oss. 132). Polemicamente egli si chiede una volta: «Questo linguaggio è troppo grossolano, materiale, per quello che vogliamo dire? E allora come si fa a costruirne un altro?» (oss. 120). Ma la critica non riguarda affatto l’invenzione di simbolismi specializzati per particolari discipline scientifiche: si sostiene invece che questi miglioramenti debbono aver le loro precise motivazioni, i loro scopi ben determinati, e non a loro volta essere proposti unicamente sulla base di una presunta imperfezione logica di principio del linguaggio ordinario. Si dice una volta: «Una siffatta riforma volta a determinati scopi pratici, come il miglioramento della nostra terminologia al fine di evitare fraintendimenti nell’uso pratico è pienamente possibile» (oss. 132). Questi «usi pratici» non vanno intesi in un senso banalmente pragmatico. Si può ben trattare della prassi conoscitiva rivolta ad una determinata regione della scienza. In questo caso è necessario che i concetti siano rigorosamente determinati ed è anche giusto che il nostro linguaggio ci appaia realmente troppo «grossolano». Ciò è fuori discussione. Affermare la mobilità dei concetti non vuol dire escludere la possibilità ed anzi la necessità di una loro rigorosa determinazione. Questa rigorosa determinazione apre comunque un nuovo gioco linguistico e dovrà essere a sua volta intesa come una determinazione che riguarda il nostro modo di tracciare i confini per particolari scopi, e non una scoperta di confini che appartengono al concetto in sé e per sé. Dopo la rigorosa determinazione, il concetto può muoversi ancora. Questa condizione di mobilità fa tutt’uno con la possibilità del progresso della scienza, con la sua storicità interna.
Una volta Wittgenstein parla del linguaggio come di una vecchia città. Essa è cresciuta come è cresciuta, e così vi è un «dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi». Ma vi è anche, tutt’intorno, «una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi» (oss. 18).
La «rete dei nuovi sobborghi» allude ai linguaggi della scienza. In essi è intervenuta un’attività organizzatrice e pianificatrice. Ciò a cui credo si debba dare il massimo rilievo è che si tratta di una unica città, e noi viviamo dappertutto in essa, e la possiamo percorrere in lungo e in largo, dal centro sino ai sobborghi più lontani. Questa nostra vecchia città ha una lunga storia, e si svilupperà ancora.
