Materiali di lavoro per un corso di commento alla Ricerche Filosofiche di Wittgenstein tenuto nell'anno 1975. I testi numerati da I a VI si possono ritirare riuniti nell'unico file PDF intitolato "Commenti a Wittgenstein"
Data di immissione in questo archivio: dicembre 2002
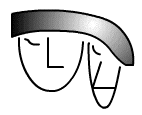
 Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
II.
Torniamo sul terreno scabro!
(Ric. Fil., oss. 43-107)
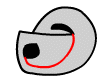
II.1 Che cosa è il significato di una parola
Alla concezione del linguaggio che dà al rapporto tra nome e cosa denominata un’importanza centrale, possiamo contrapporne un’altra che viene sintetizzata così:
«Per una grande classe di casi - anche se non per tutti i casi - in cui ce ne serviamo, la parola ’significato’ si può definire così: ’Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio’. E talvolta il significato di un nome si definisce indicando il suo portatore» (oss. 43).
Questa osservazione può essere considerata un primo importante punto di arrivo. Se dovessimo fornire una rapida formulazione della concezione di Wittgenstein del significato citeremmo proprio questa piccola frase: «il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio». Faremmo inoltre notare la stretta connessione tra questa definizione e l’adozione del punto di vista dei giochi linguistici; ed anche la possibilità di riferirci a giochi linguistici che possiamo liberamente immaginare per operare chiarimenti sui significati delle parole, sui «concetti». La nozione di gioco linguistico rimanda ad un tempo ad una filosofia del linguaggio ed a un metodo di chiarificazione filosofica.
Quella frase tuttavia non deve essere intesa come se proponesse una definizione realmente completa. Vi è infatti quell’inciso -«anche se non per tutti i casi»: forse si allude ancora ai nomi propri? Di fatto il dibattito sulla teoria della denominazione non si è affatto concluso, nonostante il raggiungimento di un punto fermo.
Dobbiamo ripensare ancora alle nostre considerazioni precedenti su etichette e contrassegni. L’impiego di questa immagine suggerisce nuovi problemi. In generale, se debbo apporre una etichetta, allora ci deve essere la cosa su cui l’etichetta deve essere apposta. Sarebbe assurdo ammettere che non esiste l’oggetto designato dal nome proprio; ed inversamente se l’oggetto non esistesse il nome proprio non sarebbe affatto un nome proprio, ma un segno privo di significato. L’immagine dell’etichetta orienta i nostri pensieri in questa direzione.
Si apre allora il problema, che ha tutta una storia prima di Wittgenstein ed anche dopo, una storia che sembra non finire mai, dei nomi propri di oggetti immaginari. La spada di Sigfrido ha un nome proprio: essa si chiama Nothung. Ma siamo certi che essa sia veramente un nome proprio (prescindendo naturalmente dai significati inerenti al suo etimo)? Poiché si tratta di una spada mitica di un personaggio mitico, essa non esiste - e come potremmo su di essa apporre un’etichetta o anche segnarla a dito? Per introdurre questa espressione bisogna ricorrere ad una qualche determinazione attributiva, a ciò che, seguendo una terminologia proposta da Russell, viene di solito chiamata «descrizione». Stando all’immagine del nome come etichetta della cosa, la cosa non solo deve esistere, ma deve poter esistere qui ed ora di fronte a noi. Perciò dovremmo arrivare a dichiarare che non solo «Nothung» ma anche «Socrate» è un nome proprio solo in apparenza, ma non lo è affatto nella sua essenza logica.
Ma una volta che abbiamo imboccato una strada simile dobbiamo seguirla fino in fondo. Di fronte a me vedo Pietro in persona. Ma nulla mi garantisce che Pietro in persona ci sia realmente, perché potrebbe trattarsi del fantasma di Pietro o di una mia allucinazione. Insistendo sull’essenza logica del nome dovremmo forse arrivare ad affermare che l’unico nome proprio corrispondente a quell’essenza sia la paroletta «questo», per indicare qualcosa che mi sta di fronte, sia esso Pietro o il fantasma di Pietro. Il qualcosa indicato dal questo, c’è senz’altro - la condizione per l’apposizione dell’etichetta viene allora rispettata. Il «questo» non può mai essere privo di portatore (oss. 45).
Una simile concezione del nome - che riporta a quella di Russell, ma che ricorda anche in molti punti le tesi che Wittgenstein stesso aveva sostenuto nel Tractatus - viene attaccata con autentica aggressività polemica.
Che «questo» possa essere considerato un nome proprio, anzi il nome proprio per essenza, sembra essere considerato da Wittgenstein poco meno che una che una pura e semplice corbelleria. Egli, così apparentemente propenso ad un atteggiamento elastico nelle distinzioni e nelle classificazioni, oppone a questo proposito una recisa esclusione:
«Chiamiamo nome cose molto differenti: la parola ’nome’ caratterizza molti modi differenti tra loro variamente imparentati di usare una parola; ma tra questi modi d’uso non si trova quello della parola ’questo’» (oss. 38). Il nome proprio viene introdotto grazie al gesto ostensivo accompagnato dalla parola «questo», che fa dunque parte dello stesso gesto ostensivo. E come introdurre allora ostensivamente la parola «questo»? (oss. 38 e 45).
La ragione di una presa di posizione tanto netta sta nel fatto che l’obiettivo polemico oltrepassa il problema relativamente minuto in discussione, per colpire invece l’atteggiamento intellettuale da cui esso sorge: questa strana concezione ha infatti origine da «una tendenza a sublimare, per dire così, la logica del nostro linguaggio» (oss. 38). Si comincia con esempi di nomi propri a tutti familiari. Ma in luogo di avviare una riflessione su una possibile molteplicità del concetto di nome proprio che i differenti esempi che si possono addurre - Pietro, Nothung, Socrate... - sembrano immediatamente suggerire, considerando i giochi linguistici tipici in cui essi si presentano, ci si interroga sull’essenza logica del nome, ammettendone che ve ne sia una ed una sola. La domanda diventa allora: «Che cosa è veramente un nome proprio?». Accezione corrente e accezione logica si contrappongono l’una all’altra. In questa contrapposizione si annuncia una tendenza alla sublimazione che ci allontana dal terreno dei giochi linguistici, per elevarci al di sopra di essi verso la purezza di un pensiero non invischiato nei fatti dell’esperienza.
Si badi tuttavia che per Wittgenstein non c’è da un lato la logica e dall’altro i giochi linguistici, da un lato un uso corrente e dall’altro un uso che non lo è. Ogni uso è corrente entro un gioco linguistico. Dunque anche ciò che accade nella logica deve essere considerato alla luce dell’idea del gioco linguistico.

II.2 - Semplicità e composizione
La spada Nothung ha tuttavia da insegnarci ancora qualcosa. In particolare intorno al tema della semplicità e della composizione. Ecco una variante dell’esempio: Nothung sia una spada reale, proprio di fronte a noi, che ad un certo punto va in pezzi. L’oggetto che il nome designa ora non esiste più - come un intero unitario. Ciò che esiste sono solo le sue parti, ognuna delle quali potrebbe avere un nome. Cosicché Nothung potrebbe essere inteso come nome che «raccoglie» i nomi delle parti e che solo a questi nomi spetta il carattere di nomi propri autentici - con la condizione aggiuntiva che queste parti siano parti ultime, indivisibili. Altrimenti l’argomento può essere ripetuto. In quanto indivisibili, e quindi in quanto oggetti semplici, essi esistono necessariamente. Ogni processo di distruzione può essere inteso come una scomposizione, e palesemente se qualcosa è semplice, non vi sarà nulla da scomporre. Ammesso che esistano oggetti semplici essi saranno indistruttibili (oss. 39) .
Nomi autentici, dal punto di vista logico, saranno dunque solo nomi che designano entità assolutamente semplici. Si ripresenta qui dunque l’idea che vi sia una essenza logica dei nomi, e questa teoria dei nomi come segni di semplici è una variante della precedente che considerava «questo» come unico nome autentico. Ciò che entrambe hanno in comune è naturalmente la richiesta di una garanzia dell’esistenza dell’oggetto che è portatore del nome, garanzia che nel caso precedente aveva una inclinazione soggettiva, implicando un osservatore di fronte ad un oggetto osservato, mentre ora si tenta la via di una argomentazione oggettiva. Argomentazione che peraltro potrebbe non soddisfarci pienamente - e che non soddisfa affatto Wittgenstein, la cui reazione è quasi irritata.
«Ma che faccenda è mai questa dei nomi che designerebbero propriamente il semplice?» (oss. 46).
Questa irritazione si abbatte contro gli individuals di Bertrand Russell ed il suo atomismo logico; ma anche contro l’autore del Tractatus che aveva che aveva sostenuto proprio una teoria dei nomi pienamente riportabile entro questa cornice.
«Questi elementi primi erano anche gli ’individuals’ di Russell, nonché i miei ’oggetti’» (oss. 46)
Nell’oss. 47 ci si diffonde in una critica contro una nozione di semplicità che da un lato sia postulata come una nozione logica e dall’altro proiettata su entità reali. La domanda di quante parti sia composto un tavolo o una sedia è malposta se non è anche indicato un punto di vista da cui possa assumere senso. Per un falegname che deve costruire un tavolo - e che per far questo deve tagliare un unico grosso pezzo di legno - essa è una domanda perfettamente sensata, a cui deve dare una risposta che sia conforme allo scopo. Ciò significa riportare il problema dentro un gioco linguistico. Mentre se pongo la domanda intorno alle parti al di fuori di qualunque gioco linguistico essa è proposta nel vuoto, il suo significato è indeterminato e indeterminata dovrà essere la risposta.
Lo stesso vale per la semplicità e la composizione. In quale gioco linguistico ci disponiamo quando chiediamo se un certo oggetto sia semplice o composto? Se il gioco linguistico non è determinato allora rischiamo di trovarci nella situazione di quel ragazzo che non sapeva decidersi se il verbo «dormire» fosse attivo o passivo (oss. 47). Analogamente un quadrato disegnato sulla lavagna potrebbe essere considerato semplice - ma anche composto di parti: e parti potrebbero essere il perimetro - la linea di gesso - e la superficie nel suo interno. Il perimetro potrebbe essere considerato semplice, oppure si può far notare che esso consta di segmenti, ecc. Un pezzo degli scacchi è sicuramente semplice in quanto pezzo del gioco, perché se lo divido in due non ottengo certo due pezzi del gioco.
Ma vi è un gioco linguistico in cui può valere proprio la teoria dei nomi come segni di semplici? Certamente. Basta inventarlo (oss. 48).
Gli oggetti siano dei quadrati rossi, verdi, bianchi e neri. I nomi siano le lettere alfabetiche R, V, B, N. In base alle considerazioni precedenti potremo intendere i quadrati rossi come oggetti semplici; ed allora le lettere alfabetiche saranno nomi nel senso della teoria sopra esposta. Per di più possiamo intendere una qualunque sequenza di quelle lettere come una descrizione esatta della disposizione dei quadrati, come una «proposizione».
La disposizione dei segni RRN rispecchia la disposizione degli oggetti:

In questo caso la proposizione consta di nomi, e di nomi soltanto, e rappresenta esattamente come stanno le cose nella realtà. Nessun esempio si attaglierebbe meglio alla teoria dei nomi e delle proposizioni proposta da Wittgenstein nel Tractatus. Solo che nulla potrebbe sembrare più stroncatorio del fatto che questo problema, che nel Tractatus aveva la pretesa di spingersi sino alle dimensioni logico-metafisiche del reale, viene ridotto in questo modo alla dimensione minima di un gioco linguistico - verrebbe anzi voglia di dire: di un giochetto - escogitato ad hoc.

II.3 Tabelle e concetti
Alla tematica dei concetti si è già accennato nella discussione intorno ai nomi ed al rapporto di denominazione. L’argomento tuttavia riceve realmente sviluppo solo nel gruppo di osservazioni 50-64. In esse tuttavia questo termine non viene affatto impiegato. Si parla invece di tabelle, campioni, modelli, paradigmi. Per di più attribuendo a queste parole un significato concretissimo. Quando si dice tabella si intende proprio una tabella.
Del resto tabelle e campionari non li incontriamo qui per la prima volta. Si rammenti che cosa fa il fruttivendolo di fronte alla parola «rosso»: «... quindi cerca in una tabella la parola ‘rosso’ e trova, in corrispondenza di essa, un campione di colore...» (oss. 1).
Che cosa sono questi campionari, queste tabelle che ogni tanto qualcuno va misteriosamente consultando?
Chiediamoci allora che cosa accade nella nostra testa quando parliamo di un fiore rosso. Azzardiamo forse un’analisi «introspettiva»? In realtà potremmo limitarci non tanto a cercare sensazioni interne quanto piuttosto a ricorrere ad un’immagine: la nostra testa non potrebbe forse essere assimilata ad una grande stanza nella quale si vanno ad accumulare ogni sorta di oggetti fantomatici? Ed a queste immagini fantomatiche sono in qualche modo collegate le parole. La parola «fiore» ci ricorda cose che abbiamo già visto in passato, e così anche per la qualità visiva indicata dalla parola «rosso». Ciò ci orienta subito verso l’immagine della tabella: è come se fossimo in possesso di un campionario sul quale cerchiamo la parola «fiore» e troviamo accanto ad essa una certa figura; cerchiamo la parola «rosso» e troviamo una striscia colorata. «Si potrebbe dire che qui questa tabella si addossa la parte che in altri casi svolgono la memoria e l’associazione» (oss. 53).
I campioni di colore non sono parole, e quindi forse non fanno parte del linguaggio e tuttavia, in quanto criteri per l’impiego delle parole, possono essere detti strumenti del linguaggio(oss. 16). Essi sono regole per l’uso delle parole, situandosi così su un piano diverso da esso. Cosicché non avrà senso dire di un campione di colore che esso è rosso, così come non ha senso dire del metro campione conservato a Parigi che esso è lungo un metro - o meglio: di questo metro non ha senso né affermare né negare che esso è lungo un metro (oss. 50).
Vi è in realtà qui qualcosa che ci riporta secondo un’angolatura diversa alla tematica della semplicità. Agli elementi semplici di cui si parla nel Teeteto platonico non si può attribuire né l’essere né il non essere. Così si argomenta in Platone: se ha senso dire di un oggetto semplice che è, allora avrà senso dire che non è - mentre sappiamo, almeno secondo la teoria dei nomi come segni di semplici, che l’esistenza è in certo senso un attributo interno dell’oggetto semplice. Qualora il significato del nome venga fatto coincidere con il portatore del nome, allora non ha senso dire che «N non esiste» perché se il portatore del nome non esiste, allora nemmeno il nome ha un significato, e se non ha significato un elemento della proposizione non lo ha la proposizione intera. D’altro lato, in «N esiste», se N ha significato, allora l’esistenza è già posta dal nome e non ha bisogno di essere detta. Essa è inoltre, come già sappiamo una esistenza necessaria - l’oggetto semplice è indistruttibile.
È singolare - ed anche caratteristico dei grovigli in cui Wittgenstein ama trascinare il suo lettore - che considerazioni come queste vengano ora riprospettate proprio nel quadro della tematica del concetto. Ad una tabella, quindi ad un apparato concettuale che si presenta in un certo gioco linguistico dobbiamo attribuire il carattere dell’esistenza necessaria. Del resto l’osservazione sul metro di Parigi di cui non si può né dire né negare che esso sia lungo un metro riecheggia la frase secondo cui di ciò che è semplice non si può dire né che è né che non è.

II.4 - La tabella perduta
Eppure, le tabelle sono certo distruttibili. Il fruttivendolo potrebbe perdere la sua tabella. Se questo avvenisse certe parole non avranno più applicazione entro quel gioco linguistico, oppure alla vecchia tabella se ne dovrà sostituire un’altra. L’apparato concettuale che presiede al gioco linguistico è in movimento.
Poiché abbiamo detto che la tabella «si addossa la parte della memoria», ora diciamo che «se dimentichiamo qual è il colore che ha questo nome, il nome perde il suo significato per noi; vale a dire, con quel nome non possiamo più giocare un determinato gioco linguistico. Ed allora la situazione è paragonabile a quella in cui il paradigma, che era uno strumento del nostro linguaggio, è andato perduto» (oss. 51).
Si presti attenzione a come viene proposto il rapporto tabella/memoria. In precedenza abbiamo proposto la tabella come una sorta di deposito della memoria. Ma in questa immagine vogliamo giocarci dentro. La tabella è ora qualcosa che attualmente consultiamo, una tabella reale appunto che sta di fronte ai nostri occhi. E la memoria invece è nella nostra testa con tutti i suoi ricordi. Guardiamo la tabella e nello stesso tempo ricordiamo - si tratta degli oggetti fantomatici che stanno nella nostra testa, di immagini mentali: anche in questo caso accettiamo di scivolare un poco secondo un’inclinazione psicologistica.
Può accadere allora che in determinate circostanze si possa dire: ora il modello «ha cambiato colore» - ad esempio può essere ipotizzato come spiegazione una reazione chimica avvenuta a nostra insaputa. Qui la memoria giudica il modello (oss. 56). Il commento di Wittgenstein è: «Se non avessimo memoria saremmo alla mercé di un modello» (oss. 56). Il problema è che non vi è un criterio valido per stabilire se «il nostro ricordo del colore è esatto». Cosicché Wittgenstein vuol proprio dire che «siamo alla mercé di un modello». Di fronte ad un campione di colore che ci appare diverso, dovremmo forse assumere che in realtà il colore è rimasto lo stesso, giudicando così la memoria attraverso il modello.
Il modello sta prima della memoria e la giudica - la via psicologistica seguita a modo di prova tende ad autosopprimersi. Il rinvio ad immagini mentali rafforza infatti il carattere paradigmatico dell’apparato concettuale e nello stesso tempo l’idea della mobilità dei paradigmi. Nello stesso tempo avvertiamo ancora quell’inclinazione scettica di molte argomentazioni di Wittgenstein e che anche in questo caso è in realtà solo apparente.

II.5 - Una scopa nell'angolo
Il rovello della semplicità e della composizione arriva a toccare anche il tema della analisi della proposizione.
Se assumiamo che il linguaggio sia uno specchio della realtà, sembrerebbe abbastanza ovvio che ciò che si può dire intorno a qualcosa di composto possa essere detto facendo riferimento alle sue parti. Dunque invece di dire «Portami una scopa», dirò «portami il manico e la spazzola in esso infissa». Molti commentatori discutono in tutta serietà questa osservazione - che d’altronde annuncia un problema molto serio - senza mettere in rilievo che l’esempio è volutamente deprimente, in certo senso: bassamente quotidiano. Ad essi sfugge che Wittgenstein sta ironizzando sulla «tendenza alla sublimazione» - e che cosa vi di più antisublime di una scopa che se ne sta in un angolo?
E non basta: poiché nella seconda formulazione si parla delle parti di cui è composto l’oggetto di cui si parla nella prima formulazione, qualcuno potrebbe pretendere che quella sia una analisi di questa. Qui evidentemente Wittgenstein porta a conseguenze palesemente grossolane l’idea che l’espressione linguistica non faccia altro che rispecchiare la natura degli oggetti; e nello stesso tempo che vi sia una forma superficiale della proposizione che sarà per principio non analizzata in quanto presenterebbe la realtà nelle sue mere apparenze, e ad essa si debba contrapporre una forma profonda e nascosta che la seconda formulazione farebbe emergere, tanto più se fossimo in grado di analizzare manici e spazzole sino ai sospirati e pretesi atomi logici. La proposizione interamente analizzata dovrebbe constare di parole riferite esclusivamente a oggetti semplici. E se raggiungessimo un livello tanto profondo stringeremmo in pugno la proposizione nella sua essenza logica.
Ormai non è più il caso di avviare una confutazione, ma si può approfittare dell’esempio per dare una svolta alla nostra discussione e portarla anzi ad una sorta di punto culminante. Anzitutto mettiamo in azione il punto di vista dei giochi linguistici. Potremmo prendere per buone l’una e l’altra formulazione e proporle in giochi linguistici differenti. Nell’uno compare il termine di «scopa», nell’altro «manico» e «spazzola» - e l’uno funziona forse altrettanto quanto l’altro, genera nel mio interlocutore le stesse reazioni comportamentali (forse...). Ma con quale diritto potremmo assumere che vi sia tra essi una sorta di gerarchia, che l’uno sia può fondamentale dell’altro? A partire da questa domanda ci possiamo liberare dai vincoli dell’esempio e prospettare nuove domande, che finora non erano mai state poste: vi sono relazioni tra i giochi linguistici? Vi è tra essi qualcosa di simile ad un ordinamento gerarchico? E soprattutto: vi è un gioco linguistico che sta alla base di tutti i giochi linguistici?

II.6 - Una grossa questione
L’oss. 65 si apre così: «Qui ci imbattiamo in una grossa questione che sta dietro tutte queste considerazioni».
Tutte le discussioni precedenti sono nettamente distaccate da un simile inizio che propone di mettere finalmente in chiaro un presupposto ad esse soggiacente e che fino a questo punto non era stato ancora messo a fuoco. In effetti le osservazioni che seguono hanno un’importanza centrale per la comprensione di quanto precede, ma anche per le Ricerche filosofiche nel loro complesso. Per ciò che riguarda un’interpretazione ed una valutazione complessiva dell’opera molto dipende da queste pagine, dal capitolo che potremmo fare iniziare con l’oss. 65 e far concludere con l’oss. 78.
È anzitutto opportuno riprendere il tema del concetto con alcune considerazioni di carattere generale. Quando operiamo l’attribuzione di una qualunque proprietà ad un oggetto - ad esempio quando diciamo che esso è rosso, possiamo intendere questa attribuzione come una classificazione dell’oggetto stesso, come una sorta di aggregazione ideale ad una determinata classe. Parlo di aggregazione ideale perché evidentemente non si tratta di disporre l’oggetto concreto in un insieme di oggetti che si trovano concretamente di fronte a me. Inoltre, ai fini di questa aggregazione non basta la percezione di un oggetto rosso, occorre il pensiero che gli attribuisce questa proprietà, ovvero il giudizio come formazione linguistica «La tal cosa è rossa». Il giudizio stesso può dunque essere inteso come una operazione di classificazione. Vi è una classe di cose che hanno una caratteristica comune - esse sono tutte rosse. Ciò che esse hanno in comune è appunto il rosso. Il nesso predicativo può dunque essere inteso come un rapporto di sussunzione di un oggetto sotto un concetto - e potremmo chiamare estensione di un concetto l’insieme degli oggetti sussunti sotto di esso. L’insieme degli oggetti rossi formano l’estensione del concetto «il rosso».
Tenendo conto del riferimento al giudizio, si può allora intendere come espressione di un concetto la forma «x è rosso», intendendo la x come una variabile nominale, cioè come una variabile che può essere sostituita da segni di oggetti (nomi). Operando la sostituzione della variabile con nomi, otterremo allora proposizioni che saranno vere oppure false. Cosicché possiamo dire che l’estensione del concetto è descritta da tutti quegli oggetti che rendono vera la formula in questione, una volta operate le sostituzioni necessarie.
Questo è un modo un poco più complicato per dire che all’estensione del concetto «il rosso» appartengono tutte le cose rosse. Ma questa complicazione è tuttavia utile per arrivare ad un punto che ci interessa in modo particolare. Risulta infatti chiaro, ponendo le cose in questo modo, che ogni formula funzionale del tipo «x è rosso» ovvero f(x) traccia in certo senso una precisa linea di demarcazione nel variopinto mondo degli oggetti. Queste linee possono variamente intersecarsi, ma solo nel senso che un oggetto può appartenere all’estensione di più concetti. Esso può essere ad esempio rosso e sferico. Ma ogni linea descrive un’area nettamente circoscritta.
Naturalmente possono esserci predicati relativamente indeterminati. In tal caso dobbiamo metterli fuori gioco, in qualche modo vietarne l’uso. Infatti non sapremmo che farcene. Che il predicato sia indeterminato significa infatti che dato un certo oggetto non sapremmo decidere se ad esso sia o non sia attribuibile quel predicato. Il predicato deve essere tale che dato un qualsiasi oggetto a si debba poter decidere se una certa proprietà p gli spetta o non gli spetta, ovvero se la proposizione «a è p» sia vera oppure falsa. Se ciò non accade, ci troveremmo nella stessa situazione in cui ci troveremmo se ignorassimo il significato della parola predicativa in questione. La proposizione potrebbe essere allora ritenuta priva di senso.
Richiediamo dunque che i nostri predicati (concetti) siano esattamente determinati, che essi descrivano un’area e che questa area sia «chiaramente delimitata» - secondo un’immagine che Wittgernstein riprende da Frege (oss. 71) - perché «un’area non chiaramente delimitata non può nemmeno chiamarsi un’area». E questo requisito sembra ovvio e naturale nella misura in cui abbiamo a cuore la razionalità dei nostri discorsi: essa richiede (a quanto sembra) che si possano dare risposte rigorosamente determinate al si ed al no alle nostre domande; richiede che si dia un ordine, e l’ordine comincia là dove tracciamo chiare linee di separazione, dove possiamo chiaramente separare e chiaramente dividere, e dunque classificare, altrimenti tutto precipita nella massima confusione.
La «grossa questione» che deve essere finalmente portata alla luce riguarda proprio è una critica di principio contro questo modo di presentare le cose, contro questo concetto del concetto, e quindi anche contro l’immagine della razionalità che è qui implicata.
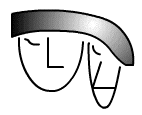
II. 7 - Somiglianze di famiglia
Questa critica comincia con il mettere in questione la rigorosità della nozione di gioco linguistico, quindi il possesso da parte di questo concetto di quei requisiti che ogni concetto autentico deve possedere. L’interlocutore immaginario di Wittgenstein avanza a questo punto la sua protesta: te la fai facile! Fai un gran parlare di giochi linguistici e non ci hai ancora detto che cosa ci consente di affermare che qualcosa sia o non sia un gioco linguistico. Non hai fatto altro che indicare alcuni esempi. Ma non puoi pensare di cavartela in un modo così indiretto ed impreciso. I concetti debbono essere rigorosamente introdotti e rigorosamente determinati. Da questa tua introduzione esemplificativa ogni cosa viene lasciata nel vago. E tutto il tuo gran parlare di giochi linguistici si riduce a pura chiacchiera se non ti decidi a dare di essi una definizione rigorosa.
A queste obiezioni si risponde attaccando alla radice il modo di pensare che sta alla base di questa richiesta.
Quando usiamo una parola può essere che indichiamo cose anche molto differenti che non hanno propriamente qualcosa in comune, ma che sono variamente imparentate l’una con l’altra.
E proprio la parola «gioco» si presta a meraviglia a illustrare questa situazione. Dovremmo forse dire che «deve esserci qualcosa di comuni a tutti i giochi altrimenti non si chiamerebbero giochi» (oss. 66). Ebbene, se dici questo stai argomentando, ed invece di argomentare che deve esserci qualcosa di comune a tutti guarda se c’è.
«Non pensare, ma guarda» (oss. 66)
«Denk nicht, sondern schau!»
È difficile trovare una formulazione più dura di contrapposizione tra il «pensiero» e l’«intuizione»! Ma questa formulazione ha un contenuto ed un obiettivo polemico assai preciso.
Guardando i giochi non è certo facile cogliere qualcosa che sia realmente comune a tutti e che quindi corrisponda all’essenza del gioco che giustifichi dunque l’applicazione del nome comune.
Non sarebbe difficile svolgere le osservazioni di Wittgernstein in un dialogo in stile platonico: la forma dialogica c’è già. Tuttavia il Socrate wittgensteiniano nei suoi inseguimenti dell’interlocutore, nel suo premerlo da vicino per metterlo con le spalle al muro, mirerebbe forse ad uno scopo ben diverso dal Socrate platonico. Il Socrate platonico porta ad oscurare, nella dialettica del dialogo, distinzioni che all’inizio erano chiare, ma infine è nelle intenzioni platoniche l’affermazione recisa dell’esistenza di un’identità ideale ed assoluta che traluce attraverso la molteplicità dei casi empirici. Wittgenstein mira invece a dissolvere questo nucleo concettuale. Ogni identificazione di ciò che sarebbe comune a tutti i giochi viene contrastata attraverso contrapposizioni significative. Se dici che è essenziale al gioco il divertimento, citerei casi in cui parleresti di giochi esitando tuttavia a caratterizzarli come divertenti. È divertente del resto il gioco degli scacchi? O la roulette russa? Se dici che è essenziale al gioco il vincere o il perdere, non è certo difficile citare giochi in cui la competizione non ha nessuna parte. E così via.
Ciò che invece si può ammettere è che tra un gioco e l’altro vi siano somiglianze, e che ciò che ci induce a chiamare cose tanto disparate «giochi» sia «una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono ed incrociano a vicenda» (oss. 66).
Naturalmente si tratta di qualcosa di totalmente diverso che ammettere «qualcosa di comune» nel senso che abbiamo precedentemente illustrato. Si tratta appunto di una «rete», di un «complicato intreccio», di sovrapposizioni e di fusioni. Di aspetti che si richiamano l’un l’altro. Forse potremmo dire: la somiglianza di cui si parla è una somiglianza sfuggente. Per questo Wittgenstein per illustrare il modo in cui si parla qui di somiglianza ricorre alle «somiglianze di famiglia» (Familienänlichkeiten) (oss. 67). Anche se talora possiamo dire che cosa nel figlio sia esattamente simile al padre o alla madre, non è in rapporto a questi «pezzi» - il naso, il mento o il sopracciglio - che si parla di solito di somiglianza di famiglia: si tratta piuttosto di un’aria di famiglia che manifesta l’appartenenza ad essa attraverso somiglianze sfuggenti.
I giochi formano una famiglia - essi sono processi variamente imparentati tra loro.
E certamente qui si tratta di ben altro che di rivendicare la plasticità o addirittura la vaghezza del linguaggio corrente, magari addirittura riproponendo di fronte a questa vaghezza il rigore di una «autentica» determinazione concettuale. Si tratta invece, di fronte ad una concezione dove sono importanti le linee di demarcazione e le aree dai contorni chiaramente fissati, di far valere le somiglianze sfuggenti ed i contorni sfumati non già come limiti, ma come caratteri da rivendicare all’interno di una corretta teoria del concetto. L’impegno di una simile presa di posizione lo si comprende meglio non appena dall’esempio del gioco, che potrebbe essere di assai poco peso, mostriamo di voler spericolatamente portare simili considerazioni all’interno di mondi per i quali sembra che debba valere obbligatoriamente proprio l’esatta determinazione dei contorni. I giochi formano una famiglia - e così anche i numeri.
«Perché chiamiamo una certa cosa ‘numero’? Forse perché ha diretta parentela con qualcosa che finora si è chiamato numero» (oss. 67).
Finora. Finora si sono chiamati numeri i numeri naturali, poi si chiama numero addirittura lo zero, e poi si introducono i numeri negativi - numeri così finora ci erano del tutto ignoti - e poi ancora i numeri immaginari, i numeri transfiniti... Nuovi tipi di numeri che vengono associati alla famiglia dei numeri che si va progressivamente allargando. Fra tutti vi è un’aria di famiglia - ed è per questo che li chiamiamo «numeri». Se prima si disponeva di una definizione che circoscriveva esattamente un’area, ora può essere che si ponga il problema di una nuova definizione. Questa è una preoccupazione che può subentrare in un secondo tempo.
Anche nel modo in cui si discute questa «grossa questione» si comprende che nulla sarebbe più fuorviante che far di Wittgenstein un «filosofo del linguaggio ordinario», come se l’unica sua preoccupazione fosse quella di enfatizzare il linguaggio ordinario o addirittura difendere l’approssimazione contro il rigore e l’esattezza. Non solo in Wittgenstein non si esclude affatto che si possano dare definizioni rigide o determinazioni rigorose dei concetti, ma si afferma che anche che, secondo le circostanze, lo si deve.
Tutto dipende dallo scopo che si persegue. Ciò che non va nella richiesta di determinazioni rigorose è che essa sia posta nel vuoto, in una forma assoluta: o vi è una determinazione rigorosa oppure tutto precipita nella massima confusione. Intanto potremmo sviluppare il nostro tema parlando di somiglianze sfuggenti. Poi per scopi particolari potremmo porci il problema di determinare rigorosamente una nozione - e per scopi particolari potremmo anche evitare di farlo.
Nel caso della nozione di gioco, nella misura in cui ci serve per illustrare una concezione del linguaggio, ci serve proprio il mantenere aperto il concetto. Se lo chiudessimo - come potremmo anche fare introducendo restrizioni nell’impiego del termine - ci rimetteremmo qualcosa. Perciò introduciamo la nozione di gioco mediante esempi e poi diciamo: «queste, e simili cose, si chiamano giochi» (oss. 69). Ed ancora: «Si dànno esempi e si vuole che vengano compresi in un certo senso» (oss. 71). Occorre poi mettere in evidenza che non abbiamo nessun diritto di indicare questa introduzione esemplificativa come un modo intuitivo, nel senso di «vago» ed «approssimativo» in cui talora viene usato questo termine, quasi che questa introduzione fosse una sorta di preparazione preliminare a cui dovrà seguire una determinazione rigorosa.
L’apertura del concetto non deve essere confusa con la sua vaghezza: qualcosa è infatti vago relativamente al problema di una determinazione rigorosa. Più chiaramente: solo nella misura in cui, per scopi particolari, esigiamo determinazioni rigorose diciamo che un certo modo di procedere è vago ed approssimativo. Inoltre nulla giustificherebbe l’idea che una nozione che non sia rigorosamente determinata sia per ciò stesso inutilizzabile (oss. 69). Ciò potrebbe essere sostenuto sulla base di un pregiudizio in cui la richiesta di una esatta determinazione venga avanzata prescindendo dai contesti e dagli scopi che vengono perseguiti.
Vi è stretta coerenza tra questa «teoria del concetto» e il «metodo degli esempi» - ed in generale con l’intero modo di procedere che Wittgenstein pone in atto nelle Ricerche filosofiche. Il metodo degli esempi è a sua volta un metodo «ostensivo», Esso mette in questione il mostrare, più che il dire. Ed è importante che si sottolinei: «Qui l’esemplificare non è un metodo indiretto di spiegazione - in mancanza di un metodo migliore» (oss. 71). Non ci sono due livelli, l’uno «intuitivo» in cui diciamo le cose alla buona, scusandoci di continuo con l’ascoltatore, ed uno esatto, rigoroso in cui riesponiamo le cose nell’unico modo legittimo. Ma il procedere attraverso esempi non potrebbe forse mettere il nostro interlocutore in una situazione di incertezza imbarazzante? Ciò può anche accadere. Forse di fronte a quel «e simili cose» che fa parte della «definizione ostensiva», egli si immagina una sconfinata pianura in cui l’occhio si perde. Oppure può incorrere in fraintendimenti.
«Qualcuno mi dice: ‘Insegna un gioco al bambino!’. Io gli insegno a giocare di denaro ai dati e l’altro mi dice: ‘Non intendevo un gioco del genere!’» (oss. 70).
Nell’accettare il metodo degli esempi, ed in genere in ogni azione del mostrare, dobbiamo accettare di poter essere fraintesi. Ciò fa parte del problema. Se dico «Portami questo» e mostro una foglia di quercia, forse 1. - il mio interlocutore cercherà di strapparmi di mano la foglia (o se ne starà lì imbarazzato) 2. - oppure mi porterà una foglia di quercia; 3. - oppure ancora mi porterà una foglia qualunque. La foglia che mostro assolve funzioni differenti (come strumento del linguaggio). Nel secondo e terzo caso in modi diversi svolge la parte del «campione». Nel primo vale per se stessa. Del resto non vi è motivo, e forse non è nemmeno possibile, garantirsi da ogni possibile fraintendimento. Vi sono fraintendimenti che potremmo non aver affatto previsto. Ed in ogni caso il fraintendimento avviene, per così dire, uno alla volta, e presumibilmente saremo sempre in grado di porre riparo a quel fraintendimento.

II.8 - Dubbi irragionevoli
Il tema del fraintendimento si ripresenta nel momento in cui si ripropone la discussione del rapporto tra nome proprio e descrizione (oss. 79-88) a cui abbiamo accennato in precedenza. Il nome proprio Mosé non può essere introdotto ostensivamente. Mosé è morto da gran pezzo. Per introdurlo dovremo dunque ricorrere ad una descrizione - ad una frase del tipo «L’uomo che ha condotto gli ebrei attraverso il deserto». I problemi che sono sorgono a questo punto sono accennati da Wittgenstein in una forma nella quale è impossibile non scorgere una forte accentuazione ironica. È singolare quanto poco gli interpreti abbiano notato la presenza di una vena ironica nelle osservazioni di Wittgenstein. L’ironia è diretta soprattutto a Bertrand Russell ed al suo parlare di «nomi propri autentici» fra i quali Mosé non può essere annoverato. Ma l’ironia è rivolta anche a tutti coloro che in un modo o nell’altro ingigantiscono problemi come questi, per ragioni del resto dipendenti da un orientamento intellettuale complessivo.
Mosé, dunque... ma che cosa accade se colui che condusse gli Ebrei nel deserto non fosse stato affatto Mosé? E come la mettiamo con il fatto che, in ogni caso, le descrizioni che potrei dare come «spiegazioni» del significato di Mosé sono comunque infinite in linea di principio? Dicendo Mosé intendo una determinata descrizione o tutte le infinite descrizioni possibili? Wittgenstein affastella domande come queste e la conclusione corrisponde ad una provocazione: se al nome di Mosé associassimo ora una descrizione ora un’altra, potremmo ammettere pacificamene che il significato della parola non è affatto fisso, anche se viene inteso comunque sempre Mosé. Potremmo peraltro concedere al nostro interlocutore che non conosciamo affatto il significato autentico della parola «Mosé», e che in effetti parliamo «insensatamente»...
«Di’ quello che vuoi, basta che ciò non ti impedisca di vedere come stanno le cose. (E quando l’avrai visto, ci saranno cose che non dirai più)» (oss. 79).
Di fronte ad un’ostinazione argomentativa che si fa vanto della propria cecità, non resta che invitare a togliersi la benda dagli occhi, sottraendosi al gioco degli argomenti e dei controargomenti. Ma la risposta vera, e profondamente ricca di senso, è che ogni interrogativo deve essere posto in un contesto determinato. Ed è in un contesto determinato, in rapporto a questioni particolari determinatamente indicabili che può sorgere il dubbio se la parola Mosé designi realmente qualcuno; oppure se una descrizione possa valere come un accettabile «riempimento» del suo significato. Si tratta di interrogativi che sorgono di fronte a fraintendimenti in un momento ed in una situazione determinata. Potremmo dire in modo molto concreto: mentre sto dialogando con qualcuno. Il fraintendimento potrà allora essere eliminato con particolari accorgimenti che sono strettamente subordinati al contesto dialogico, alle informazioni di cui io dispongo e di cui dispone eventualmente il mio interlocutore. Può così intervenire una spiegazione che risolve il fraintendimento - tanto particolare come è il fraintendimento stesso, ed essa stessa come una spiegazione data al momento. In nessun caso possiamo pretendere di liberarci una volta per tutte e in un colpo solo da ogni possibile fraintendimento. Una simile pretesa non è altro che la forma in cui si ripresenta il mito delle spiegazioni ultime.
«Una spiegazione può bensì poggiare su un’altra spiegazione già data, ma nessuna spiegazione ha bisogno di un’altra - a meno che ne abbiamo bisogno noi per evitare un fraintendimento. Si potrebbe dire: una spiegazione serve a eliminare o a prevenire un fraintendimento, dunque un fraintendimento che potrebbe sopravvenire in assenza della spiegazione; non ogni fraintendimento che io possa immaginare» (oss. 87).
In stretta connessione con ciò si rifiuta qualunque forma di iperbole del dubbio: come quando si propone di dubitare di ogni cosa per la quale il dubbio sia in generale possibile. Un simile dubbio iperbolico è profondamente irragionevole. È un dubbio che si pretende al di fuori di qualunque gioco, un dubbio nel vuoto. È giusto invece dubitare - e normalmente si dubita così - quando, nelle circostanze date, vi sono motivi per farlo. Come viene rifiutato un dubbio iperbolico, così viene rifiutata la ricerca di una certezza iperbolica - del resto i due problemi nascono insieme nella filosofia di Cartesio.
Peraltro il fraintendimento può annidarsi ovunque: a partire, come sappiamo, dalle stesse designazioni ostensive che non sono affatto così certe come talora si pretende, fino alla formulazione delle regole - formulazione che va interpretata e può essere soggetta a interpretazioni differenti. Nell’oss. 86 si riformula il gioco linguistico del muratore, introducendo una variante. La comunicazione avviene per iscritto, e ogni attore cerca la parola scritta su una tabella che indica in figura il corrispondente oggettivo. Alla tabella è acclusa una tabella che contiene uno schema per l’uso della prima tabella. Ad esempio, essa presenterà delle frecce orizzontali che hanno il compito di mostrare in che modo debbano essere coordinate la parola scritta e la figura della cosa:

Con ciò la difficoltà diventa subito evidente.
La tabella è un insieme di regole. Essa insegna infatti ad associare un certo segno grafico con un disegno che a sua volta rinvia ad un oggetto - insegna dunque ad associare un segno ad un oggetto. Si dà così forma concreta ad un processo mentale. Ma chi ci insegnerà ad usare la tabella e in che modo in generale è possibile insegnare ad usare una tabella? Sembra necessario ricorrere ad un’altra tabella per l’uso della prima - una regola per l’uso delle regole. Ecco allora la tabella delle frecce. Ma allora non ci vorrà forse un’altra regola che ci insegni ad usare questa regola per l’uso delle regole?
«Non potremmo immaginare ulteriori regole, intese a chiarire questa? E d’altro canto era incompleta quella prima tabella senza lo schema delle frecce?» (oss. 86).
Si riconoscerà qui un vecchio problema che Wittgenstein aveva già posto nel Tractatus. Noi possiamo ed anzi dobbiamo distinguere tra linguaggio e metalinguaggio - ma la distinzione in ultima analisi determinante resta quella tra un livello generalmente linguistico a cui appartengono linguaggi e metalinguaggi ed un livello extralinguistico che nel Tractatus si presenta come distinzione tra dire e mostrare e che continua a restare al centro dell’impostazione delle Ricerche Filosofiche sotto la forma della problematica dell’insegnamento ostensivo. Come deve essere usata la tabella deve essere infine mostrato. Ed in ogni caso è possibile una molteplicità di interpretazioni, così come è possibile ogni fraintendimento.
Occorre ribadire: tutto ciò non deve essere inteso come una sorta di equivoca apologia dell’indeterminatezza e della vaghezza, ma come la critica - in certi punti aspramente polemica e qui e là punteggiata da intonazioni scettiche - contro l’ideologia della perfetta e compiuta determinatezza. Non si nega che vi siano calcoli «condotti secondo regole fisse». Simili calcoli li troviamo nella logica insegnata a scuola. Possiamo anche confrontare il nostro «uso delle parole», il nostro modo di operare con le proposizioni, con questi calcoli. Peraltro anche questo confronto dovrà essere motivato da qualche scopo particolare. L’errore sarebbe quello di dare per scontato il senso di questo rapporto come se nella logica si parlasse di un linguaggio ideale, rispetto al quale il nostro linguaggio si approssima più o meno incertamente. Se parliamo di linguaggi ideali, per i linguaggi «condotti secondo regole fisse» che siamo in grado di costruire, questa espressione non sottintende che questi linguaggi siano «migliori, più completi del nostro linguaggio quotidiano» (oss. 81). «Come se vi fosse bisogno del logico per rivelare finalmente agli uomini che aspetto ha una proposizione corretta» (ivi).

II.9 -Torniamo sul terreno scabro!
Il gruppo di osservazioni 89-107 potrebbe ricevere titolo dalla domanda con la quale si apre l’oss. 89: «In che senso la logica è qualcosa di sublime?».
Sappiamo già che la domanda intende essenzialmente proporre il suo rovescio. La logica non è in nessun modo e sotto nessun punto di vista «qualcosa di sublime». La logica parla di proposizioni, di mondo, di regole, ecc. Ed anche qui, nella logica, l’impiego di queste parole «deve essere terra terra, come quello delle parole ’tavolo’, ’lampada’, ’porta’» (oss. 97).
Sappiamo anche che questa «sublimazione» contro cui si intende ora reagire è esemplarmente presente nel Tractatus e qui e là, nelle Ricerche filosofiche, non mancano esplicite autocritiche (oss. 23 ed oss. 46). «Anche a me» è successo di pensare erroneamente che «chi pronuncia una proposizione e la intende o la comprende sta eseguendo un calcolo secondo regole ben definite» (oss. 81). Questi espliciti cenni autocritici non vanno certamente perduti di vista, così come sarebbe palesemente riduttivo riportare le critiche e le nuove opinioni esposte nelle Ricerche Filosofiche ad una vicenda intellettuale personale. La «sublimazione» della logica rappresenta uno dei tratti caratteristici (ed importanti!) dell’atteggiamento intellettuale novecentesco, e tanto più significativo è il fatto che questa erosione critica possa avvenire dal suo interno.
Ma in che modo si potrebbe sostenere che la logica è «qualcosa di sublime»?
La logica «indaga l’essenza di tutte le cose»; non si occupa della superficie, ma della loro dimensione profonda. Così essa non si può contentare delle proposizioni così come ci si presentano nei loro impieghi correnti e nelle loro accidentalità estrinseche, ma va a ricercare le necessità essenziali e permanenti. Come logici ci proponiamo di indagare sulle strutture profonde - di compiere una «analisi della proposizione» che renda visibile la sua autentica ossatura logica.
Peraltro anche noi come filosofi dobbiamo imparare ad «analizzare le proposizioni» (oss. 89-90). Ad esempio, Agostino si pone il problema di un chiarimento della nozione di tempo. E la frase famosa con cui si aprono le sue riflessioni («Che cosa è il tempo? Quando nessuno me lo chiede lo so: quando voglio spiegarlo a qualcuno che me lo chiede, non lo so») denuncia già che non si tratta di una richiesta di spiegazioni che debbono essere attinte pronte chissà dove, ma che è necessario per questo mettere in moto la forza della riflessione. La nostra testa si confonde di fronte alla domanda. Eppure, che cosa sia il tempo, lo sappiamo. Dobbiamo riflettere per dipanare la confusione, e questo riflettere è qualcosa di simile ad una richiamare alla mente, ad un ricordare qualcosa si è dimenticato. L’idea platonica della conoscenza come rimemorazione riceve un accento particolare in Wittgenstein: ciò che deve essere richiamato alla mente è «il tipo di enunciati che facciamo intorno ai fenomeni», quindi nel caso di Agostino «gli enunciati che noi facciamo intorno alla durata degli eventi, al loro passato, presente e futuro» (oss. 90).
La ricerca filosofica è dunque una ricerca «grammaticale» - in un senso ampio. Anche il filosofo deve compiere una «analisi delle proposizioni» chiarendo le interne e possibili ambivalenze di senso ed i percorsi intellettuali che si compiono in esse.
Ma certamente un conto è l’analisi della proposizione così concepita, che in certo modo rinnova la maieutica socratica, ed un altro è il proporre la questione dell’analisi come se essa dovesse portare alla luce una struttura logica che se ne sta profondamente nascosta (oss. 91). L’eliminazione dei fraintendimenti si situa allora all’interno di una tendenza alla «completa esattezza» (oss. 91) e di fa avanti l’idea di un linguaggio essenziale, compiuto, perfetto - ovunque delimitato da regole, determinato una volta per tutte, chiuso e senza lacune. La tendenza alla sublimazione si volgerà allora in ogni direzione: una proposizione, che è la cosa più comune del mondo, diventa qualcosa di molto singolare, di enigmatico, qualcosa che cela profondità abissali (oss. 93-97). Si impone l’idea di ordinamenti e di regole ideali che aspirano a diventare superordini, superregole. Si pretende che di una parola il cui senso non sia perfettamente determinato non si può fare proprio nulla - così come non si è fatto nulla se dovendo chiudere un uomo in una stanza, si lascia aperto soltanto una porta. Wittgenstein protesta proprio contro tutto ciò: un recinto che abbia un buco è ancora un recinto (oss. 99). Il che non vuol dire che ci dobbiamo contentare di recinti «imperfetti». Se ci esprimessimo in questo modo resterebbe normativa ancora l’idea di una esattezza ideale. Mentre una simile esattezza è prospettata nel vuoto. Ancora una volta bisogna ripetere che qualcosa sarà detto più o meno esatto in vista di scopi particolari. In assenza di ciò tutte le istanze che puntano ad una «cristallina purezza» entreranno in un conflitto intollerabile con il mondo di esperienza con cui abbiamo quotidianamente a che fare.
Questa meditazione si conclude con un’immagine che ha il senso di una sorta di parola d’ordine per l’idea filosofia del secondo Wittgenstein:
«Siamo giunti su una lastra di ghiaccio dove manca l’attrito, e perciò le condizioni sono in certo senso ideali, ma appunto per questo non possiamo muoverci. Vogliamo camminare; dunque abbiamo bisogno dell’attrito. Torniamo sul terreno scabro!» (oss. 197)
