
![]() La notte dei lampi - Parte III (553.55 kB)
La notte dei lampi - Parte III (553.55 kB)
I. Introduzione: idea della materia

1. Intorno alla costituzione della cosa materiale
In modo particolare, il riferimento al colore si presta addirittura ad un’introduzione concisa della stessa nozione generale di fenomenologia, proprio perché i colori hanno assolto il compito di illustrare esemplarmente la classica distinzione filosofica tra qualità primarie e qualità secondarie.
Chiunque voglia afferrare il primo nodo di un’impostazione fenomenologica, evitando lunghi e tortuosi cammini, potrà certamente anzitutto prendere le mosse di qui, dalla distinzione tra proprietà che spettano alle cose considerate in se stesse, indipendentemente dalle condizioni soggettive della loro apprensione percettiva, e proprietà che invece sorgerebbero unicamente all’interno del rapporto istituito dall’esperienza, e che si contrappongono dunque alle precedenti come l’apparente al reale, come ciò che è essenzialmente soggettivo a ciò che è invece essenzialmente oggettivo.Il colore potrà allora essere rammentato, nelle sue relatività dipendenti dalle circostanze e dalle condizioni dell’osservazione, come esempio presuntivamente evidente di qualità secondaria;in opposizione, eventualmente, alla forma, a cui il richiamo implicito alla oggettività geometrica sembra, con altrettanta presuntiva evidenza, conferire senz’altro il carattere di qualità primaria.
Contro di ciò si fa valere invece una critica che contiene il nucleo dell’impostazione fenomenologica: stando alle apparenze percettive, quella distinzione risulta del tutto infondata e gli esempi si ritorcono contro di essa, potendosi rilevare, all’interno della stessa apprensione percettiva, l’attribuzione del colore come proprietà inerente alla cosa al di là e attraverso le relatività dei suoi modi di manifestazione; nello stesso modo in cui la forma della cosa si offre nella sua identità in una continua variabilità di adombramenti prospettici.
Con questa critica si opera la prima rivendicazione fondamentale per l’acquisizione di un punto di vista fenomenologico, la rivendicazione cioè del diritto, da sempre esercitato dagli usi linguistici correnti, di giocare la contrapposizione tra il reale e l’apparente in primo luogo all’interno dello spazio dei fenomeni.
Ma questa prima rivendicazione che, a partire da un’enunciazione così generale, trae il suo interesse essenzialmente dalle sue possibili specificazioni sulle datità concrete dell’esperienza, è subito accompagnata dal riconoscimento di un limite di principio: se andiamo alla ricerca di spiegazioni autentiche, ben presto dovremo accedere al terreno della transfenomenologia. La distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie, liberata dalla equivocità degli esempi e dalle oscurità teoretiche delle sue formulazioni tradizionali, contiene nel suo nucleo valido la distinzione tra due orientamenti nettamente diversi dell’indagine.
Da un lato vi è la «fisica», dall’altro la «fenomenologia»; da un lato vi è il problema del processo fisico che conduce a questo o a quel risultato fenomenologico, dall’altro, vi è questo stesso risultato, considerato indipendentemente da quel processo, come un dato che ha un suo contenuto descrittivo che può essere reso esplicito nella molteplicità delle sue interconnessioni e nella complessità dei suoi rimandi di senso, restando interamente sul terreno delle apparenze fenomenologiche.
Che cosa tutto ciò possa significare, lo possiamo cominciare a mettere in evidenza non appena ci avviamo a proporre i lineamenti di una fenomenologia della cosa materiale, che può fungere, per motivi che solo in seguito potranno divenire chiari, da premessa alla nostra tematica così come da filo conduttore per il suo svolgimento.
Come prima guida, può essere utile fare riferimento alle ricerche husserliane sopra la costituzione, e precisamente a quel capitolo secondo del secondo volume delle Idee per una fenomenologia pura [1]nel quale il problema è appunto quello di rendere conto dell’essenza della cosa, della cosa data nell’esperienza concreta, dei «corpi» del nostro mondo circostante.
Riprendiamone dunque, in breve, il contenuto.
L’apertura del problema non potrebbe essere più tradizionale: la res è caratterizzata anzitutto dalla extensio [2]. Ma già l’insistenza con cui si sottolinea che l’estensione di cui si parla non è da intendere come una nozione «pensata», bensì come una datità intuita, mostra che l’avvio e la terminologia tradizionale debbono subire un netto spostamento su un nuovo terreno. L’estensione inerente alla cosa non è una porzione dello spazio astrattamente inteso, non è un suo ritaglio. Le cose non appartengono all’universo della geometria così come del resto e nemmeno ad esso le loro estensioni. Per questo, nel testo, si parla, non tanto di estensione spaziale della cosa, quanto piuttosto del suo corpo spaziale (Raumkörper), della sua estensione corporea [3].
L’estensione è essenziale alla nozione della cosa - ovvero, secondo una terminologia meno compromessa, ma che ripete il problema negli stessi termini: in questo modo abbiamo preso una decisione sull’impiego della parola «cosa materiale». I suoni, per esempio, non sono cose materiali.
Ma subito andiamo oltre: una simile qualità delle cose è una qualità in un’accezione del tutto impropria e per un duplice ordine di motivi. In primo luogo essa non è una qualità che una cosa può avere o non avere; in secondo luogo, essa non si dà mai in se stessa e come tale, ma sempre insieme ad altre qualità. Il colore - per esempio; ma anche tutte quelle determinazioni che risultano dall’esplorazione tattile e più in generale pratica della cosa stessa. Queste determinazioni si rapportano all’estensione della cosa come a un loro necessario presupposto, come a una forma vuota che esse debbono riempire. E proprio per questo loro carattere di pienezza, solo ad esse potremmo riservare il termine di qualità, mentre l’estensione ha il senso di «una forma essenziale di qualsiasi qualità reale». «La sua particolare posizione non è quella di una qualità tra le altre» [4]. Essa appartiene primariamente alla cosa come condizione per ogni qualificazione possibile. Nulla ci impedisce infatti di riprendere la vecchia terminologia parlando delle qualità riempienti nel loro insieme come qualità secondarie e riservando invece l’espressione di qualità primaria all’estensione, in un senso totalmente rinnovato dei termini.
Resta dunque ancora da effettuare il passaggio dall’estensione come datità visiva alla materialità, un passaggio che deve nello stesso tempo condurre dalla cosa come possibile apparenza illusoria, nel senso in cui possiamo dire che è una apparenza illusoria la piramide rossa vista attraverso lo stereoscopio, alla cosa posta come tale nel suo esserci effettivo. Il problema della res diventa dunque il problema della realtà stessa. E nel tema della materialità dovrà confluire anche quello della sostanza dal momento che, al fine della posizione della cosa come realmente sussistente, l’idea di un sostrato identico a cui le datità sensoriali sono ancorate deve certamente assolvere un ruolo decisivo.
Questo passaggio dal motivo della materialità a quello della realtà e della sostanzialità rappresenta un punto particolarmente importante per comprendere l’orientamento complessivo della discussione che qui viene condotta. Altrettanto importante è il fatto che il riferimento puro e semplice ai sistemi di concordanze che si vengono istituendo attraverso gli schemi sensoriali venga ritenuto come parte del problema, ma non ancora come il riferimento risolutivo.
Questa sembra infatti essere la via che va anzitutto percorsa quando si sia posto il problema dell’opposizione tra l’apparente-illusorio e il reale sul piano della costituzione fenomenologica: tanto più la cosa verrà confermata nel suo esserci, quanto più i dati emergenti nei diversi schemi sensoriali si presenteranno tra loro organizzati e coordinati in uno schema complessivo articolato e coerente. La cosa, nella sua realtà sostanziale, si impone allora come polarità identica di riferimento all’interno dell’apprensione percettiva.
Ma nel testo che stiamo considerando si intende procedere oltre: pur riconoscendo che la presenza di concordanze sensoriali sistematicamente organizzate non possano che agire come motivazioni per la posizione della cosa, si afferma anche perentoriamente che «rifarsi alla concordanza dei sensi diversi significherebbe fraintendere il nostro problema» [7]. Mentre questo problema viene avviato alla sua soluzione passando dalla cosa, fin qui implicitamente intesa nel suo isolamento, alla considerazione dei nessi e delle relazioni intercosali in cui essa si presenta e ponendo l’accento sul fatto che ogni variazione delle manifestazioni fenomenologiche di essa ci appare come funzionalmente dipendente da circostanze specificabili.
L’attribuzione a una cosa di una qualità deve risolversi nella descrizione del comportamento della cosa nel variare delle circostanze del suo apparire. Il tema della materialità confluisce in quello della realtà e della sostanza: e nello sviluppo della discussione emerge come determinante il tema della connessione causale. «La realtà o, ed è lo stesso, la sostanzialità e la causalità sono inseparabilmente inerenti. Le qualità reali sono eo ipso qualità causali» [8]. «Perciò conoscere una cosa significa: sapere per esperienza come si comporterà sotto una spinta, sotto una pressione, quando verrà piegata, quando verrà rotta, sottoposta al riscaldamento, sottoposta al raffreddamento, vale a dire: come si comporterà nel contesto delle sue causalità, in quali stati verrà a trovarsi e in che modo si manterrà la stessa attraverso tutti questi stati» [9].
3. Limiti di una considerazione epistemologica e necessità di un nuovo orientamento
In tutto lo sviluppo del problema della materialità Husserl si attiene strettamente ai criteri di principio di un’impostazione fenomenologica: in particolare, la nozione della cosa è proposta in primo luogo a partire dall’esperienza della cosa, quindi dalla concretezza delle datità fenomenologiche. E tuttavia lo scopo prefissato fin dall’inizio, che orienta le conclusioni, era essenzialmente quello di mostrare in che modo, a partire di qui, la cosa si proponga alla fine come un’oggettività sulla quale possano innestarsi operazioni conoscitive. Ciò spiega come mai il titolo della materialità non assolva, nonostante tutto, alcun ruolo specificamente determinato, ma esso si converta senz’altro in quello della realtà e della sostanza, con le loro più dirette ed evidenti implicazioni epistemologiche.
Come abbiamo visto, la domanda effettiva intorno alla cosa diventa propriamente: «Che cosa costituisce il concetto di questa res, che cosa significa realtà estesa, che cosa significa realtà in generale? Si parla anche di sostanza estesa. Che cosa significa, ci chiediamo, questa sostanzialità, e che cosa significa nella massima generalità possibile?» [10].
Ma se questa è la domanda, allora ad una simile linea di sviluppo di una fenomenologia della cosa materiale si può obiettare di tenere in scarso conto proprio i contrassegni della materialità. Dove, in essa, si parla propriamente della «materia»? In quale punto emerge il tema della materia, in se stesso, come un «senso» da rendere esplicito? Lo scopo che qui si persegue è piuttosto quello di mostrare la transizione della cosa dell’esperienza alla cosa per la conoscenza, dalla cosa materiale alla cosa fisicalistica, alla cosa cioè in quanto essa si offre come obiettivo di indagini sistematiche rivolte alla natura elementarmente intesa come mondo di cose.
Fa parte allora dell’impostazione di principio del problema il mostrare da un lato che il pensiero di una simile possibilità conoscitiva, dunque il pensiero che è costituito dalla nozione della realtà oggettiva, ha la sua origine nell’apprensione percettiva dei nessi causali, di cui si ribadisce l’effettività fenomenologica; ma dall’altro si tratta anche di esibire la necessità di procedere oltre questo terreno dell’immediatezza dell’esperienza. Anzi, l’intero percorso argomentativo che abbiamo brevemente sintetizzato può essere considerato come un percorso di progressivo allontanamento da quella immediatezza: e la nozione della cosa alla fine teorizzata, secondo la quale essa è in ultima analisi una x interamente descritta da un sistema di leggi, si dispone a quel livello minimo di astrazione intellettuale che possiamo assumere idealmente come condizione per l’avvio di un progetto conoscitivo. La cosa intesa così non è affatto data, benché una simile possibilità di intenderla sia coimplicata nel darsi della cosa. Ma essa si presenta appunto come risultato di un’elaborazione teoretica che comincia a superare l’immediatezza del dato, preludendo alla produzione di vere e proprie oggettività di «ordine superiore» che non hanno alcun riscontro diretto nell’esperienza concreta.
Riceve particolare significato il fatto che al termine di questo percorso, quando si perviene alla «nuova determinazione» del concetto della cosa, nella quale le qualità reali assumono senz’altro lo statuto di qualità causali, si parli anche, e in conseguenza di questa nuova determinazione, di soppressione e di superamento (Aufhebung)dell’esperienza della cosa11]. [
Tutto ciò è una diretta conseguenza della cornice epistemologica nella quale si sviluppa, nel volume secondo delle Idee, la fenomenologia della cosa materiale. Ma una volta che abbiamo preso atto di un simile orientamento e dell’incidenza che esso finisce con l’avere sull’intero sviluppo argomentativo, si impone la possibilità di procedere in una direzione interamente diversa.
Naturalmente la domanda iniziale può anche essere formulata nello stesso modo: quali sono le caratteristiche che conducono ad attribuire a un complesso di datità fenomenologiche il senso della materialità, della cosa materiale? Ma del tutto diversa può essere l’intenzione della domanda e di conseguenza il modo secondo cui ci accingiamo a dare a essa una risposta. Parlando di materia o di cosa materiale non siamo affatto tenuti a scorgere anzitutto l’emergere del problema della costituzione di «cose» intese come oggettività da conoscere, quindi come identità sostanziali il cui concetto richiede di essere filosoficamente chiarificato. La chiarificazione filosofica potrebbe invece essere chiamata in causa per mostrare quali sono i momenti che forniscono un riempimento intuitivo della nozione di materia al di là di un’elaborazione teoretica preliminare. L’indagine costitutiva non deve allora senz’altro indirizzarsi verso la cosa fisicalistica, per mostrare in che modo essa possa delinearsi a partire dalle datità concrete, ma può arrestarsi presso l’esperienza della cosa e proporsi come compito l’esplicitazione del suo contenuto.
Di cose materiali, di cose che hanno cioè nella materialità la loro specificazione essenziale, parliamo a ragion veduta, ma per parlarne così non è affatto necessaria una qualche forma di sapere più profondo, che vada oltre il piano della semplice immediatezza percettiva.
Chiediamo, per esempio, che ci venga indicato qualcosa a cui ci si possa appigliare per avviare un discorso intorno alla materia; e certamente si farà riferimento anzitutto a un «corpo solido». Questa è una prima circostanza assai più significativa di quanto possa apparire a un primo sguardo. Di fatto, in ciò è implicitamente ammessa un’anteriorità di principio, un’esemplarità, nel senso più forte, della cosa nel senso consueto per l’illustrazione della nozione di materialità: passando semplicemente al di sopra della circostanza, nota a ognuno, secondo la quale sarebbe certamente più corretto parlare della solidità come di uno stato della materia, e della materia stessa come di qualcosa di soggiacente alla modificazione degli stati. Di questa circostanza si tace proprio perché lo stesso parlare di stati presuppone un’elaborazione teoretica che, pur avendo a sua volta una base fenomenologica nella specifica esperienza della modificazione di stato, tuttavia propone una nozione di materia che non ha un riempimento intuitivo diretto e che si trova già nella prospettiva di una concettualizzazione.
Dal punto di vista di una fenomenologia della cosa materiale che metta da parte, come un diverso problema, gli impegni e le implicazioni di ordine epistemologico, non solo deve essere riconosciuta una priorità espositiva ai corpi solidi [12], ma soprattutto essa deve prendere le mosse e lasciarsi orientare dalla loro esemplarità.
Parliamo della materia, della cosa materiale, e subito proponiamo una sorta di modello fenomenologico, di cosa materiale in senso eminente, attiriamo l’attenzione su un complesso di apparenze fenomenologiche nel quale quei caratteri che sono condizioni per l’attribuzione del senso della materialità esplicano la loro massima energia.
Una pietra di granito, dunque, e di grandi dimensioni. E non, per esempio, un granello di sabbia. E tanto meno l’acqua; o addirittura l’aria.
E così facendo ci comportiamo da uomini di buon senso. Né l’acqua né l’aria sono cose. Ma se abbiamo bisogno di un caso veramente esemplare, di un modello, nemmeno il minutissimo frammento, il granello di sabbia, è adatto allo scopo: proprio, vorremmo dire, per la sua sfuggente piccolezza. Esso non ha peso. Mentre la pietra di granito ci sta di fronte in tutta la sua pesantezza, la sua stabilità, la definitezza e la compiutezza della sua forma. Nella sua ferma individualità: non certamente nel senso letterale della indivisibilità, ma nel senso che essa si contraddistingue, nella determinatezza dei suoi contorni, da tutto ciò che sta intorno, emergendo in modo netto e definito nello spazio circostante. Di essa possiamo dire: questa cosa qui, proprio questa e non altra. Fissando la pietra nella sua identità irremovibile.
3. Limiti di una considerazione epistemologica e necessità di un nuovo orientamento
In tutto lo sviluppo del problema della materialità Husserl si attiene strettamente ai criteri di principio di un’impostazione fenomenologica: in particolare, la nozione della cosa è proposta in primo luogo a partire dall’esperienza della cosa, quindi dalla concretezza delle datità fenomenologiche. E tuttavia lo scopo prefissato fin dall’inizio, che orienta le conclusioni, era essenzialmente quello di mostrare in che modo, a partire di qui, la cosa si proponga alla fine come un’oggettività sulla quale possano innestarsi operazioni conoscitive. Ciò spiega come mai il titolo della materialità non assolva, nonostante tutto, alcun ruolo specificamente determinato, ma esso si converta senz’altro in quello della realtà e della sostanza, con le loro più dirette ed evidenti implicazioni epistemologiche.
Come abbiamo visto, la domanda effettiva intorno alla cosa diventa propriamente: «Che cosa costituisce il concetto di questa res, che cosa significa realtà estesa, che cosa significa realtà in generale? Si parla anche di sostanza estesa. Che cosa significa, ci chiediamo, questa sostanzialità, e che cosa significa nella massima generalità possibile?» [10].
Ma se questa è la domanda, allora ad una simile linea di sviluppo di una fenomenologia della cosa materiale si può obiettare di tenere in scarso conto proprio i contrassegni della materialità. Dove, in essa, si parla propriamente della «materia»? In quale punto emerge il tema della materia, in se stesso, come un «senso» da rendere esplicito? Lo scopo che qui si persegue è piuttosto quello di mostrare la transizione della cosa dell’esperienza alla cosa per la conoscenza, dalla cosa materiale alla cosa fisicalistica, alla cosa cioè in quanto essa si offre come obiettivo di indagini sistematiche rivolte alla natura elementarmente intesa come mondo di cose.
Fa parte allora dell’impostazione di principio del problema il mostrare da un lato che il pensiero di una simile possibilità conoscitiva, dunque il pensiero che è costituito dalla nozione della realtà oggettiva, ha la sua origine nell’apprensione percettiva dei nessi causali, di cui si ribadisce l’effettività fenomenologica; ma dall’altro si tratta anche di esibire la necessità di procedere oltre questo terreno dell’immediatezza dell’esperienza. Anzi, l’intero percorso argomentativo che abbiamo brevemente sintetizzato può essere considerato come un percorso di progressivo allontanamento da quella immediatezza: e la nozione della cosa alla fine teorizzata, secondo la quale essa è in ultima analisi una x interamente descritta da un sistema di leggi, si dispone a quel livello minimo di astrazione intellettuale che possiamo assumere idealmente come condizione per l’avvio di un progetto conoscitivo. La cosa intesa così non è affatto data, benché una simile possibilità di intenderla sia coimplicata nel darsi della cosa. Ma essa si presenta appunto come risultato di un’elaborazione teoretica che comincia a superare l’immediatezza del dato, preludendo alla produzione di vere e proprie oggettività di «ordine superiore» che non hanno alcun riscontro diretto nell’esperienza concreta.
Riceve particolare significato il fatto che al termine di questo percorso, quando si perviene alla «nuova determinazione» del concetto della cosa, nella quale le qualità reali assumono senz’altro lo statuto di qualità causali, si parli anche, e in conseguenza di questa nuova determinazione, di soppressione e di superamento (Aufhebung)dell’esperienza della cosa11]. [
Tutto ciò è una diretta conseguenza della cornice epistemologica nella quale si sviluppa, nel volume secondo delle Idee, la fenomenologia della cosa materiale. Ma una volta che abbiamo preso atto di un simile orientamento e dell’incidenza che esso finisce con l’avere sull’intero sviluppo argomentativo, si impone la possibilità di procedere in una direzione interamente diversa.
Naturalmente la domanda iniziale può anche essere formulata nello stesso modo: quali sono le caratteristiche che conducono ad attribuire a un complesso di datità fenomenologiche il senso della materialità, della cosa materiale? Ma del tutto diversa può essere l’intenzione della domanda e di conseguenza il modo secondo cui ci accingiamo a dare a essa una risposta. Parlando di materia o di cosa materiale non siamo affatto tenuti a scorgere anzitutto l’emergere del problema della costituzione di «cose» intese come oggettività da conoscere, quindi come identità sostanziali il cui concetto richiede di essere filosoficamente chiarificato. La chiarificazione filosofica potrebbe invece essere chiamata in causa per mostrare quali sono i momenti che forniscono un riempimento intuitivo della nozione di materia al di là di un’elaborazione teoretica preliminare. L’indagine costitutiva non deve allora senz’altro indirizzarsi verso la cosa fisicalistica, per mostrare in che modo essa possa delinearsi a partire dalle datità concrete, ma può arrestarsi presso l’esperienza della cosa e proporsi come compito l’esplicitazione del suo contenuto.
Di cose materiali, di cose che hanno cioè nella materialità la loro specificazione essenziale, parliamo a ragion veduta, ma per parlarne così non è affatto necessaria una qualche forma di sapere più profondo, che vada oltre il piano della semplice immediatezza percettiva.
Chiediamo, per esempio, che ci venga indicato qualcosa a cui ci si possa appigliare per avviare un discorso intorno alla materia; e certamente si farà riferimento anzitutto a un «corpo solido». Questa è una prima circostanza assai più significativa di quanto possa apparire a un primo sguardo. Di fatto, in ciò è implicitamente ammessa un’anteriorità di principio, un’esemplarità, nel senso più forte, della cosa nel senso consueto per l’illustrazione della nozione di materialità: passando semplicemente al di sopra della circostanza, nota a ognuno, secondo la quale sarebbe certamente più corretto parlare della solidità come di uno stato della materia, e della materia stessa come di qualcosa di soggiacente alla modificazione degli stati. Di questa circostanza si tace proprio perché lo stesso parlare di stati presuppone un’elaborazione teoretica che, pur avendo a sua volta una base fenomenologica nella specifica esperienza della modificazione di stato, tuttavia propone una nozione di materia che non ha un riempimento intuitivo diretto e che si trova già nella prospettiva di una concettualizzazione.
Dal punto di vista di una fenomenologia della cosa materiale che metta da parte, come un diverso problema, gli impegni e le implicazioni di ordine epistemologico, non solo deve essere riconosciuta una priorità espositiva ai corpi solidi [12], ma soprattutto essa deve prendere le mosse e lasciarsi orientare dalla loro esemplarità.
Parliamo della materia, della cosa materiale, e subito proponiamo una sorta di modello fenomenologico, di cosa materiale in senso eminente, attiriamo l’attenzione su un complesso di apparenze fenomenologiche nel quale quei caratteri che sono condizioni per l’attribuzione del senso della materialità esplicano la loro massima energia.
Una pietra di granito, dunque, e di grandi dimensioni. E non, per esempio, un granello di sabbia. E tanto meno l’acqua; o addirittura l’aria.
E così facendo ci comportiamo da uomini di buon senso. Né l’acqua né l’aria sono cose. Ma se abbiamo bisogno di un caso veramente esemplare, di un modello, nemmeno il minutissimo frammento, il granello di sabbia, è adatto allo scopo: proprio, vorremmo dire, per la sua sfuggente piccolezza. Esso non ha peso. Mentre la pietra di granito ci sta di fronte in tutta la sua pesantezza, la sua stabilità, la definitezza e la compiutezza della sua forma. Nella sua ferma individualità: non certamente nel senso letterale della indivisibilità, ma nel senso che essa si contraddistingue, nella determinatezza dei suoi contorni, da tutto ciò che sta intorno, emergendo in modo netto e definito nello spazio circostante. Di essa possiamo dire: questa cosa qui, proprio questa e non altra. Fissando la pietra nella sua identità irremovibile.
4. La nozione della materialità illustrata attraverso il rimando ad un modello
Dal punto di vista della costituzione fenomenologica, che riprende, esplicitandole, le precostituzioni operate dall’esperienza, la materia rimanda all’azione. L’irremovibilità del blocco di granito ha il senso di una risposta a un’intenzione di movimento. La materia è anzitutto pesante, molto pesante, secondo un’accezione della pesantezza che è interamente risolta nella sensazione soggettiva dello sforzo.
L’esperienza vissuta della materia riconduce sempre a modalità di resistenza a intenzioni pratico-attive. La cosa resiste al tentativo di sollevarla. Resiste alla pressione delle mie dita, si oppone alla penetrazione e alla modificazione. La durezza appartiene ai suoi attributi costitutivi; così come l’impenetrabilità, che si annuncia visivamente nell’intrasparenza e nell’opacità;e il corrugamento della sua superficie che genera l’attrito.
Appare ora certamente chiaro in che senso sia mutato l’orientamento delle nostre considerazioni. Anche seguendo il percorso precedente ci imbattiamo in esempi che rimandano ad azioni, alle pressioni che possiamo esercitare sulle cose e alla resistenza che oppone, per esempio, una molla di acciaio [13]; ma questi esempi sono inseriti in un contesto che fa apparire quelle azioni come pratiche che mettono alla prova le proprietà della cosa e consentono infine un collegamento diretto con la problematica delle dipendenze causali. E così in generale tutti i riferimenti alla tattilità tendono principalmente a illustrare la nozione di schema tattile come uno dei momenti dello schema sensoriale complessivo che è destinato a svolgere un ruolo di conferma all’interno del sistema di concordanze che rafforzano le motivazioni della posizione della cosa nel suo esserci. Il filo conduttore è infatti quello della cosa come oggettività da conoscere che deve essere anzitutto costituita nella sua identità sostanziale. Mentre ora la nozione di oggettività con cui abbiamo a che fare si definisce unicamente per il suo carattere di polarità oppositiva, come momento negativo rispetto alle intenzioni soggettive, come ostacolo ad esse.
E del resto muta interamente anche il senso in cui andiamo enumerando gli attributi costitutivi della cosa materiale. Solo tenendo conto di questo mutamento risulta realmente significativo il progetto di avviare le nostre considerazioni cominciando dall’esibizione di un modello fenomenologico. Non si tratta di riconoscere che in essi si trovano di fatto unificati i contrassegni della materialità, ma piuttosto di sottolineare che attraverso le tensioni pratico-percettive prende forma un immagine della materialità che il blocco di granito porta all’espressione. Fin dal momento in cui abbiamo deciso di lasciare da parte la cosa epistemologica negli sviluppi di una fenomenologia della cosa materiale che si attenga unicamente all’esperienza vissuta della materialità, abbiamo anche deciso di lasciare liberamente agire le componenti propriamente immaginative, che del resto fanno integralmente parte di quella esperienza. Indicare nel blocco di granito un modello fenomenologico della cosa materiale significa richiamare l’attenzione sul fatto che la percezione lo sa cogliere come la cosa che esso propriamente è, ma anche, e nello stesso tempo, come una sorta di monumento innalzato alla materia stessa.
5. Un’immagine per l’immateriale
Ed è indicativo dell’orizzonte entro cui si muove la fenomenologia della cosa materiale di Husserl il fatto che nell’esposizione del volume secondo delle Idee, di tutto ciò non si faccia cenno, benché non manchi qualche spunto che può essere interpretato in questa direzione.
Per esempio si osserva, e potrebbe sembrare un’affermazione un poco stravagante, che «i corpi solidi trasparenti rappresentano già una deviazione dal caso normale della costituzione originaria» [14]: spiegando che una lastra di vetro che riempia l’intero campo visivo in posizione parallela all’osservatore tende a sfuggire alla vista. Essa comincia ad apparire solo se «modificandone l’orientamento, attraverso il suo rapporto con altri corpi, vengono in luce per esempio gli orli»; ma difficilmente potremo ottenere di questa cosa uno schema visivo vero e proprio, poiché siamo ostacolati «dal lucido, dai riflessi, da immagini di altre cose viste in trasparenza» [15].
Osservazioni come queste, che compaiono in quel testo come osservazioni relativamente marginali, rivestono per noi un particolare interesse perché possono diventare veramente significative solo all’interno del nostro contesto di discorso.
Si accenna qui a una costituzione normale della materialità, e la deviazione da essa viene imputata alla mancanza di «una datità parallela per la vista e per il tatto» [16]. Ma si indebolirebbe certamente la portata dell’esempio se una simile osservazione si riducesse al rilievo delle difficoltà di formazione di uno schema visivo a causa della trasparenza. Modificando l’esempio, potremmo pensare a un piccolo oggetto di vetro: in questo caso, lo schema visivo si forma senz’altro e senza difficoltà: vedo infatti i suoi contorni, la superficie da essi circoscritta, una superficie trasparente, liscia e levigata. Se poi tocco questa superficie, i dati tattili confermeranno addirittura i dati visivi.
Eppure sarebbe giusto parlare anche in questo caso di «una deviazione dal caso normale della costituzione originaria» nel senso che vi è qui comunque una forma particolare di incoerenza, di conflitto interno alle apparenze percettive, che non è da porre sullo stesso piano di quelle discordanze che condurrebbero al dubbio intorno all’effettivo esserci della cosa, alla sua possibile illusorietà.
L’impenetrabilità tattilmente sperimentata contrasta infatti, nell’immagine della materia, con la trasparenza della cosa che evoca invece l’elemento immateriale. Non per questo, certamente, il vetro diventa una oggettività fittizia ma piuttosto una materia paradossale, una materia meravigliosa - una materia di fronte alla quale dovremmo forse imparare ancora a meravigliarci e di cui, in ogni caso, la percezione stessa si meraviglia.
La considerazione di questo rapporto contiene tuttavia anche un altro motivo che ci costringe in certo senso a ritornare sui nostri passi proprio per ciò che concerne la nozione della materialità così come l’abbiamo prospettata facendo riferimento al nostro modello fenomenologico.
Abbiamo parlato della ferma individualità del blocco di granito. E abbiamo spiegato che con ciò volevamo alludere al suo stagliarsi da tutto il resto che lo circonda. Ma se ora ci chiediamo a che cosa esso debba questa individualità probabilmente penseremmo alla forma piuttosto che alle connotazioni propriamente materiali: alla forma intesa come contorno, come linea chiusa, come momento di separazione e di distinzione.
Ma allora, se riconsideriamo la questione sotto questo aspetto, a partire dalla vuotezza della forma si opera la transizione alla sua essenziale rigidità. La forma è l’elemento individuante, e anche l’elemento rigido. Cosicché si delinea un’immagine della materia interamente diversa, in opposizione alla forma e alla stessa nozione della cosa: l’immagine della materia senza nome, di una materia che, essendo priva di forma, è anche essenzialmente defluente: la materia come elemento informale, come melma.
In questo strano argomentare, manteniamo comunque ferma la centralità del riferimento, dal punto di vista della costituzione, al nostro modello di cosa materiale.
In rapporto a esso si realizza una costituzione positiva della materialità. Ma abbiamo già notato che una costituzione positiva può comportare una costituzione negativa, e proprio per questo abbiamo potuto proporre il tema dell’immateriale. Con questo ultimo cenno non abbiamo fatto altro che sviluppare la possibilità di una costituzione negativa rivolta tuttavia in un’altra direzione.
Note
[1] E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tr. it. a cura di E. Filippini, Libro II (Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione), cap. II, Einaudi, Torino 1965, p. 426 e sgg.
[2] ivi, pp. 426-7.
[3] ivi, p. 429.
[4] ivi, p. 430.
[5] ivi, p. 434.
[6] ivi, p. 435
[7] ivi, p. 438.
[8] ivi, p. 442
[9] ivi, p. 441.
[10] ivi, p. 432.
[11] ivi, p. 441 (nel titolo del § 15e).
[12] Per quanto ci stiamo avviando in una diversa direzione di sviluppo del problema, questo riconoscimento è peraltro presente anche nel testo di Husserl, cfr. l’Aggiunta a p. 449.
[13] ivi, pp. 437 e 445.
[14] ivi, p. 450.
[15] ivi.
[16] ivi.
II. C o l o r i


Nell’avviarci a mostrare l’orientamento di una considerazione fenomenologica del colore, facciamo agire il tema della cosa materiale come filo conduttore già per il fatto che prendiamo le mosse dal colore inteso anzitutto come proprietà delle cose.
Un simile inizio non urta certamente il senso comune, mentre potrebbe suscitare riserve e perplessità filosofiche. Comunque vengano formulate, esse riproporranno prima o poi, in maniera più o meno scoperta, i termini della distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie. Il colore non apparterrebbe alla cosa stessa, ma alla relazione della cosa con la soggettività. In modo più sottile l’obiezione potrebbe essere formulata richiamandosi alla fisica del colore e alle spiegazioni corrispondenti. Da questo punto di vista il parlare del colore come proprietà delle cose sarebbe un’indebita concessione al senso comune. Dovremmo invece impostare il problema parlando di uno stato sensoriale - la sensazione cromatica - che sorge come risultato di un processo fisico complesso, nel quale svolgono una parte determinante la conformazione dell’occhio, la costituzione fisica della luce e della cosa che ci appare colorata in questo o quel modo.
Naturalmente non vi è nulla da eccepire intorno al passaggio al piano delle spiegazioni: mentre è sbagliata l’opinione che l’effettuazione di questo passaggio comporti l’illusorietà del riferimento del colore alla cosa come una sua proprietà. Questo riferimento appartiene infatti all’ambito delle pure apparenze fenomenologiche. Non sbaglia invece il linguaggio corrente quando attribuisce un determinato colore ad una cosa determinata, e lo attribuisce anzi in modo permanente e persistente come un attributo inerente alla cosa così come essa è in sé e per sé.
Del colore come qualità secondaria si può parlare solo nel senso che abbiamo in precedenza chiarito quando abbiamo mostrato che esso riempie l’estensione vuota e priva di una datità intuitiva autonoma. Questo carattere riempiente è naturalmente proprio di tutte le proprietà qualificanti, ma nel caso del colore questo rapporto con l’estensione ha certamente le sue peculiarità. Il colore si distende sulla superficie della cosa e la ricopre tutta come una sottile pellicola che aderisce perfettamente ad essa.
Questa analogia gioca peraltro su una distinzione analitica che, per quanto possa apparire ovvia, merita tuttavia di essere messa in evidenza. Ciò che forma una sottile pellicola distesa sulla cosa è, tutt’al più, il colore inteso come pigmento, come vernice, come materia cromatica. Mentre da essa dobbiamo distinguere il colore in quanto qualità puramente visiva che «aderisce» all’estensione in un senso interamente diverso.
Pensiamo del resto al modo in cui una volta si usava stendere il colore sulla tela. In fondo, di fronte a quei dipinti potremmo chiederci ingenuamente perché mai essi sono così lisci, perché mai tanta perizia veniva messa alla prova nello stendere il colore in modo non solo da ricoprire la tela in ogni suo punto, così che essa ne risulti interamente nascosta, ma anche da non lasciare trasparire la minima traccia del pennello che passa e ripassa su di essa. Fin dall’inizio la pratica pittorica non può non avere a che fare con quella distinzione che evoca l’opposizione tra la materialità del colore e la sua immaterialità. Se appena un’increspatura si notasse nel dipinto, se la pennellata lasciasse un segno, attraverso il corrugarsi della superficie, con l’ineguaglianza e la ruvidità, apparirebbe in primo piano la materia stessa. Mentre, così facendo, facciamo di tutto per ridurre questa presenza ed esaltare invece la natura puramente estesa del colore.
La tela in quanto cosa deve scomparire sotto la vernice e questa, a sua volta, come materia cromatica, deve dissolversi nel livellamento di ogni scabrosità e di ogni spessore. Tutte le nostre intenzioni sono rivolte verso la immaterialità del colore, verso l’estensione cromatica immateriale: attirando tutta l’attenzione sulla scena rappresentata nel dipinto come una sorta di rappresentazione visionaria, che è apparsa al pittore e che egli consegna intatta allo spettatore, vorremmo quasi dire, nella sua oggettività. Infatti l’occultamento della matericità del colore ha anche, nello stesso tempo, il senso di celare il momento pratico concreto, e dunque la soggettività stessa in quanto si esprime nel gesto effettivo del dipingere. Tutta la cura gestuale nello stendere il colore ha di mira la soppressione del gesto stesso, manifestando un modo di concepire l’attività pittorica come un’attività essa stessa eminentemente «spirituale».
Inversamente potremmo lasciare che la scena visiva si riempia di segnali tattili, orientandoci così nella direzione opposta: nella direzione della esibizione della matericità del colore che è anche esibizione della soggettività del gesto e della prassi pittorica come una prassi che ha a che fare anzitutto con cose.
Nelle nostre considerazioni introduttive abbiamo tuttavia anche parlato dell’estensione come superficie delineata da un contorno, abbiamo parlato della forma come rigida impalcatura della cosa. E ciò fa pensare anche al colore come circoscritto in essa, chiuso dentro la forma. Considerando il rapporto tra colore ed estensione sotto questo aspetto, il colore viene posto a distanza: esso si trova laggiù,nel recinto della cosa, appiattito su di essa.
Abbiamo preso le mosse dal colore come proprietà della cosa: ed è come se avessimo voluto dire anche, esprimendoci così, che la cosa è veramente la proprietaria del suo colore.
La relazione del colore alla luce si presenterebbe allora come una semplice messa allo scoperto di una determinazione obiettiva: un raggio lineare va a scovare l’oggetto nel suo luogo, lo colpisce, come una freccia, e poi fa la sua denuncia: «Esso è azzurro». La cosa si mostra e dice: «Questo colore è il mio».
Il prendere le mosse dal colore come proprietà della cosa sarebbe certamente orientato anzitutto in questa direzione se non sapessimo già che un simile modo di intendere la cosa e le sue proprietà può giungere solo al termine delle procedure oggettivanti dei processi di costituzione. Se da un lato infatti è per molti versi importante richiamare primariamente l’attenzione sull’appartenenza del colore alla cosa come un dato di esperienza, dall’altro è altrettanto importante per uno sviluppo effettivo del problema non perdere di vista la processualità della costituzione, e dunque l’intero ambito delle relatività fenomenologiche nelle quali questi rapporti non sono affatto decisi.
A questo proposito la fenomenologia implicita nelle pratiche pittoriche potrebbe insegnarci molte cose. Per esempio, il pittore impressionista sembra voler tradurre sul piano pittorico i risultati delle indagini scientifiche intorno alla luce e alla formazione del colore come evento fisico. Di fatto, viene invece realizzata una complessa fenomenologia dell’esperienza cromatica, nella quale viene respinta ai margini la cosa nella sua identità onnitemporale, così come il rapporto del colore alla cosa inteso come mero rapporto di riempimento. Il colore viene anzitutto giocato contro la forma, cosicché il «corpo spaziale» diventa nient’altro che un addensamento del cromatismo, immerso e sconfinante nelle atmosfere di luce da cui sembra avere origine. In questo modo, la cosa, tendenzialmente dissolta nella sua consistenza materiale, viene attratta nella temporalità soggettiva del vissuto. Raffigurata non è la cosa in sé, ma la cosa nel suo giorno, e il giorno nella sua ora - così come ci appare.
Ma non appena attiriamo l’attenzione sulla problematicità di questi rapporti ci rendiamo subito conto che essa non è certamente solo attestata dalle relatività dei processi di costituzione.
Anche qui vi sono infatti quelle che potremmo ancora chiamare deviazioni dal caso normale della costituzione originaria. Ai colori distesi e fermi sulla superficie delle cose si possono contrapporre i colori irrequieti delle bolle di sapone oppure gli scintillanti cromatismi che baluginano nei riflessi delle superfici. Ma infine la massima distanza dalla cosa è data dai colori diffusi: dalla possibilità di colorare la luce - vogliamo proprio esprimerci così. Nella luce colorata, il colore si libera interamente dal vincolo con la cosa materiale, si libera addirittura dal riferimento all’estensione intesa come forma, come contorno, come "corpo spaziale". In luogo di distendersi e di riempire una forma, esso si diffonde nello spazio. Esso non è più circoscritto in un luogo, il luogo stesso della cosa - non è più là: ma in esso ci si può immergersi e da esso ci si può lasciare avvolgere.
Facendo agire i punti di vista finora emersi affrontiamo ora il classico problema del sistema dei colori.Dell’universo cromatico possiamo dare una sorta di rappresentazione grafica, ricorrendo a un cerchio o a un’altra configurazione geometrica più complessa, e questa possibilità indica in primo luogo che i colori singoli sono in realtà integrati in una struttura relazionale essenzialmente unitaria.
La circostanza è ben nota, ma l’ovvietà con la quale potrebbe essere assunta è in realtà solo apparente. In primo luogo ci stanno di fronte i colori nella loro enorme varietà, nella loro infinita molteplicità che il linguaggio stesso stenta a dominare. Ciononostante il pensiero di una fondamentale semplicità, di una struttura in ultima analisi elementare, della possibilità di un ordine rigoroso, e precisamente di un ordine inscritto nella natura stessa del colore, si è imposto dal tempo dei tempi e ha determinato, nelle sue trasformazioni ed evoluzioni, la lunga e complessa storia di questo problema.
Possiamo idealmente assumere che in questo pensiero confluiscano almeno due motivi che ci riconducono alla duplicità del colore come qualità visiva e come materia cromatica. Da un lato infatti vi sono evidenti affinità nell’aspetto dei colori, come tra il rosso e l’arancione o tra diversi tipi di uno stesso colore. Dall’altro, vi sono le constatazioni relative alle mescolanze delle materie cromatiche, nelle quali un determinato colore appare come risultato di una composizione. Di qui certamente ha avuto origine il problema, che è rimasto così a lungo indeciso, della distinzione tra colori semplici e colori composti. Se vi sono colori che sorgono per composizione, allora debbono esservi colori semplici - e l’identificazione di un numero ristretto e ben definito di colori semplici rappresenterebbe la soluzione del problema dell’unità.
Ma si cominciano a intravedere alcune prime difficoltà non appena facciamo notare che si tratta di motivi per nulla omogenei e che connettere il secondo con il primo conduce a una falsa posizione del problema. Come possiamo infatti essere certi che ciò che risulta composto in una mescolanza concreta di materie, debba essere giudicato tale anche in rapporto alla natura intrinseca del colore? Inversamente la semplicità, riferita alla materia cromatica, ha solo un senso affatto accidentale, e indica niente altro che l’impossibilità tecnico-pratica di ottenere questa materia cromatica attraverso mescolanze di altre.
Di qui risulta chiara non solo la non ovvietà di una considerazione dei colori da un punto di vista sistematico, ma persino della distinzione tra colore come qualità visiva e colore come materia cromatica. La storia della teoria del colore mostra un continuo e oscuro oscillare tra l’uno e l’altro polo, e molte delle proposte tradizionali di ordinamento sistematico sarebbero del tutto incomprensibili se non si tenesse conto di questa confusione latente. A complicare ancor più le cose, si aggiunge poi il problema dell’«armonia dei colori», che si affaccia fin dall’inizio in stretta connessione con le considerazioni sistematiche, e il peso delle valenze simboliche di cui vengono investiti i colori singoli e la stessa idea dell’unità dell’universo cromatico.
In questo intreccio di motivi si è inserito infine in modo determinante il motivo scientifico-esplicativo - un motivo che può a sua volta essere largamente frainteso nel suo senso e nella sua portata. Per una comprensione corretta è infatti necessario essere consapevoli che, nel momento in cui si propone una spiegazione autentica del prodursi del colore come evento fisico, l’asse del problema subisce un radicale spostamento e il tema stesso dell’unità riceve un senso interamente nuovo, così come la stessa problematica della semplicità e della composizione.
10. Gradazione chiaroscurale ed esperienza della transizione
Di fronte a tutto ciò ci proponiamo il compito, molto limitato, ma probabilmente utile per un orientamento della discussione, di mostrare quale aspetto assuma il problema del sistema dei colori inteso come un problema di fenomenologia filosofica. Si tratta allora in primo luogo di prescindere a un tempo dalle mescolanze tra le materie cromatiche così come da giustificazioni che presuppongono in un modo o nell’altro le spiegazioni tratte dalla fisica del colore. Il colore deve venire in questione solo come datità visiva - e allora deve indubbiamente essere chiarito in che senso si possa parlare di relazioni tra i colori e se seguendo questa via sia possibile pervenire alla posizione di un ordinamento sistematico, che a sua volta deve trarre il suo senso esclusivamente dal modo in cui esso viene proposto.
Il primo chiarimento necessario riguarda il carattere del sistema. Accanto alla tendenza alla moltiplicazione dei colori, al fine di adeguarsi all’infinita varietà dei casi singoli, vi è nel linguaggio corrente anche la tendenza opposta all’estrema semplificazione. Se non vi sono particolari ragioni per una specificità che raggiunga il caso singolo, ci limitiamo di norma all’impiego di un numero relativamente ristretto di parole di colore. «Semplificando» si prendono le distanze dalle particolarità del materiale empirico, dalle determinatezze del caso singolo-individuale. Perciò si parla dell’azzurro o del rosso come di unità eidetiche che non hanno alcun corrispondente empirico vero e proprio, ma che fanno riferimento ai casi singoli solo come esempi che illustrano un tipo. In realtà questatendenza è assecondata e fatta propria da una considerazione fenomenologica che prospetta fin dall’inizio il problema del sistema all’interno di un orizzonte platonistico. Le idealizzazioni operate debbono tuttavia poter essere giustificate a partire da una base fenomenologica, si richiede cioè che la struttura relazionale proposta poggi su relazioni effettivamente sperimentate.
Questa richiesta è, a nostro avviso, interamente soddisfatta dall’esperienza della transizione, che trova la sua prima ed elementare illustrazione nell’apprensione percettiva delle differenze chiaroscurali. Stando a essa, il colore singolo può essere colto come integrato in una sequenza continua che procede verso gradazioni sempre più chiare sino al bianco e, nella direzione opposta, verso gradazioni sempre più scure fino al nero. La chiarezza ha dunque il carattere di una «proprietà interna» del colore, e ciò comporta che una rete relazionale sia presupposta all’apprensione del colore nella sua singolarità.
Ora, il problema effettivo della base fenomenologica di un ordinamento sistematico dei colori sta nel mostrare la possibilità di operare una generalizzazione, di mostrare cioè che l’esperienza della transizione si fa valere anche in rapporto ai colori considerati nelle differenze del loro momento cromatico vero e proprio. |25|
Per illustrare il senso della questione vogliamo riprendere nei suoi termini essenziali la discussione a cui abbiamo già accennato in precedenza.
Abbiamo osservato che l’apparente ovvietà del problema di una considerazione unitaria è messa in questione anzitutto dalla stessa complessa e controversa storia del problema. In realtà è necessario giungere sino agli inizi del secolo XVII per avere la prima schematizzazione grafica del sistema che ci può apparire realmente ragionevole.
Il più antico diagramma delle relazioni cromatiche sembra sia dovuto a Franciscus Aguilonius che, nella sua Ottica del 1613, propone lo schema seguente[17]:
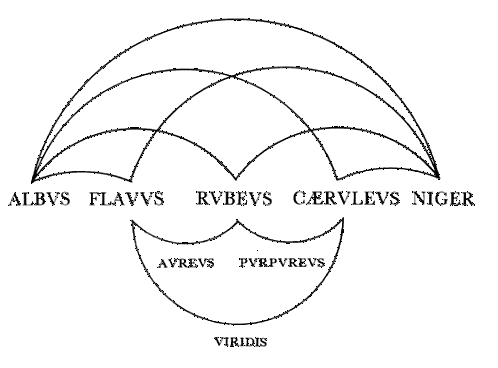
Come colori fondamentali vengono riconosciuti, stando a questo schema, il flavus, il rubeus e il caeruleus: dunque il giallo, il rosso e l’azzurro. Ciascuno di essi è posto in relazione nella parte superiore del grafico con il bianco e il nero. Si noti poi come il nome di ciascun colore venga scritto sugli estremi delle linee semicircolari di connessione. Tuttavia solo il rubeus è equidistante rispetto al nero ed al bianco mentre il ceruleus è spostato verso il nero e il flavus verso il bianco. In forza di questa equidistanza il rosso viene a trovarsi al centro della costruzione grafica. I colori derivati o composti vengono proposti nella parte sottostante della figura, con i nomi di viridis, per il colore composto da flavus e caeruleus, aureus per il colore composto da rosso e giallo, purpureus per il colore composto da rubeus e caeruleus. Si tratta dunque, rispettivamente, di verde, arancione e viola. È infine da notare che i nomi dei colori composti vengono scritti lungo l’arco di congiunzione dei colori semplici corrispondenti.
Tenendo conto di quel diagramma e trascurando per il momento le relazioni con il bianco e con il nero, si può passare senz’altro alla rappresentazione mediante la circonferenza di un cerchio. Su di essa si contrassegneranno anzitutto i punti rappresentativi dei colori semplici e, tra essi, quelli dei colori composti corrispondenti. La rappresentazione potrà poi essere integrata con i gradi di chiarezza e di saturazione cromatica, sviluppando la figura nella terza dimensione e ottenendo così un solido (un doppio cono, una doppia piramide ouna sfera,per esempio) che sarà considerato come rappresentativo dell’intero spazio cromatico.
Ma comunque ne sia dei dettagli della costruzione ideale e delle alternative possibili in proposito, tutti i problemi si trovano già nella decisione preliminare relativa ai fondamenti del sistema. E che vi siano qui dei problemi è mostrato dal fatto che, nonostante l’apparente plausibilità della sistemazione proposta, ci troviamo subito in difficoltà non appena tentiamo di conferire un senso sufficientemente determinato in primo luogo alle nozioni della semplicità e della composizione. Queste espressioni sono or ora state impiegate come se esse potessero essere assunte in un accezione ovvia e ben nota. Ma le cose non stanno così.
Infatti si potrà parlare di semplicità e di composizione in rapporto al colore come materia cromatica oppure al colore come qualità visiva. Ma né nell’uno né nell’altro caso possiamo giungere a una conclusione realmente soddisfacente. Nel primo caso, infatti, il parlare di semplicità in rapporto ai colori giallo, rosso e azzurro significherebbe niente altro che formulare un’ipotesi empirica sulle materie cromatiche, che sarebbe irrilevante ai fini di una considerazione sistematica. Nel secondo caso, al quale del resto pensava Aguilonius, la distinzione stessa diventa fondamentalmente inconsistente, dal momento che verrebbe interamente affidata a contestabili impressioni soggettive attinenti alla semplicità e alla composizione del colore. Sarebbe infatti in errore chi tentasse di rendere conto sul piano fenomenologico di quella differenza, ritenendo che essa possa essere giustificata sul piano della stessa manifestazione cromatica.
Se prescindiamo con buoni motivi dalle mescolanze delle materie cromatiche, sembrerebbe allora che dovrebbe esserci un qualche contrassegno all’interno dell’esperienza visiva che contraddistingua il viola, per esempio, dal giallo e dal rosso. Ma se proponiamo a qualcuno la domanda se il viola gli appaia come colore semplice o composto non solo non potremmo essere sicuri della risposta, ma nemmeno del fatto che la domanda abbia realmente senso e possa essere veramente compresa.
Inversamente potremmo vedere con i nostri stessi occhi che il giallo appare verde attraverso un filtro azzurro, senza che da ciò consegua che l’impressione visiva del verde comporti l’impressione della composizione.
Di fronte a questi dubbi è naturale che una chiara formulazione del problema della semplicità e della composizione venga ricercata piuttosto sul piano esplicativo. Solo prendendo le mosse dalla fisica del colore possiamo attribuire un senso sufficientemente determinato a parole come semplice, composto, fondamentale e derivato, o introdurre altri termini eventualmente ritenuti più appropriati. Assumendo questo punto di vista tenderemo certo a guardare a quella vecchia schematizzazione (e alla sua stessa terminologia) come ad una rozza anticipazione «intuitiva» di una problematica che può trovare il suo assetto autentico solo considerando il colore come evento fisico.
11. Nuova determinazione del problema
Eppure anche il pieno riconoscimento dei diritti conoscitivi e degli interessi tecnico-pratici di un sistema dei colori con un fondamento esplicativo non toglie il sussistere dell’altro aspetto della questione.
Vogliamo allora riconsiderare il problema mettendo drasticamente da parte ogni tentativo di dare un senso, presuntivamente giacente nell’esperienza del colore, alla distinzione tra colore semplice e colore composto. Occorre invece fare riferimento a ciò che nel cerchio cromatico giunge effettivamente alla manifestazione percettiva. Indipendentemente da ogni considerazione relativa alle mescolanze concrete così come alle impressioni psicologiche sulla semplicità e sulla composizione, il cerchio cromatico ci appare come un percorso percettivo che conduce secondo sfumature continue da una tonalità cromatica all’altra, come una sequenza di gradazioni tonali. Ma non solo: questa sequenza ci appare caratterizzata da un proprio ritmo interno i cui accenti cadono proprio su quei colori a cui in precedenza attribuivamo un oscuro carattere di semplicità e di fondamentalità.
Cerchiamo di illustrare il senso di un simile rilievo. Stando a esso, la nostra attenzione non viene attirata sulla natura intrinseca di questo o di quel colore, ma sulla struttura complessiva della sequenza qui in questione. Anzi, prima ancora, attiriamo l’attenzione sul fatto che possono essere date sequenze cromatiche del genere più vario, che vengono colte appunto nelle loro tipiche differenze di struttura. Ma in che modo ciò sarebbe possibile se nell’apprensione stessa non fosse implicato il rimando a una sorta di ordine precostituito nell’essenza della datità cromatica, e dunque ad una localizzazione ben determinata all’interno di un sistema ideale?
Riprendiamo a questo proposito il caso elementare della sequenza cromatico-chiaroscurale. Il bianco e il nero operano la chiusura della sequenza, essi hanno il carattere di polarità estreme. Ma questo carattere non è pura accidentalità empirica, non indica cioè meramente il posto che essi occupano nella sequenza che proprio ora sta di fronte ai nostri occhi. Potremmo dire invece che questa sequenza esibisce il luogo ideale di questi «colori», del bianco e del nero, all’interno dell’universo cromatico.
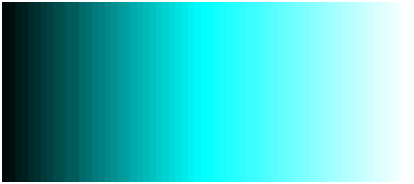
Il dubbio filosofico intorno al diritto di annoverare il bianco e il nero tra i colori veri e propri ha del resto sempre avuto i suoi motivi nella posizione che essi occupano all’interno di una considerazione sistematica.
Naturalmente, il bianco e il nero sono colori come tutti gli altri - se considero le materie cromatiche. Ma possiamo anche dire di una cosa che essa è bianca, oppure nera, volendo con ciò parlare proprio del suo colore. Mentre potrebbe essere giustificato avanzare dubbi sull’impiego del termine, se con ciò si vuole mettere in evidenza la dissoluzione dell’universo cromatico nella chiarezza e nell’oscurità, se cioè si vuole indicare la posizione estrema che il bianco e il nero occupano in via di principio nel sistema. |40|
Se dunque sono in presenza di una sequenza che conduce dal bianco al nero secondo una transizione chiaroscurale del l’azzurro (o di un altro colore qualunque), posso dire che questa sequenza presenta il luogo che spetta «a priori» al bianco e al nero. Ma può ben darsi una sequenza, per esempio, dall’azzurro al giallo attraverso il nero. Questo si trova allora tra l’uno e l’altro colore.
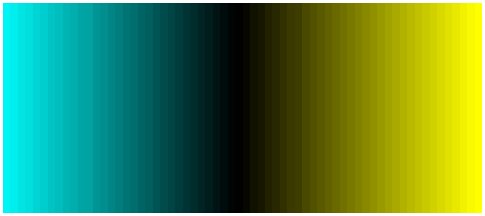
Ma questo luogo di fatto non modifica certamente il suo luogo ideale e anzi proprio in forza del riferimento a questo luogo ideale la sequenza viene appresa come determinatamente caratterizzata da una forma strutturale che la differenzia in maniera tipica da altre sequenze possibili.
Il richiamo all’esperienza della transizione ha appunto il senso di un richiamo alla manifestazione percettiva delle differenze strutturali delle sequenze cromatiche e di conseguenza quell’esperienza può essere proposta in via del tutto generale come base fenomenologica del sistema.
Si comprende allora in che senso possiamo attirare l’attenzione sul ritmo interno del cerchio cromatico: in esso, per esempio, il rosso si trova tra il viola e l’arancione e quest’ultimo tra il rosso e il giallo. Ma la struttura fenomenologica della prima sequenza è interamente diversa da quella della seconda: nel primo caso, il rosso appare come punto di volta verso cui si impennano l’arancione e il viola; nel secondo il cromatismo scorre dal rosso al giallo, o nella direzione inversa.
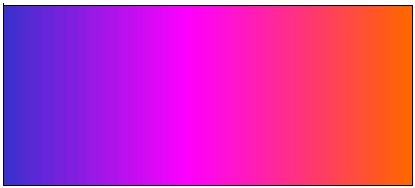
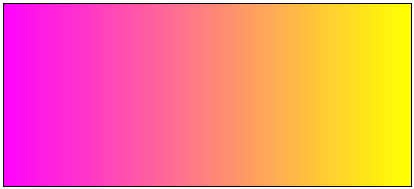
Nonostante i buoni motivi dei dubbi a cui abbiamo accennato, e nonostante il riconoscimento necessario della possibilità di proporre lo stesso problema su una base interamente diversa - e di conseguenza con un significato e uno scopo diverso - non dobbiamo affatto rinunciare alla vecchia idea di un sistema che poggi sulla «fondamentalità» del giallo, del rosso e dell’azzurro. Non si tratta infatti di una idea sbagliata, che va sostituita con una teoria più aggiornata e con la terminologia corrispondentemente mutata. Ma di una idea che può trovare la sua giustificazione in primo luogo mettendo l’accento sull’intervento di procedure di idealizzazione; e in secondo luogo mostrando che le idealizzazioni operate hanno tuttavia la loro base fenomenologica nell’esperienza della transizione e quindi più in generale nelle differenze strutturali, effettivamente sperimentate, delle sequenze cromatiche possibili.
Tutte le discussioni intorno alla nozione della semplicità e della composizione, sia quelle orientate in direzione della fisica del colore come in quella della sua psicologia, vanno coerentemente messe da parte. La circostanza realmente rilevante nel nostro contesto di discorso, è che alcuni punti del cerchio cromatico si propongono come limiti di una sequenza, altri invece come momenti di passaggio. Allo scopo di togliere ogni possibile equivoco potremmo parlare, rispettivamente, di colori terminali e colori intermedi.
Stando a questa impostazione, infine, il tema dell’unità del mondo cromatico si impone in tutta la sua evidenza all’interno delle stesse datità percettive. Ciò che stabilisce un legame tra i colori è in primo luogo la possibilità di stabilire tra l’uno e l’altro una transizione percettiva continua: la possibilità, per esempio, di vedere il rosso trapassare nell’azzurro, diventare azzurro. Si istituisce così una relazione che ha la stessa evidenza di quella che sussiste tra due momenti di una sequenza chiaroscurale di un unico colore.
La molteplicità dei colori si comprime così, idealmente, nella più stretta unità. Anzitutto vi è il Colore. E nel cerchio si rispecchia il suo movimento. Quella rappresentazione infatti non deve essere intesa solo come una statica fissazione di rapporti, ma come se essa mostrasse il divenire del colore.
13. Fenomenologia e naturalismo nella teoria del colore di Goethe
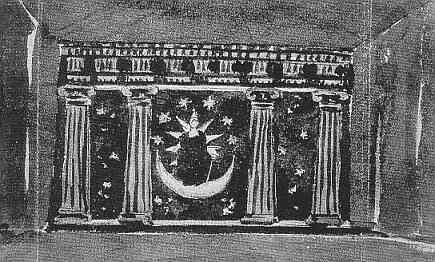
Bozzetto di Goethe per una scenografia del "Flauto Magico" di Mozart
Vi sono diversi motivi che ci suggeriscono di proseguire la nostra discussione prendendo ora in esame la teoria goethiana dei colori[18]. In primo luogo, il libro di Goethe mostra con chiarezza, nella molteplicità degli aspetti che in esso vengono implicati, e anche nelle difficoltà e nei dubbi che solleva la sua lettura, le vicissitudini che può attraversare una teoria del colore che sia investita da interessi filosofici di carattere generale. Siamo qui in presenza di un’opera sbagliata e straordinaria, nella quale l’ingenuità scientifica si mescola con la scienza genuina e il momento ideologico con la discussione teorica e con l’osservazione empirica.
Di fronte ad essa vorremmo anzitutto cercare di mostrare come le nostre considerazioni precedenti ci mettano in grado di farne una lettura produttiva e ci aiutino a cogliere i nodi centrali ed a scioglierne i grovigli.
In rapporto alla posizione che Goethe assume nel suo approccio alla tematica del colore si parla spesso di un atteggiamento fenomenologico implicito. Ma più che l’uso di una simile espressione, ci interessa cercare di individuare le ragioni particolari della possibilità della sua applicazione nel caso di Goethe, proprio perché in queste ragioni essa può ricevere la necessaria determinatezza.
Affrontando questo primo compito, abbiamo subito a che fare con lo sfondo filosofico generale dell’opera, concentrato nelle pagine introduttive che fissano in pochi tratti lo spirito da cui essa è animata. Questo sfondo rimanda al concetto di natura, un concetto che Goethe condivide con così larga parte della cultura romantica, di cui la Teoria dei colori è anzitutto un documento esemplare. La natura come un sistema complesso di leggi, che assumono necessariamente forma matematica e la cui formulazione richiede elaborate costruzioni intellettuali - la natura dunque come «mondo di cose» e precisamente secondo quella nozione della cosa che comporta la soppressione dell’esperienza, come ci siamo espressi in precedenza sottolineando l’inerenza di questo punto di vista alla stessa posizione di scopi conoscitivi - questa nozione di natura non è certamente per Goethe una nozione prioritaria.
Colori e suoni appartengono alla natura scrive Goethe[19]; e molto, se non tutto, il senso della posizione che egli assume dipende proprio dalla comprensione di questa frase.
Colori e suoni sono parti di un intero, di quel grande organismo vivente che è la natura stessa. Essi sono fenomeni naturali in un’accezione pregnante: non semplici eventi invia di principio dominabili all’interno di un sistema unitario di leggi; sono fenomeni nel senso di manifestazioni.
La natura si manifesta in essi; colori e suoni sono espressioni della natura. I fenomeni naturali di cui consta il grande organismo, sono ciò attraverso cui esso ci parla, sono il linguaggio stesso della natura:«e dal più leggero soffio fino al più selvaggio rumore, dal suono più elementare fino al più complesso accordo, dal più veemente e appassionato grido sino alle più miti parole della ragione, sarà sempre la natura a parlare, a rivelare la propria presenza, la propria vita e le proprie connessioni»[20].
Ciò decide fin dall’inizio l’atteggiamento che deve essere assunto nei confronti dei colori. Se essi sono il linguaggio vivente della natura, attraverso la vita dei sensi attraverso l’esperienza sensibile, si deve realizzare un rapporto autentico di comunicazione. Il colore parla e dunque noi dobbiamo sforzarci di comprendere ciò che esso dice. Per fare questo dobbiamo afferrare il fenomeno cromatico in tutta la sua vivezza, così come ci si presenta in tutta la sua forza ai nostri occhi.
Si annuncia in questo modo, nell’intera impostazione goethiana, una tensione verso il qualitativo, verso un sapere legato alla corposità dei fenomeni come una corposità che non può essere affatto ridotta. Ciò che fa del colore una «qualità secondaria», la pienezza che lo caratterizza in quanto datità visiva si propone come tale nella sua validità. E naturalmente già per questo potremmo parlare di un aspetto fenomenologico che si impone con motivazioni proprie che avranno le loro conseguenze nello stesso impianto del problema.
Sono proprio le peculiarità di queste motivazioni che impediscono la consapevolezza dei limiti entro cui deve muoversi una fenomenologia del colore. Fin dall’inizio abbiamo attirato l’attenzione su questo punto: la distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie, nel suo senso classico, è erronea perché riduce ad apparenza illusoria il mondo visibile e tangibile. I risultati delle spiegazioni fisiche possono così essere falsamente proposti come se contraddicessero le datità fenomenologiche. Ma è possibile anche incorrere nell’errore inverso di contrapporre i rilievi descrittivi condotti sulla base della concretezza dell’esperienza come tanto potenti da contestare le ipotesi esplicative. Questo è appunto l’errore di principio di Goethe, attestato dalla sua accanita polemica antinewtoniana.
Goethe non si rassegna alla necessità di considerare la luce, e dunque - per Goethe - la chiarezza, il bianco, come un risultato della fusione di una molteplicità di colori. «Che tutti i colori mischiati producano il bianco è un’assurdità che, accanto ad altre assurdità, si è abituati a ripetere fiduciosi da un secolo, e in contrasto con la testimonianza degli occhi»[21].
Goethe ha certamente ragione, se stiamo appunto alla testimonianza degli occhi. E ha ragione anche nel ritenere che non sia affatto giustificato respingere questa testimonianza come se essa fosse ingannevole. E tuttavia il problema di Newton era intanto quello di fornire una spiegazione soddisfacente della formazione, su uno schermo, di un ordinato cromatismo ad opera di un fascio di luce passante per un prisma di vetro. Escludendo con buoni motivi che una simile formazione possa essere dovuta alla natura del mezzo, è possibile formulare l’ipotesi teorica e apprestare esperimenti di conferma, secondo cui la «luce bianca» sarebbe la risultante di raggi «monocromatici» (e dunque semplici, in un senso ben definito del termine), ciascuno caratterizzato da uno specifico angolo di rifrazione. In tal caso, il dato di fatto della formazione dello spettro risulterebbe spiegato in termini fisici come un processo di scomposizione. La formulazione della ipotesi e i risultati soddisfacenti della sperimentazione corrispondente non ci consentono peraltro di ritenere definitivamente raggiunta l’essenza stessa della luce o del processo fisico di formazione dei colori, dal momento che si pone subito la necessità di chiarimenti epistemologici sulla natura e sulla portata della teoria, la quale a sua volta è destinata a muoversi problematicamente con il movimento stesso degli apparati concettuali entro cui essa è integrata. Ma è certo in ogni caso che quella teoria non può essere semplicemente riportata all’immediatezza fenomenologica e giudicata a partire da essa, ma deve essere lasciata esattamente dove si trova, sul terreno della transfenomenologia.
La presenza, così consistente in Goethe, dell’esigenza di convalidare i risultati della propria indagine anche attraverso la confutazione polemica della teoria newtoniana deriva indubbiamente da un’ambiguità di fondo, da un nodo metodologico destinato a restare irrisolto. Cosicché da un lato è giusto richiamare l’attenzione sul fatto che ci troviamo qui di fronte non già a teorie contrapposte, ma semplicemente a problemi distinti. Dall’altro è altrettanto giusto mettere in rilievo che l’equivoco dipende a sua volta dal modo in cui in Goethe prende forma la rivendicazione della concretezza dell’esperienza cromatica.
Infatti, per Goethe non si tratta soltanto di realizzare una compiuta descrizione di quella esperienza, ma di penetrare attraverso di essa sino all’essenza naturale del colore. In qualche modo, vi è un’istanza naturalistica che si integra strettamente con la fenomenologiadi Goethe e ne specifica la direzione[22].
Di qui deriva anche il dubbio ricorrente sull’impiego dello strumento matematico dello studio dei fenomeni naturali in genere. Se il linguaggio della natura è rappresentato già dai fenomeni naturali sperimentati nella loro concretezza, allora il linguaggio matematico deve essere considerato come un secondo linguaggio che si sovrappone al primo e che rischia di confonderne il senso, qualora il suo impiego non sia accompagnato da opportune cautele[23]. Ogni possibilità di acquisire elementi conoscitivi sarà dunque interamente affidata all’osservazione: a un osservazione attenta, ostinata, minuta, puntuale, incessante, a un’osservazione empirica nel senso più ampio, dalla quale manca tuttavia, per ragioni ben comprensibili, una chiara nozione di esperimento. Non vi è infatti qui propriamente nessuna ipotesi da mettere alla prova, e anche tutti i dispositivi di cui possiamo eventualmente avvalerci hanno come scopo essenziale quello di rendere più acuta l’osservazione stessa. Lo strumento principale di Goethe è proprio questa attenzione osservativa portata alla sua estrema esasperazione: ci accingiamo ora a spiare ogni mossa del colore, a inseguire le sue manifestazioni negli angoli più riposti, non tanto per giungere a rendere conto di esse, quanto piuttosto per arrivare a possederle nel loro senso.
L’importanza della componente naturalistica, nel senso certamente un poco particolare che dipende dal contenuto complessivo del discorso di Goethe, diventa subito chiara se consideriamo l’impianto dell’opera e in particolare se cerchiamo di renderci conto dei motivi per i quali egli prende le mosse dai colori fisiologici.
L’ingente massa di osservazioni minute viene infatti distribuita per l’essenziale nelle prime tre sezioni, ognuna delle quali fa riferimento a un modo di manifestazione del colore, secondo un ordine di sviluppo che richiama l’opposizione tra il materiale e l’immateriale. Anzitutto vengono considerati i colori che Goethe chiama fisiologici intendendo con ciò quelle manifestazioni cromatiche che possono essere considerate come appartenenti essenzialmente all’occhio. Si tratta dunque di manifestazioni eminentemente soggettive, che hanno il carattere della massima fugacità, della precarietà e della transitorietà in quanto sono del tutto libere da vincoli rispetto alla cosa.
All’estremo opposto vi sono invece i colori chimici, considerati nella terza sezione, i colori cioè intesi come proprietà determinante di cose materiali, i colori consolidati sulla cosa e che sono quelli che sono in forza della composizione chimica di essa.
I colori fisici invece, considerati nella seconda sezione, occupano una posizione intermedia tra i colori fisiologici e i colori chimici in quanto hanno un carattere sia soggettivo che oggettivo: non appartengono alla cosa come una proprietà stabile di essa, ma hanno bisogno della cosa per sussistere.
Dal punto di vista concettuale si prende l’avvio dal colore come apparenza evanescente per progredire sempre più verso la cosa - un principio di ordinamento a cui Goethe attribuisce un particolare significato e al quale si attiene anche nell’operare ulteriori sottoclassificazioni, come accade nella sezione dedicata ai colori fisici[24].
Particolarmente significativa è anzitutto la decisione di dare rilievo a quei fenomeni cromatici che si trovano alla massima distanza dalla cosa, che non hanno alcuna consistenza effettiva e alcun rapporto con l’esteriorità. Esempi caratteristici, che offrono una chiara illustrazione della nozione goethiana di colore fisiologico, sono tutti i fantasmi cromatici che sperimentiamo in seguito ad un abbagliamento, all’osservazione prolungata di una figura intensamente illuminata o addirittura quelle formazioni cromatiche che ci appaiono esercitando una pressione delle dita sulle palpebre abbassate. Essi sono colori che sembrano attraversare fugacemente il nostro campo visivo, ma che non hanno in esso nessuna localizzazione obiettiva: essi sono visti per così dire di sbieco, anzi, che in senso proprio non sono visti affatto, sono colti dall’occhio come colori dentro gli occhi.
Che vi siano simili colori ognuno lo deve sapere per conto proprio, dal momento che essi non sono indicabili ad altri, sono colori soggettivi nel senso più stretto e rigoroso. Eppure Goethe si accinge a sottoporre proprio questi colori, che esiteremmo persino a chiamare tali, ad una osservazione sistematica rivendicando anzi fin dall’inizio, e non a torto, l’originalità di questo avvio.
Questi colori, egli osserva, «sono stati finora considerati inessenziali e casuali, alla stregua di illusioni e deficienze. Le loro manifestazioni sono note fin dall’antichità ma, poiché non si poteva avere ragione della loro incostanza, li si relegò tra le apparizioni di natura maligna»[25]. Contro di ciò, e contro le varie denominazioni che rimandano in vari modi ad un presunto carattere patologico, Goethe fa notare che il termine di colore «fisiologico» è stato scelto appositamente per sottolineare che queste manifestazioni cromatiche appartengono al normale funzionamento dell’occhio sano[26]. In questa motivazione del nome, troviamo anche la motivazione dell’interesse che muove Goethe anzitutto in questa direzione. I colori dentro gli occhi sono colori prodotti dall’occhio stesso nella sua relazione con la luce - nulla qui deriva dall’artificio, ma tutto sorge dalla stessa produttività spontanea della natura. Cosicché se, attraverso l’osservazione, riusciamo a individuare qualcosa di simile a regole che presiedono a questa produzione, con ciò arriveremmo forse a cogliere almeno qualche aspetto rilevante dell’intima essenza del colore come fenomeno naturale. La relazione del colore con l’occhio e con la luce potrebbe cominciare a rivelarsi, non già da osservazioni anatomiche o dalla ricostruzione teorica di un processo fisico, ma proprio attraverso una fedele descrizione di questi strani eventi.
Ecco dunque che il momento dell’osservazione fenomenologica si ripresenta in uno stretto legame con il tema dell’essenza naturale del colore, e questo legame rappresenta indubbiamente il tratto caratteristico dell’impostazione goethiana. Di esso dobbiamo in qualche modo cercare di impadronirci se vogliamo pervenire a una comprensione autentica del senso della sua opera.
15. Il colore come valore d’ombra
Non c’è dubbio che la sezione dedicata ai colori fisiologici possa essere indicata come la parte meno compromessa con le prese di posizioni generali più impegnative e discutibili dell’opera e la più ricca di osservazioni particolari e di spunti geniali che possono essere particolarmente apprezzati dal punto di vista psicologico come anticipazioni di problemi che solo in seguito riceveranno un’elaborazione effettiva.
Tuttavia a noi interessa non tanto isolare questa sezione da tutto il resto, ed eventualmente, all’interno di essa, quei pochi, benché significativi momenti che possono essere valorizzati in questa direzione, quanto piuttosto mostrare il filo conduttore che tiene insieme le osservazioni empiriche e la connessione di esso con l’atteggiamento mentale da cui sono orientate.
Questo filo conduttore è rappresentato dal tema della opposizione e del contrasto, e ciò ci riconduce ancora una volta alla concezione della natura come totalità vivente e onnicomprensiva. Fa parte di questa concezione l’idea di una dialetticità interna, nel senso più ampio, che rimanda a un gioco di opposizioni, di azioni e reazioni, di complessi equilibri e di contrasti, di tensioni e di compensazioni, di attrazioni e repulsioni. Uno degli aspetti più sorprendenti dell’indagine di Goethe è il modo in cui una simile concezione di carattere generale, un simile sentimento della natura si specializzi fino al più infimo dettaglio, che riceve così una improvvisa ricchezza di significato, un valore esemplare.
Che cosa accade se entriamo in una stanza completamente buia? «Avvertiamo subito un senso di privazione» [27]E inversamente «se ora rivolgiamo l’occhio verso una superficie bianca, fortemente illuminata, esso viene abbagliato e, per un certo tempo, rimane incapace di distinguere oggetti moderatamente illuminati»[28].
Osservazioni come queste vengono subito riscattate dalla loro apparente insignificanza proprio perché manifestano la presenza di una sorta di legge della visione che rimanda al tema del contrasto e del ripristino della totalità attraverso il richiamo dall’uno all’altro polo dell’opposizione. In quel senso di privazione vi è già il richiamo dallo scuro al chiaro; così come dal chiaro allo scuro, nel ritrarsi dell’occhio di fronte a una luce troppo viva.
Questa opposizione della chiarezza e dell’oscurità, del bianco e del nero è destinata ad avere un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo della tematica del colore, così come nello stesso orientamento dell’osservazione empirica.
Il colore in generale sta tra il bianco e il nero - e perciò esso significa dettaglio, specificità, varietà, individuazione. In questo senso Goethe ripete più volte, e in vari modi, che il colore ha un valore d’ombra [29]. Attraverso il colore si disegna la forma - «in quanto soltanto chiaro, scuro e colore stabiliscono insieme ciò che distingue un oggetto dall’altro e la parte di un oggetto dalle altre. Sulla base di questi tre momenti costruiamo il mondo visibile»[30]. «Il chiaroscuro fa apparire il corpo come corpo, in quanto luce e ombra ci danno nozione della materialità»[31]. Nello stesso tempo nel colore dobbiamo cogliere la stessa molteplicità e varietà della vita e perciò possiamo dire che «ogni essere vivente tende al colore alla specificazione», mentre «ogni ente privo di vita si muove verso il bianco, verso l’astrazione, verso la generalità, verso la trasfigurazione, verso la trasparenza»[32].
Ma già nelle affermazioni iniziali questo trovarsi del colore tra il bianco e il nero tende ad assumere un’inclinazione che potrà apparirci subito arrischiata. Goethe presenta infatti fin dall’inizio il rapporto del colore con il bianco e il nero come un rapporto «genetico» in un qualche senso che subito non riusciremmo affatto a precisare. Dal bianco e dal nero è come se si avviasse un duplice movimento, di scurimento e di schiarimento, e proprio di qui avrebbe origine il colore. In qualche modo è l’incontro del bianco con il nero che genera il colore.
Per il momento queste formulazioni non possono che sembrarci oscure: si avvia forse qui un’astrusa speculazione che vorrebbe riprendere dal passato la vecchia teoria aristotelica, ripetuta lungo tutto il Medioevo e poi finalmente dimenticata, secondo la quale i colori sorgerebbero per mescolanza del bianco e del nero secondo rapporti numerici determinati? E se non questo, che altro allora? In che senso si deve intendere il fatto che si parli qui di origine? In che modo quelle formulazioni possono avere una qualche giustificazione?
16. I fenomeni di inversione cromatica
Nessuna risposta a questa domanda possiamo ritrovare nella sezione dedicata ai colori fisiologici. Qui si procede positivamente nell’osservazione diretta a cui il tema dell’opposizione chiaroscurale offre unicamente il materiale su cui esercitarsi. Si presentano così in essa significative considerazioni sui rapporti figura-sfondo, realizzate con figure elementari bianche e nere, e si ordinano all’interno di un quadro sistematico osservazioni in parte note, in parte nuove e originali: ed è comunque notevole già in se stessa l’idea di un’indagine sistematica rivolta agli effetti contestuali delle apparenze fenomenologiche concernenti sia l’aspetto figurale o dimensionale, sia i valori cromatici e chiaroscurali.
Nello stesso tempo una simile indagine è solo preparatoria rispetto al tema delle manifestazioni fisiologiche vere e proprie, che entrano in campo soltanto nella considerazione dei fenomeni di inversione. Anzitutto tra il bianco e il nero: se guardiamo intensamente, dall’interno di una stanza, una finestra illuminata dalla luce del giorno, come immagine consecutiva non si proporrà solo l’immagine della crociera, ma questa immagine con l’inversione dei valori chiaroscurali: «La crociera apparirà chiara e lo spazio del vetro scuro»[33].
A questi fenomeni di inversione fisiologica Goethe è straordinariamente interessato, e per motivi che ormai ci sono noti. L’occhio si mantiene in una determinata situazione percettiva in modo dinamico, cioè proponendo l’opposizione immanente nel dato percettivo e ricostituendo così di continuo la totalità di cui sente la mancanza: «L’occhio di una persona desta - egli scrive - esprime la sua vitalità in modo particolare nel fatto che esso richiede un mutamento delle proprie condizioni passando, nel caso più semplice, dallo scuro al chiaro, e viceversa. L’occhio né può né vuole neppure un istante restare identico nella condizione specifica a cui è determinato all’oggetto. Esso è invece costretto a una sorta di opposizione che, mentre contrappone termine estremo a termine estremo e termine medio a termine medio, contemporaneamente congiunge quanto ha contrapposto e nella successione, così come nella contemporaneità e nella coesistenza, tende verso un intero»[34].
A questo motivo di carattere generale se ne aggiunge uno più particolare che riguarda non più l’opposizione bianco-nero, ma i fatti cromatici veri e propri. Se infatti poniamo un pezzo di carta colorata rossa su un fondo bianco, se lo osserviamo abbastanza a lungo e poi togliamo la carta rossa, sul fondo bianco lasciato scoperto apparirà una distinta immagine «fisiologica» verde[35]. E lo stesso «esperimento» può essere ripetuto per le coppie giallo-viola e azzurro-arancione.
Per comprendere il rilievo che Goethe conferisce a questa circostanza converrà ricollegarsi al cerchio cromatico.
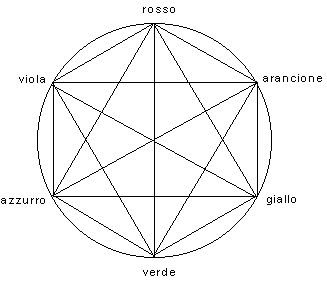
Facendo riferimento unicamente ad esso potremo subito notare che proprio queste coppie sono tra loro connesse da una determinata relazione strutturale che è rispecchiata nella rappresentazione grafica dal fatto che i punti corrispondenti, e solo essi, possono essere connessi tra loro attraverso diametri. Ciò dipende naturalmente soltanto dall’ordinamento dei colori terminali e intermedi - il quale peraltro non è un ordinamento arbitrario, ma poggia sulle datità fenomenologiche. La connessione diametrale nel cerchio indica pertanto che non è possibile alcuna sequenza continua dal rosso al verde nello stesso modo in cui è possibile una sequenza continua dal rosso al giallo o dal rosso all’arancione. Il sussistere di una simile relazione di tipo peculiare non ha bisogno di essere dimostrato empiricamente e tanto meno di essere interpretato in termini psicologici. Vi è dunque una precisa differenza di principio tra il rilievo del sussistere della relazione di connessione diametrale effettuato sulla base di considerazioni fenomenologico-strutturali e la constatazione empirico-psicologica dell’evocazione fantomatica dell’un colore da parte dell’altro in un caso particolare di atto percettivo concreto.
Questa differenza può essere resa chiara sottolineando che è possibile effettuare quell’«esperimento» prendendo atto del sussistere di una simile connessione di fatto senza saperne nulla della connessione diametrale, e inversamente è possibile rilevare quest’ultima senza saperne nulla della connessione rilevata nell’«esperimento». Va da sé che distinguendo l’un caso dall’altro escluderemo che la situazione sperimentata possa essere proposta come una sorta di verifica empirica del sussistere della relazione sistematica, dal momento che questa non ha bisogno di alcuna verifica empirica.
Come stanno ora le cose in Goethe? In realtà abbiamo già spiegato che Goethe non ha affatto di mira una logica del colore fenomenologicamente fondata, ma la natura del colore in quanto essa può essere colta nell’osservazione immediata. Di conseguenza il modo di valutare il problema segue un’angolatura interamente diversa. In primo luogo, la comparsa introspettiva del colore diametrale viene intesa come un caso vero e proprio di inversione, dunque la relazione tra quelle coppie cromatiche interpretata come una relazione oppositiva; in secondo luogo, la constatazione di una simile evocazione di fatto dall’uno all’altro polo dell’opposizione sembra conferire un senso ben più ricco alla relazione stessa in quanto proposta unicamente sulla base di considerazioni sistematiche. Constatata all’interno della percezione visiva, essa non è più una relazione in certo modo astratta, ma diventa significativa in rapporto all’essenza naturale del colore.
Ma vi è anche un altro aspetto della questione che procede nella direzione inversa: la sistemazione dei colori nel cerchio, che - a quanto sembra - ci insegna che vi sono solo tre colori «semplici», sembra a sua volta arricchire di senso l’evocazione fattuale dei colori diametrali. Poiché il verde, per esempio, secondo lo schema proposto, si presenta come «composto» dal giallo e dell’azzurro, l’evocazione fisiologica del verde da parte del rosso può essere considerata come una evocazione del sistema nella sua totalità.
Si fa avanti così l’idea che le circostanze osservate in rapporto alle comparse fisiologiche dei colori diametrali non siano solo di notevole importanza per illustrare i meccanismi psicologici della percezione, ma che attraverso di esse si possa dare consistenza al problema dell’«armonia dei colori», avviandolo a una soluzione ben fondata.
I colori fisiologici «che legittimamente collochiamo qui all’inizio - osserva Goethe in apertura della sezione - costituiscono il fondamento dell’intera teoria e svelano quella armonia cromatica che è tema di tante dispute»[36]. E nella chiusa:
«L’occhio richiede qui... una totalità, e serra in se stesso il cerchio dei colori... Vedremo più avanti per quale via da questi fenomeni si derivi la teoria dell’armonia dei colori e come soltanto per queste proprietà il colore è adatto ad un impiego estetico»[37].
17. Riproposta delle considerazioni sistematiche
Siamo venuti così a riparlare dei colori considerati da un punto di vista sistematico. Questo problema non solo è tutt’altro che assente dal libro di Goethe, ma potrebbe essere considerato come uno dei suoi centri, come uno dei suoi motivi conduttori che conferiscono unità all’enorme massa di osservazioni sparse. Più precisamente: il sistema nella forma che abbiamo descritta, con l’individuazione dei colori rosso-giallo-azzurro a titolo di colori «fondamentali» e dell’arancione-verde-viola a titolo di colori «derivati», è senz’altro presupposto come una nota ovvietà, la quale ha tuttavia bisogno di una interpretazione ulteriore. E gli elementi essenziali della tematica goethiana possono essere considerati come finalizzati a presentare questa interpretazione più profonda, a fornire una sorta di seconda lettura di quell’ordinamento sistematico - una lettura strettamente integrata nel contesto teorico e osservativo che abbiamo cominciato con il delineare. Il «cerchio» di per se stesso non è affatto importante, non è realmente significativo: esso comincia ad assumere rilievo proprio nel momento in cui possiamo dire che l’occhio lo racchiude in se stesso, quando dunque quell’astratta costruzione rappresentativa arriva a congiungersi con la concretezza dell’esperienza del colore. Considerato da questa angolatura, esso ci si presenta in modo diverso, richiede di essere nuovamente interpretato, riceve ulteriori determinazioni che non sono direttamente contenute in esso.
Lo abbiamo visto or ora a proposito della connessione diametrale. Attraverso l’esperienza, questa relazione diventa una relazione di opposizione dinamica nella quale il cerchio comincia ad agitarsi. Ma prima ancora, ciò che segnala l’intervento di una prospettiva interpretativa è naturalmente la stessa concezione del colore come valore d’ombra, quindi la proposta del bianco e del nero come polarità oppositiva fondamentale. Tra questi due poli, e nell’incontro di essi, come ci esprimevamo in precedenza, si trova il colore. E ora possiamo aggiungere, più precisamente, che nelle immediate prossimità del bianco si trova il giallo, nelle immediate prossimità del nero si trova l’azzurro. Oppure, in termini genetici: dal bianco ha origine anzitutto il giallo, dal nero l’azzurro. E ancora: il giallo è un colore essenzialmente chiaro, l’azzurro invece un colore essenzialmente scuro. Dalla polarità oppositiva fondamentale scaturisce infatti, secondo Goethe, questa nuova opposizione polare che si avvia a diventare il fulcro della lettura goethiana del cerchio cromatico.
Ma che cosa possiamo intendere con tutto ciò, in che modo questa opposizione deve essere intesa e in che modo può essere giustificata? Se ci atteniamo alle nostre considerazioni precedenti intorno al sistema, appare chiaro che una sequenza che conduca dal bianco al nero attraverso il giallo è altrettanto possibile quanto lo è una sequenza che conduca dal bianco al nero attraverso l’azzurro. Ciò significa che nella rappresentazione grafica potremo convenire che i colori siano rappresentati con un grado di chiarezza corrispondente a un grigio medio; e in generale appare ovvio che a un qualunque grado di chiarezza del giallo potremo in via di principio associare un grado di azzurro esattamente corrispondente. Se le cose stanno così, allora non vi è nessun motivo per affermare che il giallo sta dalla parte del bianco e l’azzurro dalla parte del nero.
Tuttavia vi è qualcosa anche a partire dagli impieghi linguistici che sembra dare un senso all’osservazione goethiana. Parlare di un «giallo scuro» sembra assai singolare - sembra quasi un controsenso, e forse potremmo sostenere che un giallo scuro non riusciremmo nemmeno ad immaginarlo. Cosicché è possibile che che di fronte a una sequenza del tipo indicato che contenga tutte le gradazioni chiaroscurali del giallo, se fossimo richiesti di indicare il giallo, non indicheremo il punto medio della sequenza, ma un punto spostato verso il polo bianco. La parola «azzurro», nell’impiego corrente, si riferisce ad una tonalità certamente piuttosto chiara, a differenza del «blu» che che si riferisce ad una tonalità tendenzialmente scura. Ma l’un termine sta sulla scia dell’altro. «Azzurro scuro» - quindi blu - è invece una possibilità implicitamente riconosciuta.
Tuttavia questo argomento linguistico è indubbiamente molto debole. Va segnalata inoltre la possibilità che la connessione del giallo con il bianco e dell’azzurro con il nero possa essere suggerita da una nozione di «luminosità» che non ha propriamente a che vedere con la chiarezza ed i suoi gradi, quanto piuttosto con il «calore» del colore. Se guardiamo un paesaggio attraverso un filtro giallo non accade solo la modificazione corrispondente dei colori delle cose, ma il paesaggio ci appare più «luminoso», come se fosse animato da un soffio di nuova energia. Di contro, l’impressione complessiva del paesaggio muta completamente se lo osserviamo attraverso un filtro azzurro. Ora il paesaggio si è in qualche modo incupito, si è smorzato, ha subito una sorta di offuscamento, di perdita di brillantezza e di vivacità.
Questi aspetti, che appartengono anch’essi a una fenomenologia concreta del colore, sono presenti sullo sfondo dell’impostazione di Goethe, e sono certamente destinati a emergere in primo piano nel suo sviluppo. Ma il modo in cui egli giustifica l’opposizione polare tra il giallo e l’azzurro e la dipendenza di essa dall’opposizione tra il bianco e il nero è fondamentalmente diverso.
18. La teoria dei mezzi torbidi
Volendo riferire sulle ragioni di Goethe intorno a questo problema dobbiamo anzitutto accennare alla cosiddetta teoria dei mezzi torbidi. Non già perché in essa si trovi il punto centrale di sostegno della posizione assunta, ma al contrario per potercene sbrigare al più presto e passare oltre.
La proposta di quella teoria infatti è significativa soprattutto perché rivela con particolare chiarezza l’ambiguità metodologica che resta alla base dell’impostazione goethiana. Il motivo fenomenologico si attenua qui quasi al punto da dissolversi interamente, mentre la pretesa di avanzare una vera e propria ipotesi esplicativa sull’origine dei colori, che intende in qualche modo contrapporsi sul terreno conoscitivo alle teorie newtoniane denuncia apertamente il proprio primitivismo.
Lo scopo della teoria è in realtà quello di articolare sul piano empirico l’indicazione suggestiva dell’origine dei colori dal chiaro e dallo scuro, dove la parola origine assume una spiccata accentuazione genetico-causale. Per questo l’area delle considerazioni fenomenologiche, sia pure nel senso più lato del termine, viene ampiamente oltrepassata e l’intera proposta teorica appare, tutto sommato, come un momento spurio, difficile da inserire organicamente nello sviluppo problematico nel suo complesso e indicativo dunque solo di una difficoltà metodologica pregiudiziale.
Un simile tentativo di articolazione passa attraverso la nozione di mezzo torbido. L’aggettivo «torbido» deve essere inteso in primo luogo in un accezione del tutto corrente. Torbido si oppone a limpido, trasparente: l’acqua viene detta torbida quando è piena di pulviscolo che impedisce di vederne chiaramente il fondo. Torbido è ciò che sta tra la perfetta trasparenza e la completa opacità.
Saranno allora esempi di mezzi torbidi la nebbia, il fumo, il vetro affumicato[38]. Ma poiché la perfetta trasparenza rappresenta solo un limite ideale che può essere riferito solo alla nozione della pura immaterialità saranno mezzi torbidi naturalmente l’aria oppure il vetro - anche l’aria più limpida o il vetro più libero da impurità.
Questo tema della torbidezza si incontra ora con l’opposizione di chiaro e scuro. E il colore sorgerebbe dall’interposizione di mezzi torbidi rispetto al chiaro ed allo scuro.
Consideriamo, per esempio, le montagne in lontananza. Esse sono in realtà grandi masse nerastre [39],e tuttavia ci appaiono azzurrine proprio per via del mezzo torbido, cioè del velo atmosferico. Oppure pensiamo semplicemente all’azzurro del cielo. Al di là dell’atmosfera vi è l’oscuro spazio infinito che ci appare azzurro proprio perché vi è tra il nostro occhio e quella oscurità l’interposizione di un mezzo torbido[40]. Inversamente, una montagna bianca, coperta di neve, un iceberg, se visto di lontano e attraverso la nebbia, ci apparirà giallastro [41] - così almeno ci assicura Goethe.
In questo modo forniamo una spiegazione autentica per la formazione dell’opposizione polare dell’azzurro e del giallo a partire dal nero e dal bianco, e Goethe pensa che elaborando a fondo questo spunto, si possa arrivare a fornire una spiegazione soddisfacente della formazione dei colori in genere: «Da un lato la luce, il chiaro, dall’altro la tenebra, lo scuro; poniamo tra le due la torbidezza e da questi opposti, con l’aiuto delle mediazioni di cui abbiamo detto e ancora in un’opposizione si sviluppano i colori...»[42].
Una spiegazione autentica, beninteso, soltanto nelle intenzioni. Per il resto, la nozione di torbidezza, attinta dall’esperienza quotidiana resta tanto generica nel tentativo di operare una generalizzazione da rendere a malapena possibile una discussione.
Non deve peraltro sfuggire che una simile teoria, presentata in buona sostanza come una ipotesi esplicativa, può essere intesa invece come una sorta di variazione immaginativa sul tema del colore come valore d’ombra. La generalizzazione del concetto della torbidezza introduce nel contesto di queste considerazioni il momento della materialità. Che la trasparenza perfetta rappresenti solo un limite ideale significa, in particolare, che nessun mezzo materiale può essere perfettamente trasparente. La torbidezza diventa allora un indice essenziale della materia stessa. Ciò che genera il colore è l’impatto della visione con la materialità. Senza questa mediazione della materia, il mondo ci apparirebbe solo in bianco e in nero - dunque interamente privo della vita stessa, che il colore esprime proprio in quanto l’ombra è la sua essenza.
19. Là dove il colore comincia con l’apparire
Goethe non solo non insiste più del necessario sulla teoria dei mezzi torbidi presentandola spesso solo come uno spunto grezzo che attende un’elaborazione effettiva, ma soprattutto riprende lo stesso problema da un’angolatura interamente diversa. La sua soluzione, o meglio il suo senso deve essere ricercato in tutt’altra direzione che in quella della teoria dei mezzi torbidi, e precisamente nell’ambito delle considerazioni relative ai colori «prismatici» che si presentano all’interno della seconda sezione[43]. Qui si trova anzi il centro effettivo dell’intera opera, nella quale i diversi motivi che la ispirano trovano modo di entrare in una singolare confluenza l’uno con l’altro.
Come abbiamo già osservato, la seconda sezione è dedicata nel suo complesso ai colori fisici, cioè ai colori che, pur non essendo inerenti alla cosa, hanno bisogno della cosa per sussistere.
Per comprenderne la nozione converrà ricollegarsi agli esempi. All’interno dei colori fisici, e come specie di essi, abbiamo anzitutto le apparizioni cromatiche dovute a fenomeni di riflessione della luce su superfici lucide (colori catottrici), che sono indubbiamente le più fugaci e che si possono cogliere solo assumendo una determinata angolatura della visione, per giungere attraverso numerosi casi intermedi sino a quei colori che sorgono per via di processi di ossidazione o di arroventamento e che tendono a fissarsi stabilmente sulla cosa (caso estremo dei colori epottici, nel quale stiamo ormai debordando sul terreno dei colori chimici). Tra i casi intermedi vi sono quelle manifestazioni cromatiche che si possono talora scorgere ai margini e agli spigoli delle cose in particolari circostanze di illuminazione (colori parottici), così come i colori che possiamo osservare guardando attraverso prismi di vetro (colori diottrici).
Anche un semplice ragguaglio intorno a una simile classificazione mostra in che direzione è orientata l’attenzione osservativa di Goethe, che cosa propriamente egli osserva e soprattutto che cosa cerca in questo osservare. Tutta la teoria deve essere costruita indipendentemente da considerazioni attinenti alle materie cromatiche e in particolare alla produzione artificiale dei colori attraverso le mescolanze tra i pigmenti. Per questo d’altra parte abbiamo preso le mosse dai colori fisiologici: proprio in quanto essi sono produzioni spontanee dell’occhio, possiamo sperare di cogliere in essi qualcosa che riguarda la natura stessa del colore. Ora abbiamo abbandonato questo terreno, non cerchiamo più di guardare dentro i nostri occhi, ma il nostro sguardo si volge intorno non già per arrestarsi e acquetarsi sulla superficie stabile e variopinta delle cose, ma per cogliere il colore nelle sue apparizioni minime e momentanee.
In realtà cerchiamo il colore dove esso non c’è affatto, dove non c’è ancora. Fissiamo, per esempio, una corda di acciaio appesa davanti a una finestra illuminata [44] in attesa di intravedere scintille di colore sprizzare da essa nel punto in cui viene colpita da un raggio di sole. Oppure giriamo e rigiriamo tra le nostre mani, torcendo la testa alla ricerca dell’inclinazione adatta, un piatto di rame variamente arabescato per scoprire che «sotto una certa angolazione appaiono nell’occhio colori cangianti, specialmente dei verdi e dei porpora»[45];oppure indugiamo a lungo a descrivere i cromatismi che sorgono ai bordi delle fessure[46],sui vetri appannati [47]o sui fiori di ghiaccio che si formano sui finestrini della nostra diligenza[48].E naturalmente non potremo certo trascurare i colori delle bolle di sapone [49] che cercheremo anzi di sottoporre a una descrizione accurata; così come ci potrà accadere di sprofondarci nella contemplazione della schiuma della cioccolata, nelle cui bolle, a quanto sembra, i colori si possono osservare ancora meglio che nel caso delle bolle di sapone[50].
Qual è dunque il tema vero e proprio dell’osservazione di Goethe? Abbiamo detto prima: qui il colore non c’è affatto, ma comincia a esserci. Ciò che vogliamo afferrare è l’apparire stesso del colore, il momento in cui il colore, che prima non c’è, si presenta all’improvviso sotto i nostri occhi. Vogliamo sorprendere il colore nell’istante della sua nascita.
Tutti i casi considerati negli esempi potrebbero essere caratterizzati come fenomeni di insorgenza cromatica come fenomeni cioè in cui il colore si produce spontaneamente, naturalmente, in rapporto ai quali possiamo parlare di origine del colore, senza che una simile espressione comporti un rimando a un processo fisico causale.
Tra essi, debbono certamente occupare una posizione eminente le manifestazioni cromatiche che si presentano guardando attraverso il prisma. L’insorgere del colore è qui particolarmente vistoso, particolarmente eclatante. Secondo la classificazione indicata, i colori prismatici occupano (come esempi di colori diottrici) il terzo posto nell’ordine, per via della loro particolare stabilità, ma l’esposizione di Goethe comincia senz’altro da essi, perché da essi dobbiamo trarre le indicazioni decisive.
20. Guardando attraverso il prisma
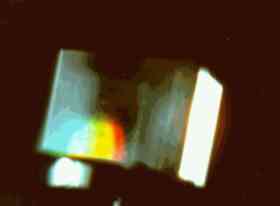
E con Goethe dobbiamo accingerci anche noi a guardare attraverso il prisma. Dobbiamo farlo veramente, perché solo in questo modo è possibile cogliere lo spirito delle sue minute descrizioni ed esserne in qualche modo compartecipi. Guardandoci attorno, con l’occhio appiccicato al piccolo pezzo di vetro, non possiamo trattenere la meraviglia e la sorpresa di fronte a un mondo improvvisamente arricchito di vividi cromatismi: attraverso il prisma, vediamo le cose letteralmente grondanti di colore, di un colore che esse non hanno.
E così Goethe si getta avidamente nell’osservazione dello strano mondo cromatico che il prisma ci offre - certamente con la convinzione che una tanto vistosa apparizione del colore non sia semplicemente una circostanza che richiede una spiegazione, ma un fenomeno affatto peculiare: forse esso mette sotto i nostri occhi ciò che è normalmente nascosto, in esso sono forse contenute tutte le risposte alle nostre domande.
Ci siamo interrogati sull’essenza del colore come fenomeno naturale, quindi anche intorno all’origine del colore. In che modo sorge il colore in quanto è spontaneamente prodotto dalla natura stessa? E non è forse vero che questa origine ci viene mostrata ora nell’osservazione dei fenomeni prismatici? Qui il colore ci appare nella ricchezza delle sue possibili sfumature, e inoltre lo possiamo rimirare in tutta tranquillità dal momento che esso non è più soltanto una comparsa fugace e istantanea, ma possiamo ripristinare in ogni momento le condizioni per il suo sorgere.
Cosicché dapprima gettiamo uno sguardo pieno dì meraviglia dentro il prisma, restando affascinati da quei sorprendenti cromatismi: ma poi ci accingiamo a un osservazione accurata e sistematica. Allora ci rendiamo ben presto conto che la produzione del colore non è arbitraria e accidentale e nemmeno segue da cause oscure, ma si attiene invece a regole semplici e ricche di significato che si possono cogliere sulla superficie del fenomeno stesso. Perciò possiamo pensare di trovarci di fronte a un fenomeno che lascia finalmente trasparire l’essenza stessa delle manifestazioni cromatiche, a un fenomeno che, nel suo stesso manifestarsi, contiene la propria spiegazione.
Proprio a questo punto Goethe impiega uno dei termini più caratteristici della sua speculazione filosofica, il termine di fenomeno originario. |120|
Si parla di fenomeni originari nel caso di quei fenomeni nei quali «non vi è nulla che li oltrepassi e permettono anzi, dopo essere saliti fino a essi, di scendere sino al caso più comune dell’esperienza quotidiana» [51].
In questo tema, come è facile comprendere, confluiscono tutte le istanze di carattere generale che erano alla base del problema goethiano. In primo luogo, naturalmente, quella tensione verso il concreto, verso il momento qualitativo dell’esperienza da cui abbiamo fin dall’inizio fatto dipendere la componente fenomenologica. Ma la nozione di fenomeno originario precisa e determina il modo in cui questa componente e interamente risucchiata entro una matrice «naturalistica».
In questa fenomenologia non si tratta semplicemente di osservare e di descrivere ciò che è stato osservato, eventualmente fissando con chiarezza la reciproca autonomia del piano descrittivo e del piano esplicativo, ma di andare anzitutto alla ricerca di quei fenomeni inderivabili che aprono per ciò stesso la via ad una comprensione autentica.
L’accento sulla irriducibilità del fenomeno contiene così anche la riconferma dell’atteggiamento polemico nei confronti della riduzione fisicalistica - il tema così spesso ricorrente nel testo dello scambio tra ciò che è derivato e ciò che è originario - così come il dubbio nei confronti della trasposizione linguistica dei fenomeni naturali che debbono invece essere anzitutto colti nella loro immediatezza e pienezza intuitiva: «Qui in luogo delle manifestazioni non vengono posti segni arbitrari, lettere e altre cose a piacimento. Qui non vengono offerti modi di dire che si possono ripetere cento volte senza veramente che si dia qualcosa da pensare a qualcuno. E invece questione di manifestazioni che si debbono avere presenti dinanzi agli occhi del corpo e dello spirito per poter mostrare con chiarezza la loro nascita e la loro derivazione dinanzi a sé e agli altri» [52].
21. Il colore appare là dove il bianco si incontra con il nero

Ma che cosa si vede mai, guardando dentro il prisma, che ha colpito a tal punto la fantasia di Goethe?
Intanto, non appena ci accingiamo ad un’osservazione analitica tendente a cogliere precise regole fenomenologiche per la comparsa dei colori prismatici, dobbiamo subito prendere nota del fatto che essi sorgono lungo i contorni degli oggetti e delle forme. E le ragioni per le quali un simile dettaglio può apparire estremamente significativo diventano subito chiare: considerato come pura apparenza percettiva, il contorno non è altro che uno scarto chiaroscurale, vi è contorno solo se vi è contrasto.
Cosicché ci deve apparire subito significativo il fatto che, laddove la produzione stessa del colore si esibisce originariamente sotto i nostri occhi, essa riveli una sorta di legame intrinseco con l’opposizione tra il chiaro e lo scuro, tra il bianco e il nero. Il colore sorge nel punto in cui il bianco si incontra con il nero. Ecco che allora l’essere del colore tra l’uno e l’altro assume un senso interamente nuovo.
A questa prima regola, ne seguono altre che riguardano l’ordine e la disposizione dei colori tra loro e nel rapporto con il bianco e il nero e che ci consentono di entrare ancor più nel dettaglio.
Una volta che abbiamo notato che il colore si forma lungo il contorno degli oggetti e che il fenomeno è tanto più vivido e intenso quanto più aumenta il contrasto, ci disponiamo nelle condizioni più agevoli per l’osservazione servendoci di figure elementari bianche su sfondo nero e nere su sfondo bianco.
Osservando, per esempio, un cerchio bianco su sfondo nero i colori assumeranno sul cerchio una disposizione caratteristica che merita di essere descritta nel dettaglio.
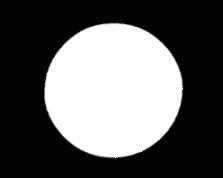
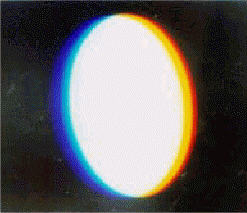
La zona centrale del cerchio apparirà ancora bianca, mentre sul lato destro, al confine con il nero dello sfondo, ma senza debordare in esso, apparirà una orlatura di colore arancione intenso e nella parte più interna apparirà una zona gialla. La regione giallo-arancione si presenta percettivamente come interamente diffusa sulla superficie bianca del cerchio.
Consideriamo ora come stanno le cose sul lato opposto quindi sul lato sinistro. Qui avremo verso l’esterno del cerchio una zona blu-viola (che chiameremo semplicemente viola) tendenzialmente sconfinante verso lo sfondo nero. A ridosso di essa, verso la zona interna del cerchio, vi è invece una zona azzurra. L’impressione percettiva della regione azzurro-viola è dunque che essa si diffonda a partire dal cerchio verso lo sfondo nero.
Il cerchio ci appare articolato in due regioni cromatiche ben differenziate, la regione giallo-arancione e la regione azzurro-viola che si presentano come regioni localmente opposte. Naturalmente il fatto che l’una si presenti sul lato destro e l’altra sul lato sinistro dipende unicamente dalla disposizione del prisma: ma ruotando il prisma e modificandone l’orientamento si avrà una modificazione coerente e corrispondente delle regioni. Questa opposizione locale è in certo senso rafforzata dall’opposizione rispetto al bianco ed al nero dunque rispetto alla figura e allo sfondo. La regione giallo-arancione appartiene interamente alla figura bianca; la regione azzurro-viola allo sfondo nero.
Invertendo il rapporto tra figura e sfondo - cioè assumendo per esempio un cerchio nero su sfondo bianco si ha una inversione simmetrica e corrispondente di questi rapporti: la regione giallo-arancione ci apparirà interamente diffusa sullo sfondo chiaro (verso il bianco), con la zona gialla nella parte più esterna, mentre la regione azzurro-viola si presenterà diffusa sulla superficie del cerchio nero (verso il nero), e precisamente avremo l’azzurro al confine con lo sfondo bianco e il viola nella parte più interna.
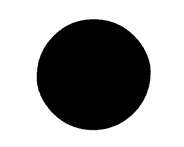
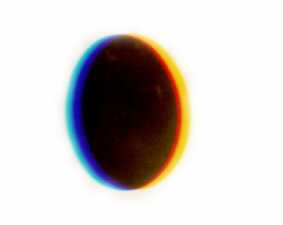
Accingiamoci ora a osservare una striscia rettangolare bianca su fondo nero, non troppo larga. La zona bianca centrale tenderà a contrarsi nell’approssimarsi della zona gialla e di quella azzurra, fino alla «sovrapposizione» dell’una con l’altra. In luogo del bianco abbiamo ora il verde.
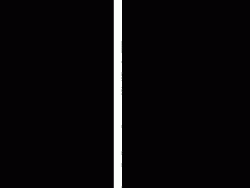

Naturalmente in un cerchio bianco su fondo nero, se il giallo si sovrappone all’azzurro, si avrà una zona centrale gialla e verde.
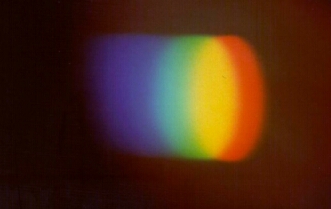
Inversamente, nel caso di una striscia rettangolare nera su sfondo bianco, la compressione della zona nera centrale porterà all’approssimarsi della zona arancione con quella viola, fino alla «sovrapposizione» dell’una con l’altra. E in luogo del nero avremo il rosso.
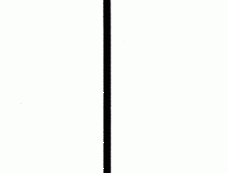

Quest’ultimo risultato non sarebbe certo prevedibile a partire da considerazioni riguardanti i risultati di mescolanze di materie cromatiche, ma qui appunto non stiamo affatto occupandoci di esse [53].
Goethe propone illustrativamente la seguente figura ottagonale bianco-nera per metterla alla prova dell’osservazione attraverso il prisma:
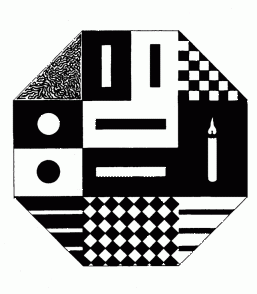
Essa assume allora questo aspetto:
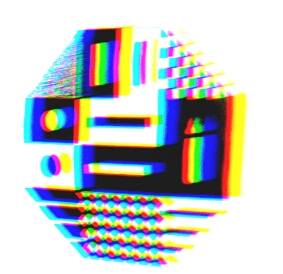
Si considerino in particolare il cerchio bianco su sfondo nero e il cerchio nero su sfondo bianco sulla sinistra della figura:

La zona azzurro-blu nel primo caso si diffonde sullo sfondo nero, mentre nel secondo a diffondersi verso lo sfondo bianco è la zona giallo-arancione. Naturalmente si generano cromatismi anche ai bordi dello sfondo e nello stesso senso: la zona azzurro-viola invade lo sfondo nero e mentre la zona giallo-arancione lo sfondo bianco della figura adiacente. Ciò accade anche nel caso della striscia nera e della striscia bianca nella parte superiore della figura:

dove dal bordo dello sfondo nero si diffonde sullo sfondo bianco adiacente una zona giallo-arancione, ed inoltre si crea dalla "sovrapposizione" tra l’arancione e il blu-viola, una tonalità rossa (magenta). |138|
Il sistema cromatico si sta così nuovamente dipanando sotto i nostri occhi, non più come una costruzione che rimanda a procedure di idealizzazione e nemmeno come derivante dai risultati delle composizioni effettuate con i colori intesi come materie cromatiche, ma come un fenomeno direttamente intuitivo, nel quale assumono evidenza quelle connessioni, quei rapporti e quelle tensioni che caratterizzano l’interpretazione goethiana del sistema dei colori.
Abbiamo già osservato, anzitutto, che il tema dell’origine dei colori dal bianco e dal nero assume un senso interamente nuovo. Ma naturalmente ora possiamo anche constatare in che senso si possa parlare di un’affinità dell’azzurro con il nero e del giallo con il bianco e di una polarità cromatica dipendente dalla polarità chiaroscurale fondamentale. Si ha qui di mira la regola fenomenologica che governa l’insorgenza delle regioni cromatiche corrispondenti ed è proprio questa regola che conferisce senso alla tematica goethiana nel suo insieme, che fornisce a essa, in certo modo, la sua giustificazione ultima. E naturalmente quella regola assume una portata tanto ampia, di fronte a quelle motivazioni implicite a cui abbiamo accennato, proprio per via dell’istanza naturalistica della concezione dei colori prismatici come «fenomeno originario».
Gli estremi a cui Goethe intende spingere una simile istanza sono d’altronde anche troppo chiaramente visibili nella sezione terza dedicata ai colori chimici. In essa raggiungiamo finalmente i colori che di volta in volta sono stati chiamati (una terminologia rammentata da Goethe) materiales, proprii, corporei, veri, permanentes, flexi [54]:i colori, dunque, come colori che possono essere apposti stabilmente alla cosa ovvero che sono inerenti alla cosa in forza della sua composizione fisico-chimica. Giunti a questo punto ci rendiamo conto, con nostra maggiore o minore sorpresa, che Goethe intende ritrovare anche su questo piano quelle regole che erano state messe in evidenza anzitutto in rapporto ai colori fisiologici e ai colori fisici.
Così egli comincia col dare una grande importanza alla distinzione tra acidi e alcali come una distinzione che può essere posta in stretta corrispondenza con l’opposizione tra il giallo e l’azzurro [55]: e dato un simile inizio non è difficile prevedere che cosa possa seguire. In generale i processi di trasformazione chimica e gli effetti di mutazione cromatica che spesso ne conseguono saranno considerati come di per se stessi altamente significativi nel quadro della tematica precedentemente esposta. Per esempio, Goethe richiama l’attenzione sul fatto che una determinata sostanza che, disciolta nell’acqua, appare di colore verde assume poco dopo una colorazione rossa [56] quasi che si potesse scorgere in ciò niente altro che un parallelismo sul piano chimico dei fenomeni di inversione messi in rilievo in rapporto ai colori fisiologici. Oppure può trovare significativo che un determinato materiale nero possa assumere, in seguito a trasformazione chimica una colorazione azzurra [57]; o addirittura che la carta più candida, con il passare del tempo, assuma una colorazione giallastra [58].
Il discorso avviato in questo senso nel campo dei minerali, si amplia e si estende ai vegetali e agli animali, dagli animali inferiori sino all’uomo. E il colore delle cose tende a diventare una sorta di cifra che ha una sua precisa ricchezza di significato rispetto a una presupposta gerarchia degli esseri della natura. Attraverso il colore si prospetta l’ordine stesso dell’universo e il suo procedere dalla natura inanimata sino alle soglie della vita spirituale.
Annotazione
Le immagini presentate in questo paragrafo così come l’immagine della finestra all’inizio di questa sezione sono state ottenute ponendo un prisma di fronte all’obbiettivo di una macchina fotografica e fotografando l’immagine fantomatica che si mostra.
22. Il simbolismo del colore e il suo fondamento nell’ordinamento sistematico
Tuttavia, nonostante l’indubbia invadenza dei temi di una filosofia della natura caratterizzata da una ipertrofica richiesta di senso, io penso che si possa ribadire che l’impresa di Goethe si presenta, nel suo nucleo essenziale, come una sorta di complessa interpretazione del sistema cromatico. In questo senso è stata sottolineata la centralità delle osservazioni goethiane intorno ai colori prismatici rispetto alla tematica complessiva dell’opera e il carattere di giustificazione ultima che deve essere attribuito ai loro risultati. Ciò non significa naturalmente che sia in qualche modo sostenibile l’idea che la tematica goethiana abbia qualcosa di simile a un fondamento empirico. Di fatto il modo in cui Goethe guarda attraverso il prisma è impregnato di una tensione immaginativa che è diretta a cogliere anzitutto la dialettica del colore come una dialettica dell’espressione.
Sul sistema cromatico viene proiettata la polarità giallo-azzurro - il sistema è articolato in un lato del Più e in un lato del Meno. E non si tratta naturalmente di una pura contrapposizione formale, i cui termini possano essere invertiti a piacimento: dal lato del Più dovrà essere posto il giallo, e dal lato del Meno, l’azzurro. Questo perché il giallo è immaginativamente connesso a momenti di attività e di dinamismo, esso richiama la luce, l’energia, il calore, evoca idee di prossimità e di vicinanza. L’azzurro invece ci attrae: ma questa attrazione è qualcosa di diverso dalla spinta che ci dà il giallo, non è una forza esercitata attivamente su di noi, ma qualcosa di simile a un invito ad abbandonarci, ad affondare nell’azzurro, cosicché questo colore si associa a immagini di privazione, di estenuazione, di offuscamento e di lontananza.
Ma queste due regioni possono essere approssimate l’una all’altra, il giallo e l’azzurro confluiscono nel verde, così come l’arancione e il viola nel rosso.
A questo proposito è certamente della massima importanza non solo prescindere dalle mescolanze concrete, ma anche mettere da parte coerentemente l’intera questione della composizione, badando unicamente all’aspetto che assumono i colori nel loro ordine originario esibito dalle immagini prismatiche. Il verde ci appare del resto «come una unità a proposito della quale non pensiamo più alla composizione» [59], mentre nell’arancione «degli esperimenti prismatici, che direttamente origina dal giallo, ben poco si pensa a quest’ultimo» [60]. Perciò non ha particolare interesse rilevare che mescolando il giallo con il rosso si possa ottenere l’arancione, quanto piuttosto il fatto che questo colore ci possa apparire come un colore che "sorge" dal giallo, come un giallo che si oscura e si arroventa. E in modo analogo può essere inteso il passaggio dall’azzurro al viola. Cosicché, dalle regioni cromatiche opposte si annuncia il rosso come punto culminante di un simile processo di intensificazione. Inversamente, se guardiamo alla formazione del verde, in esso la tensione delle regioni opposte giunge al suo punto di equilibrio e di riposo.
Nell’osservazione attraverso il prisma dunque non vediamo soltanto ricomporsi il sistema cromatico, ma soprattutto esso si presenta, nel proprio ordine e nella propria disposizione, nel modo stesso del suo apparire e nel modo in cui appaiono in esso i singoli colori e i loro rapporti, come un sistema che ha una propria dinamica interna e che da questa dinamica trae il proprio senso.
Tutto ciò mostra quanto sia erroneo e riduttivo isolare l’ultima sezione dell’opera, proponendola alla lettura come se avesse di per se stessa un contenuto autonomo. In essa si tratta dell’«azione sensibile e morale del colore», così come suona il titolo; e si può essere indotti a ritenere che, mentre su tutto il resto pesano le confusioni di un’impostazione metodologica troppo indeterminata e di una polemica che poggia su presupposti falsi, qui almeno si possa riconoscere la presenza di acute annotazioni intorno agli effetti psicologici del colore, che avrebbero un’eventuale validità indipendentemente dall’ampio insieme delle considerazioni da cui esse sono precedute.
Nulla invece potrebbe essere più fuorviante di un simile modo di lettura, che oltretutto ridurrebbe quelle poche annotazioni proprio a ben poco. Fuorviante è anzitutto il parlare di effetti psicologici, benché una simile formulazione del problema sia suggerita dallo stesso titolo della sezione. In realtà qui non ci si propone il compito di descrivere alla buona quali impressioni generino in noi i colori considerati in se stessi, quanto piuttosto di indicare le valenze espressive che possono essere attribuite ai colori sul fondamento dell’ordinamento sistematico esibito spontaneamente dalla natura.
Perciò la ben nota distinzione tra simbolo e allegoria proposta al termine della sezione, è naturalmente a essa preordinata. Nel caso del simbolo come in quello dell’allegoria, si tratta in generale, spiega Goethe, di un rapporto di rinvio significativo ad altro di cui è investito un certo materiale percettivo - per esempio, il colore. Parleremo tuttavia di allegoria - fissando in questo modo una regola per l’impiego del termine - quando ci troviamo di fronte a una connessione tendenzialmente arbitraria o esplicitamente dipendente da convenzioni. L’impiego allegorico «contiene una quota maggiore di casualità e di arbitrarietà, direi perfino qualcosa di convenzionale, in quanto prima di realizzarne il significato è necessario che ci venga offerto il senso del segno come nel caso del verde attribuito alla speranza» [61]. Mentre si parlerà di simbolo o di impiego simbolico, quando in luogo di una simile estrinsecità del rapporto tra rappresentante e rappresentato, il significato ci appaia come adeguato al materiale che lo esprime, e pertanto direttamente leggibile in esso.
Naturalmente non sarebbe difficile mostrare le difficoltà e anche l’inconsistenza di una simile formulazione. Gli esempi stessi sui quali essa si appoggia mostrano la sua inadeguatezza: di contro all’esempio della connessione verde-speranza, esempio evidente di connessione allegorica, sta l’esempio della connessione rosso-regalità, in rapporto alla quale Goethe non nutre dubbi che ci si trovi di fronte a un rapporto che è del tutto conforme alla natura delle cose, e dunque ad un esempio altrettanto evidente di connessione simbolica.
Tuttavia sviluppare la discussione in questa direzione sarebbe in ultima analisi improduttivo, perché nonostante l’inadeguatezza in cui quella distinzione è formulata, lo scopo che essa persegue rimanda a un problema reale e precisamente al rifiuto di un atteggiamento che riduca le associazioni di idee che stanno alla base delle manifestazioni espressive a contingenze di ordine psicologico e più in generale empirico-culturale.
L’esempio della connessione tra il rosso e l’idea della regalità come connessione simbolica non deve dunque metterci troppo in imbarazzo, e in particolare non deve farci pensare che saremo ora costretti a decidere se il rosso sia veramente il giusto colore del re, ma piuttosto essere inteso come un esempio che attira la nostra attenzione verso il centro del problema goethiano, che ricollega la tematica del simbolismo alle osservazioni dei colori attraverso il prisma. Come già sappiamo qui il rosso si presenta come «il vertice dell’intero fenomeno» [62], e il parlare della maestosità del rosso non fa altro che rafforzare la qualificazione espressiva che esso detiene già in forza di una simile caratterizzazione.
In linea generale dunque è lo stesso «interno del cerchio dei colori» che rappresenta il filo conduttore per lo sviluppo della tematica dell’espressione e proprio per questo, nonostante la terminologia impiegata da Goethe, che parla spesso di stati d’animo suscitati dai colori, il problema non è affrontato come un problema propriamente psicologico. Così quando si osserva che i colori che stanno dal lato del Più «dànno luogo a stati d’animo attivi, vivaci, tendenti all’azione» [63]mentre i colori che stanno dal lato del Meno «dispongono a uno stato di inquietudine, di tenerezza e di nostalgia»; oppure quando si afferma che l’«azzurro porta sempre con sé qualcosa di scuro» [64](in un’accezione ambigua del termine che non rimanda più ora soltanto all’oscurità vera e propria, ma alle sue possibili valorizzazioni immaginative), non si fa altro che operare la riconversione espressiva di determinazioni acquisite sul piano dell’osservazione fenomenologica, anche se è certamente giusto dare il massimo rilievo al fatto che quella osservazione era già fin dall’inizio sotto la presa di una simile intenzione diretta all’afferramento dell’espressione.
23. Il tema dell’armonia e la sua interpretazione in direzione del problema di una grammatica del colore
L’insistere su questo carattere dell’esposizione goethiana relativa al simbolismo ha infine particolare interesse per chiarire entro quali termini si propone in questo contesto il tema dell’«armonia dei colori». In tutta la storia della teoria dei colori ci si è spesso chiesti quali accostamenti cromatici possono essere considerati tra loro «concordanti» e «armonici». E una delle difficoltà principali del problema consisteva nell’indeterminatezza del senso di questi termini, come del resto dello stesso scopo della domanda. Parlando di armonia tra i colori potremmo appunto pensare ad un effetto psicologico di gradevolezza, a un sentimento di completezza e di soddisfazione di fronte agli accostamenti che chiameremmo armonici; e all’opposto a una sgradevole impressione di urto che sorgerebbe in noi di fronte ai colori che chiameremmo disarmonici. Il riferimento analogico al mondo dei suoni, e in particolare alla distinzione tra consonanza e dissonanza sembra direttamente a portata di mano per dare del problema un’illustrazione apparentemente evidente.
Ora, il primo compito che Goethe si propone a questo proposito è quello di operare una determinazione di senso della nozione di armonia, cosa che egli ritiene di poter conseguire ricollegandola al concetto di totalità. Armonica è anzitutto la totalità stessa [65]. Ciò comporta un netto indebolimento di un approccio puramente psicologico. Il riferimento a un’impressione di gradevolezza potrà essere mantenuto senza ambiguità, solo dopo che si sia chiarito che il centro del problema è rappresentato dal tema della totalità.
In questo modo ci si avvia ad una considerazione della questione che, secondo la linea di tendenza dell’intera trattazione del simbolismo del colore, può almeno avanzare la pretesa di una giustificazione interna nei materiali percettivi, una pretesa che riceve ancor più forza dal fatto che il tema della totalità, e naturalmente dell’opposizione che la caratterizza, è stato già elaborato in vari modi come una legalità interna dell’occhio e dei fatti della visione in genere.
Stando a questa impostazione sappiamo già quale sarà la configurazione armonica dei colori per eccellenza: essa sarà rappresentata dallo stesso «cerchio cromatico», proprio perché esso presenta l’universo cromatico nella sua totalità. Il cerchio cromatico produce una «sensazione di gradevolezza» in forza del suo contenuto, di fronte a esso ci sentiamo pervasi dall’«idea di questa armonia, avvertendone la presenza nello spirito» [66].
Dalla posizione del cerchio cromatico come modello di configurazione armonica, consegue la possibilità di proporre un secondo e un terzo modello particolarmente notevoli. Si tratterà naturalmente anzitutto dell’accostamento dei tre colori «fondamentali», secondo la vecchia terminologia. Il giallo, il rosso e l’azzurro ripropongono infatti il sistema nella sua totalità. Ma ciò vale anche per le coppie dei colori che si trovano nel cerchio in un rapporto di opposizione diametrale, e per lo stesso motivo. Perciò considerando le coppie cromatiche, solo le coppie dei colori diametrali meriteranno di essere chiamate armoniche.
Goethe chiama invece caratteristiche quelle composizioni di colori che risultano da connessioni mediante corde, con salto di un colore intermedio, e prive di carattere le composizioni di colori prossimi nel cerchio cromatico cioè che risultano da connessioni mediante corde senza salto di colore intermedio. In tutto ciò va notata soprattutto la chiarezza con la quale agisce l’intenzione di ricavare le connotazioni espressive dall’ambito delle considerazioni sistematiche; così come l’intenzione di far valere ancora una volta, insieme al tema della totalità, quello del contrasto e dell’opposizione. Le composizioni dette «prive di carattere» sono infatti quelle in cui vi è minore contrasto cromatico, mentre il contrasto è massimo nel caso delle composizioni «armoniche» dal momento che il rapporto che sussiste qui tra i colori è assimilabile, secondo Goethe, all’opposizione bianco-nero. Risulta così confermata, in questi sviluppi conclusivi, la coerenza del quadro di insieme e la prospettiva di lettura del testo che abbiamo proposto. L’aggiungere qualche parola di commento proprio sul tema dell’armonia dei colori sembra tuttavia tanto più necessario per il fatto che la sistemazione goethiana di questo problema, certamente non nei suoi dettagli, ma in alcuni dei suoi aspetti essenziali, si ripresenta di continuo immutata sino ai nostri giorni. Per esempio, nella classica opera di Itten, L’arte del colore [67], l’autore nota che molti tendono a ritenere armonici solo gli accostamenti dei colori aventi caratteri simili e che per lo più le parole «armonico-disarmonico» vengono impiegate come sinonimo di «gradevole-sgradevole». Ma questa nozione dell’armonia che Itten qualifica come meramente soggettiva viene respinta come priva di fondamento. Ad essa si deve contrapporre una nozione oggettiva che viene individuata nel principio: «Due colori sono armonici se la loro combinazione dà un grigio neutro», una relazione che è appunto la relazione di opposizione diametrale, formulata nei termini delle mescolanze tra materie cromatiche. Come in Goethe, Itten dà inoltre il massimo risalto alla comparsa «fisiologica» del colore «complementare», connettendola al problema dell’armonia: «Il principio fondamentale di armonia è desumibile dalla legge fisiologica dei colori complementari»68]. [
Eppure, monostante il fatto che la concezione goethiana nella sua sostanza si sia diffusa al punto da diventare quasi un luogo comune, sentiamo ancora il bisogno di qualche chiarimento. Ciò che ci può apparire oscuro è infatti proprio il tipo di problema che è realmente in discussione sotto il titolo di «armonia dei colori». La stessa formulazione di Itten, che distingue anche terminologicamente una nozione soggettiva di armonia da una nozione oggettiva, da un lato rende indubbiamente più drastica la tendenza, implicita nell’impostazione goethiana, a impedire la sua riduzione psicologistica, dall’altro e di conseguenza, mostra la difficoltà dell’impiego dello stesso termine di armonia, la difficoltà cioè di riempirlo di un contenuto fenomenologico specifico.Infatti, la soluzione goethiana di far confluire la nozione di armonia in quella di totalità che sta del resto anche alla base delle formulazioni di Itten, ci appare significativa unicamente in quanto mostra la coerenza dell’impostazione complessiva, mentre considerata in se stessa non sembra dire di più di una vuota tautologia.
Le difficoltà del problema e la loro natura risultano del resto evidenti se consideriamo i modelli di configurazioni armoniche di cui abbiamo parlato in precedenza. Mentre nel cerchio direttamente esibito la totalità è effettivamente presente, già nel caso dei tre colori «fondamentali», essa è solo implicitamente evocata. Ma che cosa si vuole dire quando, in un caso come questo, si parla di «evocazione»? La risposta ci viene appunto dal richiamo alla comparsa fisiologica del colore «complementare». Giustamente Goethe dà una grande importanza, dal proprio punto di vista, a questa comparsa, ponendola a fondamento del tema dell’armonia: senza di ciò infatti, la parola «evocazione» resterebbe del tutto vuota.
Ma il punto è questo: il richiamo fisiologico del colore complementare non è altro che un dato di fatto empirico che può avere la massima rilevanza nel campo della psicologia del colore, ma non per questo esso deve avere la stessa rilevanza nella sua fenomenologia. In realtà, qui ragionamenti e dati di fatto si intrecciano insieme, restando al di qua o al di là del dato fenomenologico. Se per esempio affermo che, dati i tre colori fondamentali o una coppia di colori diametrali è evocata la totalità, può essere che il contenuto di questa evocazione si risolva in niente altro che in un ragionamento: poiché so che a partire di qui il cerchio intero può essere costruito, allora penso che sia lecito parlare di evocazione della totalità. Se poi faccio riferimento alla comparsa fisiologica dei colori diametrali, aggiungo al ragionamento un dato di fatto di rinforzo. Ma il fatto è che non riusciamo a reperire per tutto ciò un effettivo riscontro sul piano fenomenologico.
In realtà, il problema che sta alla base della tematica dell’armonia dei colori non è affatto quello a cui il termine stesso sembra oscuramente alludere, quindi in particolare quello di decidere qualcosa intorno alle concordanze e alle discordanze cromatiche in un’ accezione qualunque dei termini, quanto piuttosto quello di conferire un’articolazione al problema, essenzialmente diverso, di una vera e propria grammatica del colore. Il primo passo in questa direzione consiste nel mostrare la possibilità di realizzare una tipologia degli accostamenti cromatici, di esibire le forme possibili delle sequenze cromatiche. Impostando il problema in questo modo appare subito chiaro che la questione dell’armonia, con tutte le sue difficoltà può essere semplicemente messa da parte e che il tema può essere trattato facendo convergere considerazioni strutturali con considerazioni propriamente fenomenologiche.
Ciò stabilisce naturalmente per noi anzitutto un punto di vista per la lettura del problema di Goethe: da un lato va messo in rilievo il ripresentarsi anche su questo terreno dei temi di fondo su cui è costruita la teoria; dall’altro l’interesse che riveste il fatto stesso che ci si orienti verso un tentativo di differenziazione tipologica degli accostamenti cromatici, adombrando così il problema autentico di una grammatica del colore.
Note
[17] Cfr. H. Matile, Die Farbenlehre Philipp Otto Runges, Mäander Kunstverlag, München-Mittenwald 1979, p. 51. Su Aguilonius si intrattiene piuttosto a lungo Goethe nella parte storica della sua Farbenlehre. Cfr. Zur Farbenlehre. Materialen zur Geschichte der Farbenlehre, trad. it. a cura di R. Troncon, Luni Editrice, Milano-Trento 1997, pp. 206-211.
[18] J.W. Goethe, Teoria dei colori (parte didattica), tr. it. a cura di R. Troncon, Il Saggiatore, Milano 1979. In questa stessa edizione, si veda di R. Troncon, Goethe e la filosofia del colore, pp. 215-250. La pubblicazione dei questa traduzione italiana dell’opera fu da me proposta e promossa presso l’Editore Il Saggiatore.
[19] ivi, p. 12.
[20] ivi, p. 3.
[21] ivi, p. 140.
[22] Wittgenstein rileva giustamente nelle sue Osservazioni sui colori (tr. it. a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1981) che sussiste una distinzione di principio, e non un’opposizione, tra il problema di Newton e quello di Goethe (cfr. a es. oss. 206, p. 78). Nello stesso tempo, egli tende ad accentuare, anche in rapporto a Goethe, l’idea di una fenomenologia del colore come «analisi concettuale», tacendo del tutto su questa componente naturalistica (cfr. a es. oss. 16, p. 28). Su questo testo si veda la limpida Introduzione di A. Gargani, pp. VII-XIX.
[23] J.W. Goethe, op. cit., p. 175.
[24] ivi, p. 50.
[25] ivi, p. 17.
[26] ivi.
[27] ivi, p. 18.
[28] ivi.
[29] ivi, pp. 14, 35, 77.
[30] ivi, p. 11.
[31] ivi, p. 70.
[32] ivi, p. 144
[33] ivi, p. 23.
[34] ivi, pp. 24-25.
[35] ivi, p. 29.
[36] ivi, p. 17.
[37] ivi, p. 33
[38] J.W. Goethe, op. cit., pp. 52-53.
[39] ivi, p. 55.
[40] ivi, p. 53.
[41] ivi.
[42] ivi, p. 57
[43] ivi, p. 58 e sgg.
[44] ivi, p. 103.
[45] ivi, p. 104.
[46] ivi, p. 107.
[47] ivi, p. 120
[48] ivi, p. 49.
[49] ivi, p. 122.
[50] ivi, p. 123
[51] ivi, p. 57.
[52] ivi, p. 73.
[53] Per ragioni di chiarezza è bene avvertire che, nel primo caso, in cui si ha la formazione dei colori viola, arancione, verde si tratta dei colori fondamentali additivi chiamati invece correntemente, nell’ordine, blu, rosso, verde:nel secondo caso, in cui si ha la formazione dei colori azzurro, rosso, giallo si tratta dei colori fondamentali sottrattivi chiamati correntemente, nell’ordine, ciano, magenta, giallo.
[54] ivi, p. 127.
[55] ivi, p. 128.
[56] ivi, p. 137.
[57] ivi, p. 130.
[58] ivi, p. 148
[59] ivi, p. 169.
[60] ivi, p. 170.
[61] ivi, p. 210.
[62] ivi, p. 170.
[63] ivi, p. 186.
[64] ivi, p. 189.
[65] ivi, p. 192.
[66] ivi, p. 194.
[67] J. Itten, Arte del colore, tr. li. di A. Monferini e M. Bignami, Il Saggiatore, Milano 1981.
[68] ivi, p. 21
III. S u o n i
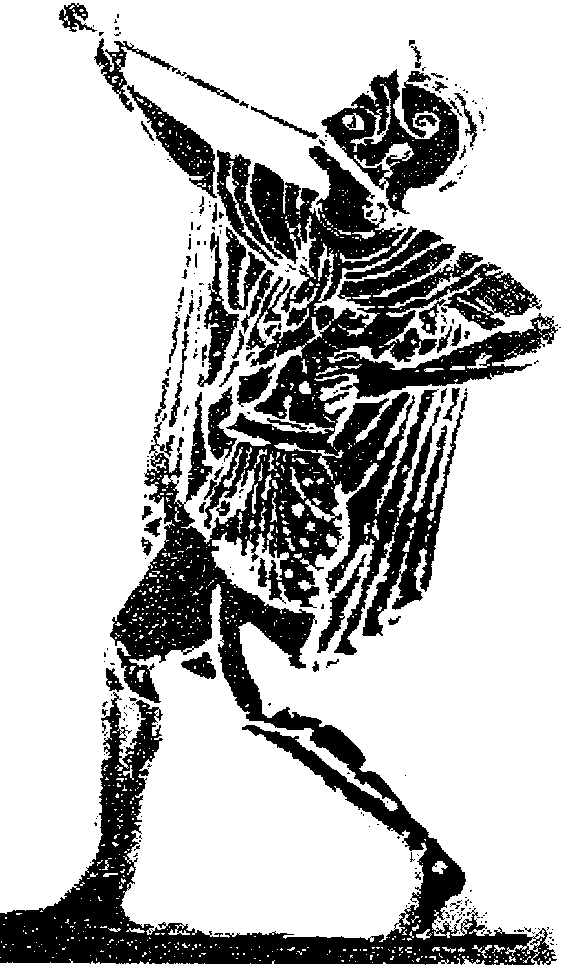
24. La relazione tra il suono e la cosa: causalità e provenienza
Passiamo ora al campo dei suoni. Nessuno avrà allora incertezze nell’indicare la direzione nella quale va ricercata la relazione del suono alla cosa. A differenza del colore che la percezione stessa attribuisce alla cosa come sua proprietà oggettiva, il suono non inerisce alla cosa nello stesso modo, per così dire, staticamente: ma dinamicamente.
Il suono proviene dalla cosa, ha origine in essa. Proprio per questo, non appena la nostra attenzione, per qualche motivo, viene attratta da uno dei tanti suoni che stanno sempre sullo sfondo della nostra vita di ogni giorno, esso ci appare senz’altro e in primo luogo come un segnale, come un indice della cosa da cui proviene o addirittura come una sorta di immagine di essa. Il suono ci appare tanto prossimo alla cosa, da valere come una sua pura e semplice presenza uditiva. Udiamo il suono e cerchiamo la cosa.
La naturalezza di un simile atteggiamento ci appare tanto più significativa quanto più riusciamo ad avvertirne la singolarità. In fin dei conti, i suoni non sono affatto cose, e non sono nemmeno qualità delle cose. E inoltre non è in generale vero che ogni volta che è dato un suono, siano date anche le circostanze della sua produzione e neppure che i suoni abbiamo sempre e necessariamente origine da cose. Si pensi soltanto a ciò che accade durante un temporale di agosto. E, tuttavia, se siamo orientati verso l’indicazione di condizioni fenomenologiche primarie che assolvono una funzione orientativa all’interno dei fatti dell’esperienza, il rumore del tuono, per esempio, dovrebbe apparirci anzitutto sorprendente; mentre il semplice gesto con il quale ora emetto un suono percuotendo con le nocche delle mie dita la superficie di questo tavolo - nonostante le particolarità del caso - assume subito il senso di un gesto esemplare.
In questo modo mostro che il suono (e non semplicemente questo suono) è connesso con la cosa, e posso mostrare anche che il suo carattere, il tipo di suono che viene emesso dipende dal tipo di azione che ho compiuto, così come dalla specifica consistenza materiale della cosa. Il suono sarebbe certamente stato diverso se la superficie percossa fosse stata metallica oppure se in luogo di percuotere questa superficie l’avessi sfregata con le unghie.
In particolare, l’esemplarità del gesto consiste nel mostrare il realizzarsi del suono, la sua inerenza alla realtà, il suo inserirsi all’interno di una catena di rimandi, di connessioni causali che - lo abbiamo visto a suo tempo - costituisce la nozione della cosa, e dunque della realtà stessa.
Ma a questo proposito occorre notare: il parlare di causalità coglie solo un aspetto della relazione del suono con la cosa, mentre il tipo di questo nesso non è affatto esaustivamente espresso dal richiamo alla nozione di causa. Infatti andrà certamente sottolineato che in talune circostanze questo rapporto può giungere, in quanto rapporto causale, sino al piano delle apparenze fenomenologiche dirette. Pizzicando corde metalliche ben tese udiamo un suono, e non in un semplice rapporto di contiguità: nella situazione complessiva ci appare una precisa correlazione tra le vibrazioni delle corde, visivamente percepite, e il suono emesso. Di qui potremmo prendere le mosse per un approccio autenticamente conoscitivo dei processi di produzione del suono. E questo approccio potrà spingersi molto oltre queste prime apparenze sino a giungere a elaborazioni teoriche di ampio respiro, superando l’effettività percettiva dei dati sonori.
Se invece vogliamo attenerci strettamente a questa effettività, il parlare di provenienza del suono dalla cosa si presenta particolarmente appropriato, proprio perché, pur richiamandosi alla produzione di esso e alla sua origine nella cosa, non pone affatto in primo piano il rimando alla causalità come un rimando che qualifica in modo esauriente la situazione.
Quando diciamo che il suono proviene dalla cosa non intendiamo semplicemente un nesso causale eventualmente percepito, ma anche sulla via di assumere la forma di un’astrazione produttiva sul piano conoscitivo: vogliamo dire anzitutto che il suono comincia di qui, dalla cosa, dentro di essa, e poi si fa avanti irraggiandosi tutt’intorno.
Pensiamo alle rappresentazioni infantili del suono di una campana: la campana viene circondata da raggi che promanano da essa, da un punto che sta dentro di essa, e che di qui si diffondono nello spazio intorno.
Una simile convenzione grafica non fa parola di una connessione causale, ma mostra appunto il farsi avanti del suono dalla cosa.
Tuttavia il suono non solo proviene dalla cosa ma, nella sua qualità specifica, porta anche con sé qualcosa della materia da cui proviene. Ed è interessante notare questo, dopo tutta la nostra discussione sulla tematica del colore. Mentre allora potevamo cominciare dal rilievo di un saldo riferimento del colore alla cosa, e tuttavia dopo quel primo inizio la tematica poteva essere sviluppata mettendo in secondo piano il momento della materialità, proprio nel caso dei suoni il legame con l’azione, e dunque con i momenti costitutivi della materialità, con la materia stessa, ci appare fin d’ora particolarmente rilevante. Ogni suono, lo accennavamo poc’anzi, ha una sua caratteristica impronta che dipende dal gesto che lo determina così come dalla consistenza materiale della cosa da cui proviene. Il colore aderisce semplicemente alla superficie della cosa, mentre il suono comincia dalle sue fibre profonde portando la cosa alla sua espansione espressiva.
Ci allontaniamo così sempre più da un’interpretazione della provenienza del suono dalla cosa nella pura e semplice forma di un rapporto causale, mentre tendiamo a ritrovare nel suono della cosa il modello originario del suono soggettivo - la voce umana. Se non comprendi che cosa possa significare il parlare del suono come espansione espressiva della cosa, pensa allora alla tua voce, alla voce degli altri, alla voce umana in generale. Quando la odi, nulla è più distante del pensiero del meccanismo della sua produzione; e nello stesso tempo, la nozione stessa della cosa e delle sue legalità causali si dissolve ed a essa subentra la nozione, interamente diversa, della corporeità vivente e soggettivamente vissuta.
Tuttavia, se da un lato incliniamo spontaneamente, guidati da una sorta di istinto causale che ha una funzione costitutiva rispetto alla realtà stessa a ricondurre il suono alla cosa, dall’altro il suono si impone percettivamente come una pura datità uditiva, come un’oggettività di nuovo genere che si trova in una netta opposizione alla cosa. Il gesto esemplare che mostra le circostanze della produzione del suono reagisce alla vocazione del suono a prendere le distanze dal mondo, effettuando un’integrazione di questi singolari eventi che sono i suoni con tutti gli altri eventi del nostro mondo. I suoni sarebbero infatti comparse misteriose e incomprensibili se non ci fosse un qualche punto a partire dal quale sia possibile porre il problema della loro origine, se non potessimo vincolare questa origine alla cosa stessa, alla materia che diventa fremente sotto le percosse delle nostre dita.
Eppure, ciò che caratterizza il suono è proprio la sua "immaterialità", il suo darsi come un’oggettività a sé stante, che tende a sfuggire al mondo, a proporsi fuori di esso o addirittura prima di esso. I racconti delle antiche mitologie nei quali si esprime in varie forme l’idea del divenire del mondo dal suono, dal canto di un dio che è il suo stesso canto [69] - rappresentano certamente straordinarie elaborazioni dell’immaginazione che si innestano sulla possibilità di intendere il suono come ciò che non ha origine e che perciò può assumere il significato di origine dell’origine.
Inversamente, si potrebbe affermare che il suono può essere veramente udito solo in una sorta di "soppressione del mondo", di "messa tra parentesi" dei legami con la cosa in modo tale che esso ci si presenti nella sua pura oggettività uditiva70].
Molti pensano del resto che sia quasi obbligatorio ascoltare la musica ad occhi chiusi. E allora si potrebbe commentare: in questo modo si manifesta concretamente e simbolicamente l’intenzione di un ascolto che cerca di porsi alla presenza del flusso sonoro stesso, e che dunque deve anzitutto porre fuori campo ciò che non appartiene al suono come tale e che riconduce invece soltanto alla sua provenienza dalla cosa.
Ma qui occorre prestare particolare attenzione a non confondere due ordini interamente differenti di considerazioni. Un conto è mettere in evidenza il manifestarsi del suono come oggettività autonoma, ed eventualmente come oggettività in se stessa espressiva (e di ciò fa parte, in primo luogo, il prescindere dalla natura di segnale del suono); e un altro è il ritenere che nelle determinazioni fenomenologiche del suono, e in un certo modo sul prolungamento di esse, siano già implicite decisioni sulla natura intrinseca dei fatti musicali in genere.
Ecco che cosa soleva dire quel personaggio del Wilhelm Meister che "aveva la bizzarria di non vedere i cantanti", e che perciò aveva apprestato una sala da concerto provvista di opportuni tendaggi per celare cantanti e strumentisti alla vista degli spettatori: "Il teatro ci vizia troppo. In esso, la musica serve quasi soltanto per l’occhio: essa accompagna i movimenti, e non i sentimenti. Negli oratori e nei concerti ci disturba sempre la persona del musicante. La vera musica è solo per l’orecchio. Una bella voce è ciò che di più universale e di più astratto possa pensarsi. E se l’individuo da cui essa emana ci compare dinanzi agli occhi nella sua concretezza, distrugge il puro effetto di quella vaga generalità. Io amo vedere colui con il quale debbo parlare, poiché è un dato uomo, la cui figura e il cui carattere rendono interessante o meno il suo discorso. Al contrario, chi canta deve restarmi invisibile". Questo stesso personaggio "anche nella musica strumentale voleva che fosse nascosta il più possibile l’orchestra; poiché si viene distratti e confusi dagli sforzi meccanici e dai necessari e sempre curiosi gesti dei suonatori. Quindi, in generale, ascoltava la musica a occhi chiusi..." [71].
Un simile personaggio potrebbe certamente essere convinto che questo atteggiamento si imponga a partire dall’essenza della musica, e prima ancora dall’essenza stessa del suono. Un’immagine della musica sembra infatti profilarsi dalla stessa essenza immateriale del suono - un’immagine nella quale l’accento cade nella sua prossimità alle dimensioni più profonde della vita spirituale. Perciò la voce deve restare senza un corpo; mentre del gesto espressivo degli strumentisti resta soltanto il goffo affanno del movimento tendente alla produzione meccanica del suono.
25. Suoni più vicini alla cosa e suoni da essa più lontani
Ma che cosa intendiamo propriamente dire, quando parliamo dell’immaterialità del suono contrassegnando in questo modo la sua opposizione alla cosa? In realtà, una simile caratterizzazione può valere solo in via del tutto generale, quindi come una determinazione generica dei suoni considerati nella loro oggettività autonoma. Ma la problematica della materialità e dell’immaterialità è destinata a ripresentarsi in una nuova forma, non appena procediamo in direzione delle differenze specifiche che contraddistinguono i suoni considerati come datità puramente uditive.
Qui pensiamo anzitutto a ciò che in precedenza abbiamo chiamato l’impronta del suono, riferendola alla provenienza del suono dalla cosa. Ma anche se prescindiamo interamente da questa provenienza, se consideriamo la pura apprensione del suono ponendo fuori campo questo riferimento fattuale, il tema della materialità e dell’immaterialità si ripresenta in una trasvalutazione immaginativa all’interno delle descrizioni che cercano di fissare i caratteri dei suoni e le loro tipicità qualitative.
È un fatto per noi estremamente interessante che proprio in rapporto a queste oggettività genericamente immateriali che sono i suoni ci si possa accingere a una descrizione che si avvale in modo efficace di aggettivazioni che rimandano agli attributi della materialità specifica della cosa. Noi possiamo parlare di suoni aspri, massicci, pesanti, opachi; e naturalmente all’opposto di suoni vellutati, levigati, sottili, trasparenti, rarefatti.
Queste descrizioni poggiano certamente su sintesi dell’immaginazione, ma possono anche nello stesso tempo essere considerate in qualche modo autentiche descrizioni. E a questa circostanza noi tendiamo a dare il massimo rilievo. In base a essa potremmo parlare di suoni più vicini alla cosa e di suoni da essa più lontani, dove la vicinanza e la lontananza non hanno più alcun significato reale.
Perciò tenderemmo anche a prendere abbastanza sul serio la distinzione, propria degli impieghi correnti del linguaggio, tra suoni e rumori. Esiste infatti almeno un’inclinazione del linguaggio corrente a impiegare questi due termini in contesti differenti: anche se proprio l’illustrazione comune di questa differenza può essere citata per mostrare che essa non solo è largamente equivoca, ma anche particolarmente dannosa quando si pretenda di farla valere acriticamente sul piano della riflessione musicale. Alla domanda sulla differenza dei contesti si risponderà, di norma, appellandosi alla gradevolezza del "suono" e alla sgradevolezza del "rumore", quando non ci si richiamerà senz’altro ai "suoni" emessi dagli strumenti musicali.
Non è certo difficile mostrare che una simile risposta non ha alcuna effettiva consistenza teorica. Il rimando alla gradevolezza e alla sgradevolezza abbandona infatti quella distinzione alle relatività delle impressioni psicologiche; e il riferimento agli impieghi musicali approfondisce queste relatività non appena si attira l’attenzione sulla varietà delle dimensioni culturali nelle quali deve essere deciso quali suoni debbano entrare nell’universo dei fatti musicali. Per questo chi si accinge a spendere una parola di difesa nei confronti di quella distinzione si espone certamente al rischio di essere accusato di parlare a difesa di pregiudizi dannosi e da tempo superati.
Consideriamo tuttavia il modo in cui, nel contesto del nostro problema, la distinzione tra suoni e rumori può essere riconsiderata come un indizio significativo di un’autentica differenza sul piano dei contenuti percettivi.
In effetti potremmo dire che rumori e suoni si distribuiscono sui due poli dell’opposizione tra il materiale e l’immateriale, che gli uni sono caratterizzati dalla prossimità alla cosa, gli altri dalla lontananza da essa. E da una simile affermazione sono escluse tutte quelle giustificazioni relative alla gradevolezza e alla sgradevolezza, o più in generale agli impieghi musicali, contro le quali possono essere sollevate obiezioni che potremmo fare senz’altro nostre.
26. I nomi dei suoni e i suoni senza nome
Lo stesso problema può anche essere sviluppato in un’altra direzione. Infatti, come esempi di "suoni" in contrapposizione a "rumori", potremmo proporre anche quei suoni che chiamiamo note, richiamando l’attenzione sul fatto che abbiamo a che fare qui con oggettività sonore nel senso più stretto. Anche in questo caso resta escluso qualunque rimando al piano delle impressioni e delle differenze psicologiche, così come a quello degli impieghi musicali. E nemmeno appare rilevante l’impronta del suono, dal momento che quanto qui importa è che il suono sì mantenga identico al variare di essa.
Nel proporre le note come esempi di suoni, mettiamo dunque in evidenza, all’interno dell’infinita varietà dei fatti sonori, la presenza di suoni che ci appaiono come entità puntuali e semplici, come singolarità ben definite. Perciò i suoni-note possono essere chiamati con nomi propri, mentre agli altri suoni spettano soltanto, nel discorso corrente, designazioni tipiche nelle quali spesso con il fatto uditivo è coimplicata, con una caratteristica ambivalenza, la provenienza del suono o l’azione concreta che lo produce.
I suoni-oggetti in senso pregnante hanno una ferma individualità. Ed esprimendoci in questo modo evochiamo il nostro vecchio esempio del blocco di granito, e proprio nel punto in cui eravamo interessati a introdurre una nozione di materia diversamente orientata: se consideriamo l’individualità della cosa come dipendente dalla sua forma e se questa può essere intesa come una rigida impalcatura, si impone allora una nozione di materia come pienezza fluida e priva di contorni.
In un nuovo senso, tutto ciò fornisce un suggerimento anche in rapporto al nostro tema attuale. I suoni-oggetti appartengono al lato della forma. Essi non sono blocchi di granito, ma almeno stelle fisse attraverso le quali si profilano costellazioni sonore. In quanto possono fungere come nodi di articolazioni e strutturazioni possibili, i suoni-oggetti si contrappongono a quelle formazioni sonore che appartengono invece al lato della materia nella nostra ultima accezione: agli impasti sonori, alle fusioni instabili e inarticolate del suono, al suono magmatico e melmoso.
27. Tematica temporale
Le considerazioni intorno alla temporalità, che hanno sempre avuto un ruolo particolarmente importante nelle tematiche di filosofia della musica, debbono probabilmente prendere il loro avvio da chiarimenti elementari intorno al senso secondo cui si parla dell’essenza temporale dei suoni.
In primo luogo, è certamente in questione qui, ancora una volta, la contrapposizione alla cosa, che sembra poter trovare nella temporalità del suono la sua determinazione riassuntiva. L’oggettività del suono si specifica nel suo carattere essenzialmente temporale, differenziandosi e contrapponendosi alle cose materiali, che hanno l’estensione spaziale come condizione costitutiva.
Tuttavia basterà rammentare le nostre prime indicazioni intorno al rapporto tra il suono e la cosa per notare come vi sia una tematica spaziale specifica che fa integralmente parte di una fenomenologia del suono. L’immagine dell’irraggiamento del suono dalla cosa si richiama al diffondersi del suono nella profondità dello spazio. Ed è appena il caso di notare che i suoni possono essere intesi, nel variare dei loro momenti, per esempio, nelle differenze di intensità, come segnali spaziali che contrassegnano rapporti di prossimità e di distanza. Questo rapporto inoltre non si arresta sul terreno della posizione di una spazialità autentica, ma può essere trasposto sul piano espressivo-immaginativo, sul piano di una spazialità simbolica. Già per questo l’esclusione dell’interesse del problema della spazialità in rapporto alle questioni attinenti all’espressione musicale sarebbe soltanto un indizio di concezioni pregiudiziali.
Eppure ha certamente un senso, che non è affatto fin dall’inizio risucchiato in qualche pregiudizio, il parlare della temporalità come caratteristica specifica degli oggetti sonori.
Ciò che occorre mettere in rilievo in primo luogo, avviando le nostre considerazioni in questa direzione, è che la temporalità viene allora in questione in un’accezione piuttosto particolare.
Infatti, anche le cose in genere - le cose estese, le cose materiali - possono essere dette temporali: esse non si trovano solo nello spazio, ma anche nel tempo, e hanno una durata, un inizio e una fine. Un tavolo, per esempio, è stato una volta costruito in una falegnameria, ha dunque una sua data di nascita e con il passare del tempo certamente si logorerà e andrà in pezzi. Esso ha una durata obiettiva, e mentre lo osservo oppure lo impiego, si consuma anche un frammento di essa. In questo senso, del tutto ovvio, si può parlare della temporalità delle cose materiali, e anche naturalmente degli stessi oggetti sonori.
Una significativa differenza comincia tuttavia subito a profilarsi se teniamo conto non già degli oggetti o eventi in quanto tali, ma della parte che la temporalità svolge nell’esperienza che noi abbiamo di essi. Allora ci rendiamo conto che in rapporto alle cose, la temporalità non ha alcuna presenza autentica. In altri termini, il dato di fatto che il tavolo, che ora sto osservando, abbia una data di nascita e che prima o poi giungerà alla propria fine rimane al di fuori dell’apprensione percettiva. Cosicché, se da un lato è certamente giusto affermare che, mentre lo osservo, si consuma un frammento della sua durata, dall’altro questo consumo del tempo non è affatto dato nella percezione.
Questo è il motivo per cui occorre chiaramente distinguere, in particolare, il rapporto di coesistenza spaziale e il rapporto di simultaneità temporale. Se ci accingessimo a dare una descrizione della disposizione di una configurazione di segmenti che si trovano sotto il nostro sguardo, ci serviremmo di qualificazioni spaziali, ma non diremmo che essi sono tra loro simultanei, come una necessaria determinazione aggiuntiva. Così facendo infatti non arricchiremmo la descrizione, ma introdurremmo una confusione di ordine concettuale. La simultaneità non appartiene ai segmenti, ma alla percezione di essi: i segmenti sono ora dati simultaneamente, piuttosto che in una successione.
Per mettere in evidenza la diversa nozione della temporalità che viene qui in questione, potremmo parlare addirittura di intemporalità delle cose estese: a esse non sono applicabili le relazioni della simultaneità e della successione considerate come relazioni della temporalità fenomenologica, cioè della temporalità che si manifesta nell’esperienza.
Di fronte all’intemporalità delle cose estese assume il suo senso effettivo il parlare dei suoni come di oggettività essenzialmente temporali. Con ciò non ci si richiama al puro e semplice dato di fatto della durata oggettiva, ma alla circostanza che questa durata è data in inerenza al contenuto percettivo. L’inizio e la fine appartengono allo statuto di oggetto del suono, così come la simultaneità e la successione. Nell’esperienza del suono è coimplicata la esperienza della temporalità, con il suono è anche dato il consumo del tempo. Il suono non ha soltanto una durata, ma è anzitutto una durata.
28. I suoni non sono fatti di tempo
Mentre in precedenza abbiamo insistito sull’oggettività dei suoni, nell’accezione più lata, come nell’accezione più ristretta, a proposito della quale abbiamo portato l’attenzione sulla puntualità del suono, quindi sulla sua fissità e rigidità, la temporalità del suono propone ora l’idea del movimento, l’immagine di un punto che si sviluppa nella linea, di una macchia che si dilata. L’accento deve allora cadere sulla processualità del suono come una processualità definita dalle stesse caratteristiche essenziali della temporalità che si manifesta attraverso di essa. In effetti, non bisogna concepire questa temporalità come una giustapposizione di istanti che si avvicendano in modo semplice e lineare gli uni agli altri e che vengono direttamente appresi nella loro successione.
L’apprensione soggettiva della durata temporale non ha affatto il carattere di un puro rispecchiamento di un ordine oggettivamente precostituito. Si tratta invece di una modalità di coscienza particolarmente complessa, nella quale lo sviluppo del decorso percettivo si mantiene costantemente al presente, secondo un dinamismo che implica le opposte dimensioni del passato e del futuro. Il fatto che possa essere utile, per illustrare l’apprensione della durata, fare riferimento ai suoni come esempio particolarmente evidente di oggettività temporali, non deve trarre in inganno sulla natura del rapporto tra il suono e il tempo. Si tratta infatti di un rapporto intrinseco, nel senso che abbiamo spiegato, ma che mantiene in ogni caso la distanza della forma dal contenuto.
I suoni non sono fatti di tempo. La temporalità si rapporta al suono così come l’estensione spaziale al colore: essa rappresenta uno schema vuoto che la qualità sonora deve riempire. E ancor più: forse non è affatto opportuno parlare di schema, dal momento che la parola rimanda a una qualche articolazione. Dovremmo dire invece che il tempo, rispetto al suono, è una forma informe, una forma inarticolata, che non conosce nessuna differenziazione interna. La differenziazione del tempo è operata dai suoni stessi, in forza delle particolarità del loro contenuto, della loro concreta sostanza sonora.
Perciò i compiti compositivi in genere possono essere intesi come compiti di strutturazione del tempo attraverso i suoni. Le relazioni in forza delle quali si istituisce questa strutturazione non sono relazioni puramente temporali, ma dipendono dalle affinità e dalle differenze dei suoni considerati nei caratteri percettivi da cui sono concretamente contraddistinti. Il tempo viene differenziato e articolato proprio perché questa configurazione sonora che ora odo evoca un’altra configurazione già trascorsa oppure fa presentire, per il modo stesso in cui essa è fatta, uno sviluppo possibile. A ogni brano musicale è essenziale la struttura del rimando dalla presenza a un’assenza, la struttura della evocazione e della rievocazione.
Ciò vale naturalmente anche, e anzitutto, per i suoni considerati unicamente nelle loro singole durate, attraverso le quali entrano in determinati rapporti tra loro. Risuonando, il suono frantuma la continuità omogenea del tempo, e da questa frantumazione si propone la sua ricomposizione ritmica: che non andrà certamente intesa come una pura e semplice suddivisione aritmetica del tempo, ma come una vera e propria plasmazione della temporalità.
Attraverso il suono, attraverso le differenze tra le sostanze sonore e le relazioni che istituiscono configurazioni sonore, attraverso i rapporti reciproci fra le durate e tutti gli altri momenti che qualificano la processualità del suono, riceve strutturazione e articolazione il semplice fluire del tempo, il suo divenire astratto, che può assumere ora una grande varietà di forme. Attraverso il suono, possiamo agire sul tempo, possiamo mettere in opera una vera e propria manipolazione della temporalità.
Tenendo conto di ciò si coglie uno degli aspetti secondo cui la tematica della temporalità può diventare produttiva dal punto di vista di una filosofia della musica. L’idea che alla base della creazione musicale vi sia una specifica esperienza del tempo, che in essa si debba cogliere l’origine dell’opera e che di qui debba essere tratta addirittura una sorta di tipologia che valga come principio per una valutazione estetica, come è stato sostenuto nell’ambito dell’estetica musicale novecentesca [72],mostra nei suoi stessi risultati i propri limiti, sia dal punto di vista delle giustificazioni filosofiche, sia da quello della sua efficacia come strumento di interpretazione. Mentre è certamente legittimo e ricco di interesse proporre il tema della temporalità come uno degli interrogativi che possono essere avanzati nei confronti dell’opera. Essa è infatti portatrice, nella sua stessa struttura compositiva, di immagini della temporalità, e l’interrogarsi intorno a esse, il chiedersi in che modo la forma vuota del decorso temporale viene riempita ed articolata mediante suoni, può certamente rappresentare uno dei mezzi per la comprensione.
E infine interessante notare come la tematica temporale si trovi nel punto di intersezione di due modi di approccio nei confronti della musica che appaiono nettamente antitetici. Il luogo comune di origine romantica della musica come arte dell’interiorità per eccellenza, a cui abbiamo accennato parlando dell’ascolto a occhi chiusi, che intende l’"immaterialità" del mezzo come sua vocazione alla massima spiritualizzazione, sembra trovare nell’intrinsecità del rapporto tra il suono e il tempo un ulteriore momento a cui appoggiarsi. La temporalità è infatti la dimensione primaria e costitutiva della soggettività stessa, considerata puramente come tale, come centro rarefatto dei suoi vissuti [73].
E tuttavia uno sviluppo effettivo del problema non potrebbe certamente non dare il massimo rilievo all’emergere in questo contesto del tema della movenza gestuale, della temporalità che si traduce nel movimento sensuale del suono: mettendo in questione ancora una volta la soggettività, ma intesa come soggettività che vive e si esprime anzitutto attraverso il suo corpo.
29. Il sistema dei suoni
La linea melodica, il "canto" sorge sulla base dei rapporti che si istituiscono tra i suoni. Ed è proprio a questo proposito che sorgono le prime richieste di un chiarimento. In che modo, secondo quali forme i suoni entrano in rapporto tra loro? E difficile sottovalutare la portata di una simile domanda: la musica in genere può essere definita come arte del connettere i suoni in un modo certamente più ricco di senso di quanto possa esserlo il definire in modo analogo la pittura o la poesia. Attraverso il significato della parola, la poesia raggiunge in ogni caso l’esteriorità del mondo, così come la possibilità della raffigurazione è una possibilità immanente nella natura dei mezzi pittorici. Del resto è certamente significativo il fatto che uno dei motivi che hanno sospinto verso l’astrazione dal mondo nella pittura, sopprimendo l’elemento propriamente raffigurativo dal dipinto a favore del puro gioco delle forme e dei colori, è rappresentato dall’intenzione di portare a realizzazione una pittura essenzialmente musicale. La musica sembra infatti fin dall’inizio installata in questa astrazione, essa è in primo luogo un’arte della sintassi, in rapporto alla quale il tema delle forme di connessioni possibili tra i suoni, l’esplosione delle loro potenzialità espressive assume un carattere fondamentale.
Senza discostarci di un solo passo dal terreno delle considerazioni elementari al quale abbiamo deciso di attenerci e seguendo del resto la nostra particolare traccia argomentativa, vogliamo avviare qualche considerazione in questa direzione.
Non c’è dubbio che parlando della semplicità che caratterizza le apparenze fenomenologiche dei suoni-oggetti abbiamo nello stesso tempo insistito sulla loro chiara differenziabilità reciproca, sulla loro determinatezza e distinzione. Ora si tratta anzitutto di decidere se questa distinguibilità, connessa alla puntualità del suono, comporti la pura e semplice eterogeneità dei suoni l’uno rispetto all’altro, in modo tale che ogni relazione sorgerebbe per così dire da un investimento di senso proveniente dall’esterno, oppure se il momento relazionale debba comunque essere inteso come un momento interno che indica a sua volta in che modo la singolarità dei suoni debba essere intesa.
Rammentiamo del resto ciò che avevamo osservato in rapporto ai colori. Anche allora avevamo sottolineato la varietà dei colori, la loro singolarità e le differenze, ma ci eravamo anche posti il problema di una loro possibile considerazione sistematica. Abbiamo cominciato con l’attirare l’attenzione sulla possibilità delle gradazioni della chiarezza per giungere infine a mostrare l’unificazione dinamica delle differenze nel cerchio cromatico inteso come rappresentativo del movimento del Colore.
Nello stesso modo, vogliamo adottare anche ora un punto di vista sistematico, orientandoci in direzione di una tematica strettamente parallela. Esattamente lo stesso è poi l’assunto di principio: l’insistenza con la quale oggi si parla della musica come di un linguaggio, mettendo in opera un’analogia così ricca di interesse, è tuttavia spesso accompagnata dall’opinione, esplicita o implicita, della totale convenzionalità delle forme e delle strutturazioni espressive che divengono operanti nei fatti musicali in genere. Una simile posizione, che viene talvolta sostenuta con scarsa consapevolezza degli impegni che con essa si contraggono, si è imposta contro l’errore consistente nel ritenere che certe modalità compositive, che hanno come loro giustificazione unicamente opzioni di ordine culturale, siano radicate nella stessa fisica del suono. A una posizione assolutistica si contrappone così un relativismo altrettanto estremo e altrettanto erroneo. Nel primo caso si sopprime il livello propriamente linguistico, nel secondo si misconosce invece l’esistenza di un piano prelinguistico con le sue proprie regole interne.
30. L’esperienza della progressione
Ci siamo chiesti or ora in che senso i suoni, di cui deve essere anzitutto sottolineata l’individualità e la differenza entrino in relazione tra loro. A questa domanda rispondiamo nello stesso modo in cui risponderebbe il maestro di musica ai suoi allievi alle primissime armi. Facciamo notare, cioè, che è possibile predisporre una successione di suoni in modo che ne risulti la percezione di una progressione, e precisamente nella duplice direzione dell’ascesa e della discesa. Ad una simile esperienza della progressione tenderemo a dare lo stesso rilievo che abbiamo riconosciuto all’esperienza della transizione ai fini delle nostre considerazioni sistematiche intorno ai colori.
Naturalmente, per evitare troppo lunghe digressioni di dettaglio, sarà opportuno tenere d’occhio le nostre assunzioni di carattere più generale, raccomandando al lettore di apportare quelle opportune delimitazioni e precisazioni che ci liberano dalle obiezioni più ovvie, sulle quali in ogni caso non intendiamo indugiare più di tanto. Va da sé, per esempio, che la distinzione tra livello linguistico e livello prelinguistico deve essere in ogni caso rigorosamente mantenuta, e perciò l’esibizione di una progressione sonora a titolo di possibilità di un ordinamento non va intesa come esibizione di un modello ben determinato di "scala" eventualmente concepita come una sorta di ordinamento fondamentale del materiale di base su cui poggerebbe l’invenzione di "melodie". Cosicché dobbiamo essere avvertiti del fatto che, quando il maestro di musica mostra in concreto il sussistere di una progressione, intenderà certamente introdurre nello stesso tempo elementi più particolarmente attinenti a un determinato linguaggio musicale.
Il punto importante e significativo per noi è invece il riconoscimento di momenti generali che stanno alla base dei possibili impieghi particolari - dunque in primo luogo della possibilità di ordinamenti scalari in genere, come una possibilità interna che caratterizza i suoni-oggetti.
Questo riconoscimento apre il problema di una rete relazionale presupposta alla percezione dei suoni presi nella loro singolarità. Nella singolarità dei suoni è già implicata la relazione. Dato un suono esso si trova tra un suono più grave e un suono più acuto - se abbiamo deciso di indicare in questo modo le opposte direzioni della progressione. E questo essere tra implica, nel caso dei suoni, il punto di vista sistematico esattamente come la tematica della gradazione chiaroscurale nel caso dei colori.
Appartiene inoltre ancora ai nostri presupposti di metodo lo stabilire una netta differenza di principio tra l’"altezza" intesa come determinazione percettiva, la cui nozione può essere solo illustrata e introdotta esemplificativamente, e l’altezza come una nozione fisica esattamente definita.
Basti qui notare che è possibile considerare le frequenze indipendentemente da fatti uditivi corrispondenti come puri eventi fisici di cui possiamo indagare la struttura mediante appositi dispositivi; o, inversamente, è possibile considerare i risultati fenomenologici indipendentemente dagli eventi fisici, e infine i rapporti tra eventi fisici e risultati fenomenologici: si tratta, per noi, di piani problematici concettualmente distinti, e nessun vantaggio si può trarre dalla loro confusione.
L’esperienza della progressione di cui parliamo qui non ha, in particolare, nulla a che vedere con la percezione di una variazione numerica di frequenze, ma rappresenta appunto l’evidenza primitiva da cui prendiamo le mosse.
31. Lo spazio sonoro
Sarebbe del tutto erroneo considerare questo glissare del suono come costituito da una molteplicità di punti sonori, dal momento che la molteplicità risulta del tutto cancellata dalla situazione percettiva. Resta vero naturalmente che nel flusso sono contenuti tutti i suoni possibili compresi tra il punto iniziale e il punto terminale, come momenti del flusso stesso che possono essere fissati in esso. Ma di fatto il tema della progressione conduce all’acquisizione di una vera e propria nuova nozione di unità sonora. Ancora una volta si impone, e da un nuovo punto di vista che non è più connesso soltanto alla mera forma dello sviluppo temporale, la processualità del suono. La puntualità del suono, e dunque la sua molteplicità, viene superata, lo stesso suono diventa di continuo un altro:nello stesso senso in cui eravamo giunti in precedenza a ricondurre la molteplicità dei colori all’unità del divenire del Colore. Il fatto che nella terminologia musicale corrente si parli di "alterazione" per indicare lo stesso suono che tuttavia non è affatto lo stesso, non è pura accidentalità terminologica che avrebbe bisogno di essere corretta, ma corrisponde all’essenza trasmutante del suono.
Del flusso sonoro continuo così inteso, che ha inizio in un suono A e termina in un suono B, o più precisamente che presenta il trasmutare del suono A nel suono B, potremmo dire che esso costituisce un segmento dello spazio sonoro. Secondo il senso delle nostre considerazioni (e anche su questo punto l’analogia problematica con la tematica del colore può rappresentare ancora una guida) il flusso sonoro continuo rappresenta infatti la nozione fondamentale e prioritaria di unità sonora, in particolare per il fatto che di qui può essere introdotta quella di spazio sonoro. Lo spazio sonoro nella sua totalità potrà essere inteso come prolungamento da entrambi i versi di un segmento che appartiene a esso. Ma contro di ciò vi è ancora una circostanza che mostra quanto poco ci possiamo affidare alla logica di una possibile rappresentazione geometrica. Mentre in via di principio è possibile prolungare indefinitamente da entrambi i versi un segmento, lo spazio sonoro è uno spazio chiuso, l’ascesa e la discesa sono qui caratterizzate da un limite superiore e da un limite inferiore.
Occorre a questo proposito prestare particolare attenzione a non confondere questo problema con il problema interamente diverso delle soglie di udibilità, che richiede, per essere posto, che si tenga la presa a un tempo sui risultati fenomenologici e sugli eventi fisici corrispondenti. Nel parlare di chiusura dello spazio sonoro in rapporto alle altezze, abbiamo invece di mira una circostanza interamente giacente sul piano fenomenologico. Perciò non si tratta di sostenere la semplice esistenza di suoni estremi - come se ci fosse un suono che si annunciasse da se stesso come ultimo suono - ma piuttosto di riferire la chiusura dello spazio sonoro alla struttura stessa della progressione, alla sua forma complessiva. Lo spazio sonoro va chiudendosi da entrambi i versi, nella direzione della discesa e dell’ascesa, in una sorta di curvatura che contrassegna ogni suo punto.
Si comprenderà subito che questo procedere del suono verso opposti estremi è già implicato nella differenza del grave e dell’acuto, purché queste designazioni non vengano intese come designazioni puramente formali, ma come qualificazioni autentiche del materiale percettivo che attingono il loro fondamento dall’intreccio del dato con le sintesi operate dall’immaginazione.
Un bambino rise sentendo chiamare "bassi" i suoni gravi: osservando che gli sembravano soltanto molto più vecchi [74].
Ma il nome non importa, e nemmeno importa l’immagine in se stessa, quanto piuttosto la convergenza delle immagini. Verso il grave, il suono invecchia, si ispessisce, aumenta il suo peso e la lentezza del suo passo. Verso l’acuto, il suono si assottiglia, diventa veloce, leggero, trasparente. L’opposizione tra materiale e immateriale si ripresenta anche in questo contesto, richiamando la nostra attenzione sul rilievo che assume, anche in rapporto alle altezze, momenti che spettano primariamente alla timbrica del suono.
Ma forse l’immagine che sarebbe più opportuno richiamare per illustrare la chiusura dello spazio sonoro intesa come chiusura che caratterizza la sua forma fenomenologica è ancora quella verso cui ci orientano le considerazioni sul colore. Verso l’acuto: il bianco. Verso il grave: il nero. E lo spazio sonoro termina in essi [75]. Con tutto ciò siamo ancora lontani dall’avere indicato quei primi elementi che ci offrano un orientamento per una rappresentazione grafica dello spazio sonoro così come era possibile fare nel caso della tematica dei colori. Naturalmente, il pervenire a una simile rappresentazione non è affatto importante o indispensabile, mentre è interessante comprendere le ragioni della sua intrinseca difficoltà.
Fin qui abbiamo dato rilievo alla continuità dello spazio sonoro, alla sua forma di progressione ascendente e discendente, al modo, infine, di intendere la sua chiusura come una chiusura che si manifesta sul piano fenomenologico. Ma la stessa immagine a cui ci siamo richiamati poco fa ci avverte che abbiamo soltanto compiuto un primo passo in direzione della complessa problematica della forma dello spazio sonoro, e quindi in generale delle relazioni interne tra i suoni. Il nostro continuo dei suoni si presenta ora soltanto come un continuo chiaroscurale, come un continuo di grigi. E di fronte a ciò fa risentire i propri diritti il problema della differenza tra i suoni, di una differenza che non può essere interamente assorbita dal luogo che essi occupano nella progressione.
Indipendentemente dal loro grado di chiarezza, e anche dalla possibilità di una transizione continua dall’uno all’altro nell’unità del movimento del colore, il giallo e il viola hanno i loro caratteri particolari che sono a loro volta il fondamento della specificità della relazione da cui sono connessi.
Procedendo oltre in questa direzione, dobbiamo allora attirare l’attenzione su un’altra singolare e importantissima proprietà dello spazio sonoro: esso non è caratterizzato soltanto dal movimento progressivo nell’ordine delle altezze, ma anche dalla struttura della ripetizione. Cosicché se prendiamo un punto qualunque A del continuo sonoro e progrediamo nell’una o nell’altra direzione incontreremo un punto A’ che "consuona" con esso - incontreremo cioè un suono che si trova con il precedente, impiegando la terminologia musicale corrente, in un "rapporto di ottava". Ciò significa che è una caratteristica essenziale dello spazio sonoro il fatto che un segmento di esso sia rappresentativo dell’intero spazio sonoro.
32. Consonanza e fusione
In realtà, l’introduzione del tema della struttura iterativa dello spazio sonoro, e nello stesso tempo dell’identità e della differenza dei suoi punti, chiama in causa la nozione di consonanza: il rapporto di ottava, infatti, sembra poter valere come caso esemplare, particolarmente evidente, di una relazione che diventa invece subito problematica non appena ci si allontani da quel caso esemplare e si tenti di essa una delimitazione concettuale soddisfacente. Sull’importanza storica che ha avuto una simile problematizzazione all’interno delle vicende della musica novecentesca non è certamente necessario insistere. Piuttosto è il caso di notare che essa aveva tutti i suoi motivi e i suoi scopi sul piano del linguaggio musicale e tendeva a liberare la dissonanza dalla sua posizione subordinata nell’ambito della sintassi tonale, aprendo nuove prospettive espressive. All’interno di questo dibattito, tuttavia, l’accento tendeva in ogni caso a spostarsi anche sul piano prelinguistico, in modo tale che la rivendicazione dell’impiego libero da vincoli della dissonanza si spingeva sino alla negazione di un’effettiva consistenza della distinzione sul piano percettivo. E in ciò il motivo polemico, l’esigenza di opporsi nel modo più netto a tentativi di giustificazione extralinguistica del sistema espressivo fondato sui predominio della consonanza, prevaleva su una più precisa configurazione teorica del problema.
Una significativa ripercussione della situazione sul piano dell’indagine scientifica può essere considerata per molti versi la Psicologia del suono (1883-90) di Carl Stumpf [76] che, per quanto eviti di proposito riferimenti agli sviluppi musicali ad essa contemporanei, rappresenta tuttavia già nella sua stessa impostazione di principio, indizi consistenti dei mutamenti intervenuti. Ciò che occorrerebbe mettere in luce in rapporto a essa è anzitutto la chiarezza con cui viene individuato un terreno di indagine propriamente psicologico come un terreno che deve essere neutrale rispetto alle opzioni di ordine estetico e autonomo rispetto alle problematiche fisico-acustiche. Questa neutralità corrispondeva certamente ad un atteggiamento di massima apertura dal punto di vista dell’impiego espressivo dei materiali - atteggiamento del resto documentato dagli interessi pioneristici di Stumpf verso l’indagine etnomusicologica.
Le conseguenze di ciò si fanno sentire, in particolare nel modo in cui viene prospettata la distinzione tra consonanza e dissonanza. Se ci muoviamo all’interno di un approccio puramente psicologico, prescindendo dunque dalla teoria e dalla prassi musicale così come dalle spiegazioni fornite dalla fisica del suono, la certezza di quella distinzione non può essere data per garantita, ma deve essere messa alla prova. A tale scopo è necessario provvedere a determinarne il senso, in modo tale da poter procedere ad una sperimentazione psicologica adeguata. Va da sé che i soggetti della sperimentazione non potranno essere persone musicalmente preparate; ma, a parte la difficoltà di configurare, in modo sufficientemente esente da obiezioni, i requisiti che deve possedere una persona per essere considerata atta alla sperimentazione, deve ancora essere stabilito il tipo di domanda che deve esserle rivolta.
A questo punto interviene la decisione cruciale di Stumpf intorno al senso del termine di "consonanza"; una volta che ci siamo liberati dalle implicazioni valutative relative alle belle armonie, al sentimento di gradevolezza e di compiutezza che potrebbe rinviare a una consuetudine di ascolto più che alla cosa stessa, quel termine sembra non alludere ad altro che a una situazione percettiva nella quale i suoni si fondono insieme fino al punto da formare un tutto unitario. Ciò non significa rimandare circolarmente a una sorta di sentimento di unitarietà. Che più suoni formino un tutto unitario ha, secondo Stumpf un significato molto concreto: e precisamente diremo che i suoni sono tra loro fusi quando persone musicalmente impreparate non riescano facilmente a valutare in modo corretto se il fenomeno uditivo proposto sia semplice o complesso.
Secondo Stumpf, comunque il concetto di consonanza sia introdotto nella teoria musicale o definito sul piano degli eventi fisici, per ciò che concerne la sua consistenza percettiva, esso deve essere ricondotto a quello della fusione, intesa come difficoltà di analizzare il fenomeno uditivo.
Stumpf si accinge così ad apprestare esperimenti nei quali vengono proposti alla valutazione accordi di due note a persone musicalmente impreparate. Ne risulteranno risposte giuste e risposte sbagliate. E gli esperimenti mostrano che il numero percentuale delle risposte sbagliate cresce con il crescere del rapporto di consonanza come viene normalmente teorizzato nella tradizione musicale.
Non vi sono dubbi sull’interesse di questa impostazione del problema da parte di Stumpf. Essa prende le mosse da una esplicita messa in questione della consistenza della distinzione, per poi ritrovarla sul piano dei dati percettivi dopo aver operato una ridefinizione concettuale che sembra attribuirle un contenuto positivo. Ogni oscurità sembra dissolta se il problema si riduce a un possibile inganno della percezione intorno alla questione dell’uno e dei molti. Nello stesso tempo, la differenza viene riportata a una dimensione strettamente empirica e inoltre essa viene fortemente relativizzata: la dissonanza infatti non è che un grado, determinabile entro margini abbastanza ampi di arbitrarietà, all’interno della curva delle risposte sperimentali.
Eppure dubbi e perplessità sorgono ben presto non appena riconsideriamo con attenzione critica, prima ancora che le conseguenze di dettaglio, quello che rappresenta il vero e proprio punto di volta di quel percorso argomentativo e precisamente la risoluzione della nozione di consonanza in quella di fusione, e l’interpretazione di questa nella difficoltà empirica di operare la discriminazione tra i suoni. Per quanto all’inizio questo modo di ricondurre il fenomeno della consonanza alla sua essenza tangibile liberandola da implicazioni espressive ci possa sembrare convincente, tuttavia il dubbio che così facendo si operi in realtà il passaggio da un problema a un altro interamente diverso appare subito ampiamente giustificato.
Per rendersi conto di ciò, può forse essere sufficiente fare richiamo alla circostanza di carattere generale secondo la quale il parlare, per esempio, di una configurazione visiva unitaria, nella quale le parti sono fuse, e cioè integrate l’una all’altra nell’intero, non implica certo una difficoltà della loro discriminazione. Di fronte a un quadrato, noi vediamo naturalmente anche il numero dei suoi lati, benché ciò che è colto sia anzitutto l’unità figurale stessa. Assume allora senso il fatto che le persone musicalmente preparate, che sono perciò in grado di dare risposte corrette sulla molteplicità dei suoni nell’accordo, continueranno a percepire appunto una consonanza tra essi, mentre questa circostanza, secondo lo spirito dell’impostazione di Stumpf, dovrebbe essere considerata estranea al fatto percettivo stesso. La difficoltà della discriminazione da parte di persone musicalmente impreparate si aggiunge allora come una caratteristica peculiare della situazione percettiva, che fornisce una nuova informazione, ma che non è certamente in grado di rappresentare la base concettuale della differenza.
Ma prima ancora di ciò, è presente nell’argomento di Stumpf una confusione che rimanda all’aspetto propriamente metodologico: se qualcosa è un quadrato o un triangolo, ciò dipende dalle caratteristiche interne della figura, e non può essere deciso dalla media delle opinioni delle persone che compiono osservazioni intorno a quelle unità figurali. E così non può essere deciso statisticamente se una configurazione sia una consonanza o una dissonanza.
Nella ricerca proposta da Stumpf si pone in realtà un autentico problema di fenomenologia empirica, e precisamente sì cerca di accertare che cosa accade nel caso della percezione di consonanze e dissonanze da parte di persone di scarsa preparazione musicale. Ma la differenza puramente fenomenologica tra consonanza e dissonanza è comunque presupposta e non è in ogni caso messa in questione.
33. Consonanza e somiglianza
Vi è dunque per Révész un aspetto importante del problema che riguarda il fatto percettivo stesso. Ma mentre in Stumpf si cerca di riportare questo aspetto alla nozione di "fusione", per Révész il fenomeno del "consuonare" o del "dissuonare" è, come egli dice, un "fatto percettivo immediato, non ulteriormente riducibile" [81].
E tuttavia sarebbe sbagliato ritenere che questo riconoscimento, che pure è della massima importanza, sia sufficiente a liberare il campo da ogni difficoltà. Il sostenere che siamo in presenza di un fenomeno irriducibile significa portare l’accento sulla specificità della situazione percettiva. La parola "consonanza" è, in se stessa, una parola vuota, che può ricevere il proprio senso solo attraverso l’esempio, quindi attraverso un riempimento intuitivo diretto. Ma ciò significa forse che si deve rinunciare a una qualunque "analisi", facendo valere la distinzione tra consonanza e dissonanza come semplicemente presupposta? In realtà, stando a Révész, la discussione deve spostare il proprio centro. L’attenzione deve essere portata piuttosto alla somiglianza e dissimiglianza qualitativa dei suoni, della quale la consonanza e la dissonanza non sarebbero altro che manifestazioni nell’ordine della simultaneità.
Questo orientamento deriva dall’accento particolarmente forte posto da Révész sull’autonomia di ciò che egli chiama "qualità sonora" rispetto all’altezza, quindi sul punto sonoro che si ripete "identico" di ottava in ottava, lungo l’intero spazio sonoro. Così nel problema di una rappresentazione grafica dello spazio sonoro che sia in grado di rendere conto dei suoi aspetti sistematici si dovrà tenere conto sia del movimento ascendente sia del ritorno della stessa "qualità sonora", compresa nell’intervallo di ottava, nel quale l’intero spazio sonoro deve poter essere proiettato [82].
Questa attenzione al problema dell’identità conduce in primo luogo a mettere in evidenza l’ordine della successione, piuttosto che quello della simultaneità. Di effetto consonantico si parla, certamente, in rapporto a suoni che risuonano simultaneamente, ma è chiaro che non è la simultaneità come tale che si trova all’origine di quell’effetto. La consonanza non sorge dalla simultaneità. E nemmeno la "qualità" sorge dalla consonanza, mentre ovviamente vale l’inverso: proprio perché i suoni sono quelli che sono, risuonando insieme ne risulta un effetto consonantico o dissonantico.
In secondo luogo se nell’ottava vi è identità qualitativa, allora sembra che si possa sostenere che nelle consonanze in genere ciò che è in questione è la somiglianza tra le qualità sonore. Così Révész sottolinea non solo l’inderivabilità della consonanza, ma soprattutto il carattere "primario" e "irriducibile" [83] dell’impressione di somiglianza che sorgerebbe quando risuonano, anzitutto in successione, due suoni in rapporto di ottava o eventualmente in quei rapporti che, nella simultaneità, darebbero luogo a consonanze. Nel primo caso avremmo la massima somiglianza qualitativa [84] che andrebbe decrescendo negli altri casi.
Di fronte a ciò ci si dovrebbe chiedere in quale punto l’argomentazione subentri all’esibizione di condizioni descrittive. In effetti la somiglianza di cui qui si parla è anzitutto una somiglianza argomentata: e la pretesa che si tratti anche di una relazione percepita è appunto soltanto una pretesa [85].
34. Osservazioni conclusive
Fin dal momento in cui abbiamo cominciato con il parlare della relazione tra il suono e la cosa, ritrovando nello sviluppo del tema l’opposizione del materiale e dell’immateriale e quindi anche la possibilità di rendere conto della distinzione tra suoni e rumori, al di là dei motivi che suggerirebbero di affermare invece la sua inconsistenza teorica, e poi anche nelle segnalazioni elementari intorno alla tematica della temporalità, è costantemente presente l’idea che gli approfondimenti che possono essere condotti in questa direzione, benché non siano affatto in grado di condurci direttamente sul terreno della filosofia dell’arte, rappresentino tuttavia un piano di riferimento da cui non è possibile prescindere.
Ciò vale in modo particolare nel campo delle considerazioni sistematiche a cui rinvia la tematica dello spazio sonoro. All’opposto che nel passato, l’opinione oggi prevalente - anche se talvolta solo tacitamente presupposta - è che anche in questo campo tutto sia affidato alla relatività linguistica, all’empiria delle condizioni di fatto, alle scelte e alle decisioni soggettive, alle particolarità delle grammatiche storiche. Eppure, proprio questo momento della storicità e della soggettività verrebbe esaltato e messo nella massima evidenza dal riconoscimento di modi e di forme di organizzazione interna, di ordini strutturali immanenti al materiale stesso che dànno certamente luogo alla precostituzione di un apparato di regole, ma che nello stesso tempo, non solo non sono in grado di stabilire vincoli autentici, ma non fanno altro che determinare la scacchiera di alternative possibili dentro il quale viene giocato il gioco dell’espressione.
Note
[69] Cfr. M. Schneider, Il significato della musica, Rusconi, Milano 1981.
[70] R. Schaeffer ha elaborato ampiamente questo tema, con riferimento all’epoché husserliana, nel suo Traité des objets musicaux, Ed. du Seuil, Paris 1966.
[71] Cit. in Romanticismo e musica, a cura di G. Guanti, EDT, Torino 1981, p. 90.
[72] Cfr. G. Brelet, Esthétique et creation musicale, PUF, Paris 1947.
[73] G.W.F. Hegel, Estetica, Einaudi, Torino 1972, p. 1013: "L’io è nel tempo... il tempo è l’essere del soggetto stesso.., e il tempo del suono è anche quello del soggetto, e già su questa base il suono penetra nell’io stesso".
[74] Lo racconta Carl Stumpf, nella sua Tonpsychologie (1883-90), ristampa anastatica, Bonset, Amsterdam 1965, p. 537.
[75] G. Révész rammenta nella sua Grundlegung zur Tonpsychologie (Leipzig 1913) uno spunto di analisi di Brentano: questi parlava in rapporto ai suoni di un elemento saturo e di due elementi insaturi "che si presentano in rapporti diversi con l’elemento saturo, dei quali l’uno è paragonabile al nero e l’altro al bianco". Con queste ultime nozioni Brentano intendeva essenzialmente caratterizzare le differenze di altezza: "Un do nella regione media si distingue, secondo questa teoria, da un do più basso o più alto all’incirca come un azzurro saturo si distingue da un azzurro scuro e da un azzurro chiaro" (pp. 37-38).
[76] Op. cit. nella nota 75. L’argomento viene ripreso in C. Stumpf, Konsonanz und Dissonanz, Berlin 1898.
[77] op. cit. nella nota 76.
[78] tr. it., Firenze 1954.
[79] ivi, p. 92.
[80] ivi, p. 96.
[81] ivi.
[82] Se decidiamo di rappresentare le quantità sonore mediante punti sulla circonferenza di un cerchio e il movimento ascensionale con una curva spiraliforme che si muove nella terza dimensione avremo allora il cilindro dei suoni secondo Révész: cfr. ivi, p. 67.
[83] ivi, p. 61.
[84] ivi, p. 55.
[85] La difficoltà emerge in particolare nel testo di Révész quando la relazione tra due suoni che si trovano in un intervallo consonantico viene posta come una relazione misteriosa. La consonanza di quinta, dice per esempio Révész, sarà basata su una "certa parentela" tra i due suoni, anche "se non sappiamo di che specie e natura"; in ogni caso si tratterà di una parentela di diverso tipo rispetto a quella dei suoni in rapporto di ottava. ivi, p. 61.
