
foto di G. P.
![]() La notte dei lampi - Parte IV (196.11 kB)
La notte dei lampi - Parte IV (196.11 kB)
1. Introduzione e avviamento del dibattito aporetico
Nel libro quarto della Fisica, Aristotele si interroga intorno al luogo![]() . Egli si chiede se ciò che chiamiamo «luogo» sia qualcosa e che cosa, se vi siano effettivamente luoghi, se essi in generale possano avere un modo di esistenza autentica.
. Egli si chiede se ciò che chiamiamo «luogo» sia qualcosa e che cosa, se vi siano effettivamente luoghi, se essi in generale possano avere un modo di esistenza autentica.
Dobbiamo ammettere che domande come queste ci ap-paio-no anzitutto sorprendenti: mai esse ci si presentano come domande impellenti, la cui risposta potrebbe rappresentare una sorta di condizione necessaria per superare una difficoltà o un ostacolo imprevisto. Il senso della parola «luogo» ci appare del tutto chiaro. E sempre operiamo presupponendo luoghi. Se dun-que il filosofo ci chiede: «Che cosa è il luogo?», saremmo ten-tati di rispondere: prima di tutto, l’argomento ci sembra di scar-so peso. A tal punto che se ora ci accingiamo a dare uno sguardo alle pagine aristoteliche, in realtà siamo mossi proprio da questa ingenua curiosità: come fanno quelle domande a elevarsi alle altezze a cui pensiamo debbano sem-pre attenersi le riflessioni dei filosofi, come fa quella chiarezza a oscurarsi al punto da acquisire con ciò una dignità filosofica? Del resto, il primo avvio del discorso aristotelico subito ci rassicura, dal momento che la nozione di luogo viene proposta proprio come una nozione ben nota e con le connessioni che notoriamente la caratterizzano.
«Dove sono infatti la sfinge e l’ircocervo?»[1].
Tutti ammettono la realtà del luogo per il fatto stesso che tutti ammettono la realtà del movimento, che altro non è se non spostamento di una cosa da un luogo a un altro luogo. La cosa e il movimento della cosa esigono luoghi. Perciò, che vi siano luoghi è un’opinione che si situa sul piano della chiarezza legata alle nostre pratiche quotidiane, una chiarezza che non sembra nemmeno concedere l’interesse del problema. Tuttavia ciò che si chiede è che questa nozione praticamente chiara venga afferrata e compresa. La domanda chiede soprattutto che venga formulata una risposta.
Tutti sanno che esistono luoghi. Anche tu lo sai. Ora prova a dirlo in parole – che cosa sia il luogo. A questo scopo potremmo tentare di seguire questa strada; oppure quest’altra. Tentiamo e ritentiamo. Forse si stenterà a trovare una formula realmente convincente, un’autentica via d’uscita. Forse arriveremo a dire: qui ci sono molte aporie[2].
Nello sviluppo della discussione che prende le mosse dalle prime evidenze accade proprio così – la confusione comincia ben presto con l’apparire. Si può addirittura sospettare con qual-che fondamento che proprio questo sia il suo primo scopo: fare apparire la confusione significa infatti produrre quella consape-volezza del problema che può essere raggiunta solo quando si sia compreso come sia difficile, una volta che una formula defi-nitoria sia stata proposta, porla al riparo dal gioco dell’argo-mentare che su di essa liberamente si mette alla prova.
Intanto cominciamo con l’osservare che la realtà del luogo esclude qualunque approccio puramente soggettivo, che prospet-ta l’alto e il basso, la destra e la sinistra come determinazioni meramente relative e strettamente dipendenti dalla posizione del corpo. La nozione di luogo sarebbe allora evanescente e precaria come il gesto che indica una direzione.
Queste determinazioni debbono invece essere intese come direzioni di movimento, come tendenze che sono radicate nello stesso interno delle cose, nella stessa materia di cui sono fatte.
Aristotele parla della potenza ![]() del luogo: e si richiama alle antiche speculazioni mitiche sulla sostanza ultima delle cose, mistura dei quattro elementi di cui consta la materia. Per sottrarre alle determinazioni locali il loro riferimento soggettivo, dobbiamo prestare attenzione al movimento che per natura spetta ai quattro elementi. «Alto» e «basso» non sono designazioni locali che possano essere scambiate ad arbitrio – ma indicano la possibilità di spostarsi secondo una direzione determinata, in qualche modo prescritta alla cosa stessa che inclina, nel movimento, verso il basso o verso l’alto secondo la sua composizione materiale.
del luogo: e si richiama alle antiche speculazioni mitiche sulla sostanza ultima delle cose, mistura dei quattro elementi di cui consta la materia. Per sottrarre alle determinazioni locali il loro riferimento soggettivo, dobbiamo prestare attenzione al movimento che per natura spetta ai quattro elementi. «Alto» e «basso» non sono designazioni locali che possano essere scambiate ad arbitrio – ma indicano la possibilità di spostarsi secondo una direzione determinata, in qualche modo prescritta alla cosa stessa che inclina, nel movimento, verso il basso o verso l’alto secondo la sua composizione materiale.
Lo spazio ![]() stesso non è inteso come una nozione astratta ma, secondo una connessione anch’essa presente nel pensiero mitico, come totalità indifferenziata che precede l’esistenza delle cose e dei luoghi – il caos di cui narrava Esiodo, come materialità che non ha un ordine, ma nella quale la possibilità di un ordine è comunque già presente come possibilità dell’articolazione locale dell’alto e del basso, dal momento che «anteriore a tutto è la potenza del luogo»[3].
stesso non è inteso come una nozione astratta ma, secondo una connessione anch’essa presente nel pensiero mitico, come totalità indifferenziata che precede l’esistenza delle cose e dei luoghi – il caos di cui narrava Esiodo, come materialità che non ha un ordine, ma nella quale la possibilità di un ordine è comunque già presente come possibilità dell’articolazione locale dell’alto e del basso, dal momento che «anteriore a tutto è la potenza del luogo»[3].
Non vi è dubbio che questi primi passi sono già in grado di mostrarci almeno l’inclinazione che riceve l’intera trattazione aristotelica del problema.
Sarebbe del tutto inesatto affermare che Aristotele non ci offre una teoria dello spazio, ma una teoria del luogo: è certo in-vece che ciò che viene proposto è una teoria dello spazio attra-verso una teoria del luogo. Ma di questa circostanza occorre af-ferrare le ragioni nelle loro implicazioni più profonde. Il problema dello spazio si presenta fin dall’inizio come insepara-bile da quello della materia, cosicché l’una teoria deve svilup-parsi dentro l’altra: una teoria dello spazio dentro una teoria della materia. E a sua volta questa connessione viene considerata alla luce di una nozione di realtà che ha il suo primo modello nella concretezza della cosa materiale, del corpo che c’è nella sua individualità e determinatezza. Di conseguenza la nozione fonda-mentale di una teoria dello spazio diventa proprio quella di luogo.
Di qui d’altra parte derivano tutte le difficoltà nelle quali la discussione subito si avvolge. Ciò di cui abbiamo bisogno è soprattutto la possibilità di operare una chiara distinzione del luogo dalla cosa – una distinzione che non sia semplicemente assunta come ovvia oppure ovviamente presupposta, ma in certo modo giustificata ed estratta dalla formula che ne carat-terizza l’essenza. E proprio su questo punto ci imbattiamo fin dall’inizio in un dilemma di principio. Il luogo esiste, esso c’è.
Ma modello di ciò che c’è, della realtà stessa è appunto il corpo, dal quale il luogo deve essere concettualmente differen-ziato. Ed è senza dubbio possibile affermare che tutte le contro-versie presenti nel testo prendano la forma di argomenti antino-mici, forse non sempre chiaramente formulati (o di non facile interpretazione), ma comunque gravitanti sul contrasto latente tra la tesi della realtà e la tesi della distinzione.
Se il luogo è corporeo non potrai distinguerlo dalla cosa, se è incorporeo non potrai affermare che esso esiste. Questo dilemma si ripresenta secondo diverse varianti che sembrano perseguire un effetto di radicale disorientamento. Dovremmo forse attribuire al luogo un’effettiva consisten-za materiale, in modo da conferire ad esso una condizione essen-ziale della realtà stessa? Ma allora esso sarà solido e impene-trabile come una cosa e non potrà certamente essere occupato da cose.
Il luogo è dunque simile a un ircocervo? No – certamente. Allora potrai porre la domanda intorno al dove, aprendo un processo senza fine. Come sembra dicesse Zenone: «Se tutto l’essere è in un luogo, anche del luogo ci sarà un luogo, e così all’infinito»[4].
Da questo lato non vi è dunque alcuna via d’uscita. Allora potremmo tentare, all’opposto, di indebolire la consistenza materiale del luogo, approssimandolo se non alle irrealtà dell’immagine, almeno allo statuto delle entità che appartengono al pensiero. A una simile considerazione tuttavia subito si oppone la grandezza ![]() del luogo. Il luogo ha tre dimensioni, come i corpi, e proprio perché esso è luogo dei corpi. Dagli elementi intelligibili invece «non deriva alcuna grandezza»[5]. D’altra parte, non possiamo affatto ritenere realmente chiaro che cosa si intenda qui con grandezza del luogo, anche se siamo certi che una grandezza debba essere attribuita ai luoghi e a essa riteniamo di doverci giustamente richiamare per contestare la posizione della sua mera intelligibilità. È chiaro invece ciò che si intende con grandezza di un corpo: della grandezza di un luogo possiamo parlare, a quanto sembra, solo con essenziale riferimento al corpo che ora lo occupa. Ma se il corpo aumenta o diminuisce, come un sacco di grano che ora è vuoto e ora è pieno, diremo forse anche che cresce e diminuisce la grandezza del luogo? Forse dovremmo dirlo: e allora non potremo certo sostenere di distinguere il luogo dal corpo, se portiamo in questo modo a coincidenza la grandezza dell’uno con quella dell’altro.
del luogo. Il luogo ha tre dimensioni, come i corpi, e proprio perché esso è luogo dei corpi. Dagli elementi intelligibili invece «non deriva alcuna grandezza»[5]. D’altra parte, non possiamo affatto ritenere realmente chiaro che cosa si intenda qui con grandezza del luogo, anche se siamo certi che una grandezza debba essere attribuita ai luoghi e a essa riteniamo di doverci giustamente richiamare per contestare la posizione della sua mera intelligibilità. È chiaro invece ciò che si intende con grandezza di un corpo: della grandezza di un luogo possiamo parlare, a quanto sembra, solo con essenziale riferimento al corpo che ora lo occupa. Ma se il corpo aumenta o diminuisce, come un sacco di grano che ora è vuoto e ora è pieno, diremo forse anche che cresce e diminuisce la grandezza del luogo? Forse dovremmo dirlo: e allora non potremo certo sostenere di distinguere il luogo dal corpo, se portiamo in questo modo a coincidenza la grandezza dell’uno con quella dell’altro.
Fra tutti questi argomenti, nei quali l’attenzione riflessiva portata sulla nozione irriflessa di luogo sembra non avere altro risultato che quello di avviarci a passo rapido in una sorta di vero e proprio ingorgo intellettuale, è il caso di indugiare un poco su un argomento che sembra abbia di mira un modo interamente diverso di impostare fin dall’inizio l’intero problema.
L’argomento ammonisce a distinguere il punto dal luogo del punto:essendo qui il punto inteso come spigolo di un corpo e quindi come limite delle linee che sono a loro volta limiti delle sue facce. Il punto dovrà essere distinto dal luogo del punto, altrimenti la linea non potrà essere distinta dal luogo della linea, la faccia dal luogo della faccia e infine il corpo dal suo luogo[6].
La singolarità di questo «argomento» (se vogliamo accettare di chiamarlo così) e anche il suo interesse sta appunto nell’allusione in esso contenuta alla possibilità di un modo di approccio al problema della spazialità e del rapporto tra la cosa e lo spazio che non sia affatto mediato dal problema del luogo. Al corpo nella sua fisicità sensibile-percettiva, per il quale ha subito senso la domanda intorno al dove, tende qui a sovrapporsi e a sostituirsi il solido idealmente inteso, i cui costituenti spaziali – punto, linea superficie – non possono affatto essere messi in questione quanto al loro luogo.
Ciò che Aristotele presenta come un’aporia contiene in realtà un riferimento tacito alla via tracciata dal platonismo, un riferimento che intende ribadire una polemica e confermare una direzione: seguendo quella via la nozione stessa del luogo viene tolta, e quindi anche una posizione del tema dello spazio che ha nella cosa il suo centro.
In ogni caso, la polemica è anticipata nel Timeo platonico, proprio in rapporto a quei due punti, tra loro connessi, che abbiamo richiamato come una sorta di premessa all’avvio della problematica aristotelica del luogo: la teoria dei luoghi naturali e la teoria dei quattro elementi.
Che esistano un alto e un basso irrelativi deve essere, in Platone, duramente contestato, non già sulla base di un pretesti vincolo delle determinazioni spaziali alla soggettività, ma con argomenti che chiamano in causa la struttura stessa dell’universo. Questa struttura è concepita nella tensione di un pensiero che, dalle profondità immaginative del mito, sembra prospettare utopicamente la possibilità di una razionalizzazione completa. Le oscure parole di Timeo sulla totalità intesa come un grande essere vivente, come un animale che «doveva raccogliere in sé tutti gli animali», privo di occhi, «non essendovi rimasto nulla da vedere al di fuori», e di udito, «non essendovi rimasto niente da udire», sono da intendere sullo sfondo dei difficilissimi indugi intorno alla ricerca delle proporzioni matematiche fondamentali – nei quali si riflette la convinzione che nella matematica debba essere ricercata l’essenza profonda del tutto. Un’essenza viva, dinamica, palpitante. La matematica non è forse ciò che dà alla musica il suo respiro? Perciò quell’animale che è l’universo è certamente rotondo, essendo la sfera la più sinfonica di tutte le forme, così come rotonda è la terra che il demiurgo fece a somiglianza dell’universo[7].
In nessun caso allora potremo ammettere l’irrelatività delle regioni dello spazio. Nessun luogo può essere indicato come essenzialmente in alto o essenzialmente in basso: «Perché il luogo che è nel centro dell’universo, di esso non si può dire giustamente né che sia il basso né l’alto, ma proprio il centro: e la circonferenza non è il centro, né ha alcuna parte che sia con il centro in altro rapporto che la parte opposta... ma se uno camminasse intorno a esso in giro, spesso fermandosi in punti fra loro opposti, chiamerebbe necessariamente bassa la medesima parte di quello. E perciò essendo sferico l’universo, come ora si è detto, non è da savio affermare che esso abbia un luogo superiore e uno inferiore»[8].
E nemmeno è da savio chiamare «principi» ![]() il fuoco, l’aria, la terra e l’acqua, proponendoli come lettere di cui consisterebbe l’alfabeto dell’universo, come se ogni parola della natura fosse da esse composta. Una simile teoria della materia si arresta alle apparenze dei sensi senza tenere in nessun conto che esse non possono nemmeno insegnarci che cosa sia fuoco e che cosa aria o terra o acqua, dal momento che di continuo muta il loro aspetto; e ciò che ora abbiamo chiamato acqua, quando si congela, appare pietra e terra, e poi vento e aria quando evaporando si dissolve «e l’aria arsa diviene fuoco, e invece il fuoco compresso e spento diviene nuvola e nebbia, e da queste ancora più contratte scorre acqua, e dall’acqua di nuovo si formano terra e pietre»[9].
il fuoco, l’aria, la terra e l’acqua, proponendoli come lettere di cui consisterebbe l’alfabeto dell’universo, come se ogni parola della natura fosse da esse composta. Una simile teoria della materia si arresta alle apparenze dei sensi senza tenere in nessun conto che esse non possono nemmeno insegnarci che cosa sia fuoco e che cosa aria o terra o acqua, dal momento che di continuo muta il loro aspetto; e ciò che ora abbiamo chiamato acqua, quando si congela, appare pietra e terra, e poi vento e aria quando evaporando si dissolve «e l’aria arsa diviene fuoco, e invece il fuoco compresso e spento diviene nuvola e nebbia, e da queste ancora più contratte scorre acqua, e dall’acqua di nuovo si formano terra e pietre»[9].
In questa vicenda, in cui ogni stato si modifica e trapassa nell’altro, nulla possiamo dire su ciò che permane nella modificazione e che rappresenta la sostanza ultima delle cose.
L’uno e l’altro argomento vengono proposti nello sviluppo di un discorso che ha di mira il tema della totalità e quello dell’origine.Ed è interessante notare che entrambi questi temi sono presenti nel momento in cui lo spazio ![]() viene in questione[10]. Si avverte qui una sorta di impennarsi dello stile – che certo è già elevato e teso fin dall’inizio, quando Crizia cerca di rispondere al singolare desiderio di Socrate di vedere descritta come una realtà vivente quella che sa essere soltanto una realtà utopica, a sua volta in modo singolare, narrando il racconto di un passato profondissimo, precedente a molti diluvi, da cui emerge ancora il ricordo dell’isola in mezzo al mare ignoto, al di là delle colonne d’Ercole. Questo preludio determina l’atmosfera del dialogo intero, ed essa si rinnova quando la parola passa a Timeo, che si spinge ancora più lontano, dalle origini della civiltà alle origini dell’universo, alla sua costituzione intima e ultima: il tema è grande, e pieno di rischi il discorso che deve avventurarsi in un pensare che attraversa i sogni.
viene in questione[10]. Si avverte qui una sorta di impennarsi dello stile – che certo è già elevato e teso fin dall’inizio, quando Crizia cerca di rispondere al singolare desiderio di Socrate di vedere descritta come una realtà vivente quella che sa essere soltanto una realtà utopica, a sua volta in modo singolare, narrando il racconto di un passato profondissimo, precedente a molti diluvi, da cui emerge ancora il ricordo dell’isola in mezzo al mare ignoto, al di là delle colonne d’Ercole. Questo preludio determina l’atmosfera del dialogo intero, ed essa si rinnova quando la parola passa a Timeo, che si spinge ancora più lontano, dalle origini della civiltà alle origini dell’universo, alla sua costituzione intima e ultima: il tema è grande, e pieno di rischi il discorso che deve avventurarsi in un pensare che attraversa i sogni.
Nel momento in cui Timeo si accinge a parlare dello spazio, questa atmosfera raggiunge la massima concentrazione. Qui più che altrove l’esposizione di Timeo assume l’andamento della comunicazione di un arcano che le parole riescono a stento a esprimere ed a comunicare. In più di un punto Timeo denuncia l’oscurità e la difficoltà dell’argomento. Di esso non possiamo sperare di venire a capo mediante un ordinato percorso di deduzioni e di argomentazioni autentiche, ma dobbiamo invece affidarci agli equivoci suggerimenti dell’immaginazione, al punto che la purezza del pensiero risulta a ogni passo compromessa e inficiata dalle immagini. Dobbiamo dunque correre il rischio che i nostri ragionamenti possano apparire come ragionamenti bastardi ![]() [11].
[11].
Bastarda, del resto, è la natura stessa dello spazio: che da un lato, potendo essere detto sempre esistente e indistruttibile, si sottrae alla presa dei sensi e sembra appartenere piuttosto alla sfera di ciò «che è sempre nello stesso modo» e che «non riceve un’altra cosa da altrove, né passa mai in altra cosa»; dall’altro, invece, mantiene certamente una stretta relazione con il mondo delle cose sensibili e percepibili.
Dovremmo forse rammentare anche qui, nel contesto della tematica platonica, che tutte le cose sono in un luogo? Questa era infatti l’affermazione che in precedenza abbiamo cominciato a elaborare fino a ingarbugliare i fili del nostro cervello. E certo questa prosaica verità si riaffaccia proprio a questo punto: ma vedi che cosa ora essa diventa! I fini analitici, argomentativi e dimostrativi, sullo sfondo del problema della ricerca di una formula verbale capace di stringere in pugno l’essenza del luogo – tutto ciò è messo da parte. Perciò muta la direzione dei richiami: il movimento, per esempio, non viene in questione come puro spostamento delle cose da un luogo a un altro luogo, e allo scopo di addurre una prova, ma evoca piuttosto la generazione e la corruzione, la grande vicenda del vivere e del morire: che altro non è se non questo: l’apparire della cosa nello spazio e lo svanire da esso. Lo spazio è «ciò in cui ogni cosa nascendo si mostra e donde di nuovo svanisce»[12].
Palcoscenico del divenire, dunque: il suo teatro eterno. E forse qualcosa di questa immagine è ancora presente in quella, in realtà prevalente nel testo platonico, del ricettacolo.Così viene normalmente tradotta la parola greca ![]() /: nel suo senso essa rimanda all’azione dell’accogliere, a ciò che dà un riparo e un asilo. Questa immagine di un’accogliente cavità si determina e rafforza confluendo con l’idea di un apparire nello spazio che ha il senso del venire all’esistenza.
/: nel suo senso essa rimanda all’azione dell’accogliere, a ciò che dà un riparo e un asilo. Questa immagine di un’accogliente cavità si determina e rafforza confluendo con l’idea di un apparire nello spazio che ha il senso del venire all’esistenza.
Lo spazio è «ricettacolo di tutto ciò che si genera»: perciò può essere detto madre ![]() e nutrice
e nutrice ![]() : uno sviluppo apparentemente inatteso che tuttavia segue un percorso indicato dalla coerenza delle immagini. In forza dì questa stessa coerenza compiamo poi un passo ulteriore: la maternità dello spazio fa tutt’uno con la sua matericità originaria, ed è proprio per questa via che viene ripreso l’arcaico motivo dello spazio-caos, di cui si risentono ancora gli echi nelle pagine aristoteliche.
: uno sviluppo apparentemente inatteso che tuttavia segue un percorso indicato dalla coerenza delle immagini. In forza dì questa stessa coerenza compiamo poi un passo ulteriore: la maternità dello spazio fa tutt’uno con la sua matericità originaria, ed è proprio per questa via che viene ripreso l’arcaico motivo dello spazio-caos, di cui si risentono ancora gli echi nelle pagine aristoteliche.
Lo spazio, la madre, è la materia formativa di tutto. Perciò esso non potrà fin dall’inizio essere articolato in forme, ma è come oro non ancora forgiato, preparato a ricevere tutte le forme e, proprio per questo, affine a nessuna. Come della materia dell’orafo, anche dello spazio si potrà dire che esso è un magma nel quale gli elementi ancora fra loro indistinti, si agitano e ribollono.
Neppure in Platone riusciamo dunque ad andare realmente al di là di un’antica tradizione? Di fatto, se manteniamo la presa sulle nostre premesse e nello stesso tempo badiamo alle conclusioni, ci rendiamo ben presto conto che le cose stanno altrimenti. La discussione era cominciata proprio da una critica alla teoria dei quattro elementi ed essa non si conclude nello spazio-caos, ma in una sua effettiva messa in questione, benché non priva ancora di una profonda equivocità. Ciò che segue alle immagini dello spazio materno e materico è infatti la domanda, resa legittima dalla critica iniziale, sulla natura ultima dei quattro elementi, e nella risposta a questa domanda avviene un radicale ribaltamento che riporta queste conclusioni alla coerenza degli spunti dai quali avevamo preso le mosse.
Che cosa sono infine il fuoco, l’aria, la terra e l’acqua a cui la tradizione attribuisce il carattere di principi ultimi delle cose materiali, di elementi nei quali si dovrebbe risolvere ogni sostanza corporea? Essi non sono altro, a loro volta, che sostanze corporee che si dànno nella comune esperienza dei sensi. Di ciò si è già detto: in nessun caso possiamo attribuire validità a ciò che è soltanto mutevole apparenza, alle qualità immediatamente percepite ed osservate come se esse fossero realmente in grado di condurci in prossimità dell’essenza. L’essenziale viene colto non già osservando la cosa, ma badando alle condizioni della sua concezione, a quei caratteri che in base a esse sono possibili o impossibili. Per esempio, non può esserci corpo senza tridimensionalità. E nemmeno tridimensionalità senza il piano. Il piano poi lo puoi in ogni caso suddividere in superfici di forma triangolare. In proposizioni come queste si manifesta il passaggio a una vera e propria nuova modalità del pensiero che distoglie lo sguardo dalla precarietà del dettaglio, per badare invece alle regole interne che sono costitutive della forma come tale. La corporeità da cui si prende l’avvio sembra alla fine interamente trascesa, e proprio in direzione della sua risoluzione in una spazialità che certo non potrà più essere descritta come un informe impasto materico. Le prime materie ci appaiono ora, nella varietà dei loro modi di apparire, come manifestazioni di un’essenza cristallina: in esse e al di là di esse noi intravediamo i profili dei «quattro bellissimi corpi»[13], le meravigliose consonanze dei solidi regolari alla cui costruzione il triangolo fa da fondamento. Lo stupore della forma sopravanza così il mito della materia.
3. Ripresa del dibattito aporetico
I punti della posizione platonica che abbiamo rapidamente richiamato sono in realtà essenziali per districarsi negli ulteriori sviluppi della discussione aristotelica che continua per un buon tratto a inerpicarsi tra i rovi di una dialettica onnipresente[14]. A quella posizione non si allude soltanto con l’argomento del luogo del punto, ma essa è presente, talora in modo esplicito, in particolare quando viene messa in questione proprio l’opposizione tra la forma e la materia. Ciò che complica il dibattito è che la trama, già fittamente intrecciata, della posizione platonica viene proposta criticamente nel quadro di un’impostazione che mantiene la cosa e il luogo come centro effettivo del problema.
In Platone, invece, anche se in modo certamente non esplicito, si tende a prospettare l’intera problematica secondo una nozione di spazialità astrattamente intesa come pura estensione.
In particolare è importante, per cogliere i successivi sviluppi della discussione aristotelica, interpretare correttamente l’espressione «materia della grandezza» ![]() riportandola all’area problematica dell’impostazione platonica. Con «materia della grandezza» non si intende in realtà alcuna effettiva sostanzialità materiale, ma unicamente una quantità di estensione, che è circoscritta e racchiusa da una determinata forma, ma che, considerata appunto come mera quantità, non ha con questa forma alcun legame intrinseco. Così due solidi o due figure di diversa forma potrebbero avere lo stesso volume ovvero la stessa area. Noi parleremmo in tal caso della stessa materia della grandezza, della stessa quantità dello spazio-estensione. In senso analogo dovrebbe essere interpretata l’espressione «intervallo della grandezza»
riportandola all’area problematica dell’impostazione platonica. Con «materia della grandezza» non si intende in realtà alcuna effettiva sostanzialità materiale, ma unicamente una quantità di estensione, che è circoscritta e racchiusa da una determinata forma, ma che, considerata appunto come mera quantità, non ha con questa forma alcun legame intrinseco. Così due solidi o due figure di diversa forma potrebbero avere lo stesso volume ovvero la stessa area. Noi parleremmo in tal caso della stessa materia della grandezza, della stessa quantità dello spazio-estensione. In senso analogo dovrebbe essere interpretata l’espressione «intervallo della grandezza» ![]() – più precisamente essa dice in termini di vuoto, ciò che l’espressione materia della grandezza dice nei termini dell’astratta pienezza dello spazio-estensione.
– più precisamente essa dice in termini di vuoto, ciò che l’espressione materia della grandezza dice nei termini dell’astratta pienezza dello spazio-estensione.
Data la forma della cosa, che nel senso più elementare della parola non significa altro che il suo contorno, potrai intendere ciò che si trova all’interno di questo contorno sia come vuotezza che la cosa nella sua concretezza riempie, sia come porzione dell’estensione.
Queste proposte interpretative sembrano trarre una loro conferma dall’efficacia con la quale ci consentono di cogliere i nodi essenziali della discussione aristotelica.
Essa prende nuovamente le mosse con una distinzione che precisa il problema e, dopo tante controversie, con una prima affermazione positiva.La distinzione è quella tra luogo comune ![]() «nel quale stanno tutti i corpi» e luogo particolare
«nel quale stanno tutti i corpi» e luogo particolare![]() , che è quello che «immediatamente contiene ciascun corpo»[15].
, che è quello che «immediatamente contiene ciascun corpo»[15].
Poiché lo scopo di Aristotele è quello di costituire lo spazio a partire dal luogo, e non inversamente, la nozione di luogo comune, in quanto richiama già la problematica dello spazio, andrà provvisoriamente messa da parte, concentrando invece tutta la nostra attenzione sul luogo particolare.
In rapporto ad esso abbiamo la prima affermazione positiva: il luogo particolare, proprio in quanto contiene immediatamente il corpo, «sarà allora, un certo limite![]() »[16].
»[16].
Ma come dovrà essere propriamente intesa questa affermazione il cui senso non sembra affatto essere subito chiaro? Forse parlando di «limite» intendiamo dire che il luogo aderisce alla cosa in ogni sua piega come un guanto rispetto alla mano? Cosicché, per esempio, il mio luogo particolare terminerà esattamente nel punto in cui terminano la mia testa, le dita delle mie mani o dei miei piedi. Forse potrei dire di occupare anche il luogo che sta pochi centimetri al di sopra della mia testa? Invece, è come se intorno al mio corpo fosse ritagliata la sua sagoma. E questa sagoma è il suo luogo.
Potremmo allora tentare di spiegarci così: ora io depongo un cubetto su questo tavolo. E comprenderemo certo che cosa intendiamo dire, parlando di «un certo limite» se, tolto il cubetto, riusciamo ancora a intravederne la sagoma evanescente come immagine del luogo particolare che esso poco fa occupava.
Sono realmente corrette queste illustrazioni? In realtà stando a esse non potremmo sfuggire alle riduzioni che esse suggeriscono. Alla riduzione del luogo alla forma ![]() – anzitutto: e ciò è certamente suggerito dal richiamo ai contorni e alle sagome delle cose. Ma queste illustrazioni sosterrebbero altrettanto bene la riduzione del luogo a ciò che è fra i contorni, dunque alla «materia» (o all’«intervallo») della grandezza. Se ciò è vero, allora ci siamo allontanati di poco dalle nostre difficoltà iniziali: se a partire dalla concezione del luogo come limite, che sembra trovarsi sulla giusta via, la si sviluppa nella direzione suggerita dai presupposti platonici, si perviene all’identificazione del luogo o con la forma o con la materia, e la conseguenza di ciò è ancora una volta l’incapacità di distinguere con autentica chiarezza concettuale il luogo dalla cosa: «La forma
– anzitutto: e ciò è certamente suggerito dal richiamo ai contorni e alle sagome delle cose. Ma queste illustrazioni sosterrebbero altrettanto bene la riduzione del luogo a ciò che è fra i contorni, dunque alla «materia» (o all’«intervallo») della grandezza. Se ciò è vero, allora ci siamo allontanati di poco dalle nostre difficoltà iniziali: se a partire dalla concezione del luogo come limite, che sembra trovarsi sulla giusta via, la si sviluppa nella direzione suggerita dai presupposti platonici, si perviene all’identificazione del luogo o con la forma o con la materia, e la conseguenza di ciò è ancora una volta l’incapacità di distinguere con autentica chiarezza concettuale il luogo dalla cosa: «La forma ![]() e la materia
e la materia ![]() sono inseparabili dalla cosa, il luogo invece si ammette come separabile»[17].
sono inseparabili dalla cosa, il luogo invece si ammette come separabile»[17].
La nostra prima affermazione positiva intorno al luogo ha avuto dunque anch’essa uno sviluppo aporetico. Da questo primo passo verso una definizione sembra si debbano trarre nuove e insolubili difficoltà argomentative. Secondo ciò che ci è sembrato di capire, tuttavia, non è quella indicazione del luogo come limite che deve essere soppressa, ma deve essere invece corretta l’interpretazione che di essa si può dare nella tacita assunzione di presupposti platonici.
Nello stesso tempo cominciamo ad avere la sensazione che qualcosa debba essere mutato nel modo stesso in cui procede l’indagine. Essa rischia di continuo di andare verso un punto morto. E la ragione di ciò sta anzitutto nel fatto che la nozione di luogo è stata fin qui assunta astrattamente, come una nozione vuota, che sembra fatta di nulla. Proposta in questa vuotezza, essa viene subito risucchiata nel vortice dell’argomentazione aporetica.
Invece dovremmo forse, proprio in vista e per le esigenze di una razionalizzazione, riflettere su un terreno che non sa ancora nulla di pure determinazioni razionali ed è tuttavia in grado di indicarci una strada. Così Aristotele ci invita a indugiare sulle parole di luogo, e in particolare sulla paroletta in ![]() che risponde normalmente alla domanda intorno al dove, avviando un modo della riflessione che, pur essendo strettamente intrecciato con momenti argomentativi, ha piuttosto il carattere di un’analisi e di un’esplorazione del senso, di una chiarificazione concettuale che può finalmente avvalersi della pienezza degli esempi.
che risponde normalmente alla domanda intorno al dove, avviando un modo della riflessione che, pur essendo strettamente intrecciato con momenti argomentativi, ha piuttosto il carattere di un’analisi e di un’esplorazione del senso, di una chiarificazione concettuale che può finalmente avvalersi della pienezza degli esempi.
Certamente non basta segnalare la relazione dell’in che compare nella risposta al dove che compare nella domanda. Dobbiamo invece mettere subito in evidenza la possibilità di impieghi differenti.
Si dice per esempio: il dito è nella mano e la mano non è un luogo o qualcosa di simile a un luogo. Noi potremmo infatti parafrasare il senso di questa frase sopprimendo il riferimento al luogo, poiché dire che il dito è nella mano significa dire che appartiene a essa, che è, concretamente, una sua parte.Ma si può dire anche che l’animale è nell’uomo, per indicare il rapporto tra genere e specie, che è anch’esso concepibile come un rapporto di parte. E come posso dire che una parte è nell’intero, così anche che un intero è nelle sue parti, cioè consiste in esse.
Il nostro primo compito – analitico, piuttosto che argomentativo – è quello di indicare il senso propriamente locale della parola, districandolo da impieghi differenti, e soprattutto da quegli impieghi che mettono in questione il nesso dell’intero e della parte.
Il senso propriamente locale è concretamente illustrato da un paragone che contiene la possibilità di un’immagine: «Il luogo sembra essere qualcosa di simile ad un vaso ![]() »[18]; essere in un luogo è essere «come in un vaso»[19]. La relazione dell’acqua o del vino in un’anfora – su di essa conviene riflettere se vogliamo chiarire la natura del luogo. E ora certamente quel mutamento nello stile della ricerca che era già implicito nel passare in primo piano del riferimento linguistico riceve un approfondimento ulteriore: diventa infatti sempre più chiaro che il momento propriamente argomentativo, che premette e deduce, che contrappone tesi a tesi provando e contro provando, non procede, nonostante ogni apparenza, in una pura e autonoma elucidazione concettuale. Ci sembra ora particolarmente significativo il fatto che quel paragone fosse presente in modo apparentemente irrilevante – al punto che allora non ne avevamo nemmeno preso nota – quando, nelle battute iniziali, si parlava dell’acqua che cede il luogo all’aria, da esso defluendo «come da un vaso»[20]. E come se fin dall’inizio ci fossimo trovati sotto il segno di quell’immagine, come se il pensiero del luogo fosse stato da essa subito catturato e ne avesse nascostamente seguito la guida, che diventa ora esplicita e manifesta.
»[18]; essere in un luogo è essere «come in un vaso»[19]. La relazione dell’acqua o del vino in un’anfora – su di essa conviene riflettere se vogliamo chiarire la natura del luogo. E ora certamente quel mutamento nello stile della ricerca che era già implicito nel passare in primo piano del riferimento linguistico riceve un approfondimento ulteriore: diventa infatti sempre più chiaro che il momento propriamente argomentativo, che premette e deduce, che contrappone tesi a tesi provando e contro provando, non procede, nonostante ogni apparenza, in una pura e autonoma elucidazione concettuale. Ci sembra ora particolarmente significativo il fatto che quel paragone fosse presente in modo apparentemente irrilevante – al punto che allora non ne avevamo nemmeno preso nota – quando, nelle battute iniziali, si parlava dell’acqua che cede il luogo all’aria, da esso defluendo «come da un vaso»[20]. E come se fin dall’inizio ci fossimo trovati sotto il segno di quell’immagine, come se il pensiero del luogo fosse stato da essa subito catturato e ne avesse nascostamente seguito la guida, che diventa ora esplicita e manifesta.
Tuttavia, stando ad Aristotele, non è sufficiente la semplice esibizione dell’analogia dell’acqua o del vino nell’anfora per separare il senso locale dell’in da ogni possibile equivoco con il rapporto parte-intero. Intanto, l’anfora-di-vino può essere considerata come un intero le cui parti sono appunto l’anfora e il vino. Perciò l’anfora è certamente, come il vino, nell’anfora-divino. Potremmo dire addirittura che essa è in o dentro se stessa: ma qualora decidessimo di esprimerci in questo modo, quelle espressioni sarebbero solo apparentemente impiegate in senso locale, dal momento che, come abbiamo premesso, «sono parti dell’intero sia ciò in cui una cosa è, sia ciò che è in questa»[21]. Inversamente, non sarà ammissibile dire di una cosa che sta in o dentro se stessa, se l’in o il dentro hanno senso locale. L’alterità della cosa e del luogo viene dunque ribadita come una condizione essenziale. Così come viene ribadito che il luogo non consisterà né nella materia né nella forma, essendo esse parti di ciò che è in un luogo.
È interessante notare in margine, benché si tratti di un rilievo per nulla marginale, che è presente in Aristotele la convinzione o almeno il sospetto che la stessa struttura dell’argomentazione aporetica sorga da un impiego abile e nascosto di una stessa parola secondo significati differenti.
Ciò risulta con chiarezza dalla proposta di «risolvere» l’aporia di Zenone attraverso la duplice possibile interpretazione dell’in.
Se noi parliamo di un luogo come di un’entità, certamente può accadere che subito sorga la domanda sul luogo del luogo. Ma nessun processo all’infinito si darebbe se l’in fosse impiegato la prima volta come parola locale, la seconda nel senso del rapporto di parte. Se per esempio diciamo che la cosa è in un luogo e il luogo è nello spazio, solo nel primo impiego l’in è un’autentica parola locale.
Tuttavia non si è ancora chiarito che cosa ci insegni l’immagine dell’anfora, che cosa, attraverso di essa venga pensato intorno al luogo. Anzitutto la nozione di luogo riguarda un rapporto che è quello di un contenuto in un contenente – ed essa si dispone dalla parte del contenente. La metafora dell’anfora si addice in particolare proprio perché attira l’attenzione sulla corposità del luogo – l’essere in un luogo è proprio l’essere-dentro, come in un vaso, quindi il luogo viene proposto anzitutto esso stesso come una cosa: non come una sorta di ombra evanescente della forma. Di qui possiamo poi ottenere un definitivo chiarimento sulla nozione di limite, per il quale il riferimento al rapporto contenente-contenuto, di cui in precedenza non potevamo ancora disporre, svolge un ruolo essenziale.
Il primo luogo, cioè il luogo particolare, non è né maggiore né minore del contenuto, ma non per questo è da intendere come sagoma del contenuto. Piuttosto dovrà essere inteso come limite interno del contenente.Con questa concezione del limite, non certo priva di problemi, la corposità del luogo, che non può non essere anzitutto sottolineata, riceve tuttavia indubbiamente un’attenuazione, dal momento che il luogo non coinciderà affatto con la cosa contenente come tale, e per questo verso si può dire che esso non sia affatto una cosa.
L’anfora e il vino ci insegnano ancora che fra la cosa e il suo luogo vi è, a un tempo, contiguità e discontinuità.
Peraltro, l’una nozione implica l’altra, poiché con contiguità ![]() si intende qui, all’incirca, il contatto, e questo presuppone la «massima vicinanza», l’«aderenza», ma si contrappone anche alla continuità
si intende qui, all’incirca, il contatto, e questo presuppone la «massima vicinanza», l’«aderenza», ma si contrappone anche alla continuità ![]() , un termine che indica invece una fusione: «Vi è continuità tra oggetti le cui estremità si unificano, si confondono, contiguità tra quelli le cui estremità coincidono»[22].
, un termine che indica invece una fusione: «Vi è continuità tra oggetti le cui estremità si unificano, si confondono, contiguità tra quelli le cui estremità coincidono»[22].
Su questo punto è tuttavia il caso di diffonderci in una spiegazione un poco più precisa.
Come esempio di fusione, possiamo pensare ancora all’acqua, al vino, a una qualunque sostanza fluida. E possibile sostenere allora che l’acqua contenuta in un vaso sia composta di particelle, e ciò che intendo lo illustro vuotando il vaso goccia a goccia. L’acqua del vaso è composta di tante piccole gocce: esse sono le parti e il loro modo di essere all’interno del vaso illustra la nozione della continuità e della fusione. Una goccia d’acqua è certamente nell’acqua – chi potrebbe negarlo? Ma non ha un luogo.Più precisamente: non ha un luogo in atto, ma solo in potenza. Dunque, non ha un luogo, ma può averlo. Per esempio, da questo vaso io verso ora una goccia, esattamente in questo punto, sul tavolo. Ora la goccia ha un luogo, che prima non aveva perché era soltanto una parte fusa con le altre parti nell’intero. Solo di ciò che ha carattere di cosa, e quindi solo di un’entità corporea solidamente contraddistinta da altre entità corporee, che è determinatamente individuata, si può dire che essa sia in un luogo. Questa è la condizione della discretezza. Invece, «quando il contenente non è discreto, ma continuo, allora si dice che il corpo è in esso non come in un luogo, ma come parte nel tutto»[23]; «alcune cose sono in un luogo in potenza, altre in atto. Perciò quando un corpo omogeneo sia continuo, le parti sono in luogo in potenza, altre in atto. Perciò quando un corpo omogeneo sia continuo, le parti sono in luogo in potenza; quando invece esse siano separate, ma contigue, come in un mucchio, lo sono in atto»[24].
Queste considerazioni confermano la direzione complessiva secondo cui l’intera tematica è stata fin qui sviluppata, ma anche contribuiscono in modo determinante al suo chiarimento. Da esse risulta confermato che la nozione di luogo è una nozione relazionale, ma in un senso strettamente definito dal percorso che è stato seguito e dai presupposti che lo hanno determinato fin dal suo primo punto di avvio. La nozione di luogo deve in effetti essere risolta nella relazione dell’essere in un luogo, e questa a sua volta va intesa come essere in un corpo secondo modalità e condizioni che sono state or ora definite. Dunque il luogo c’è solo se ci sono i termini della relazione, che debbono essere corpi – il corpo che contiene e il corpo che è contenuto. Ma se abbiamo ragione nel sottolineare questo punto, allora hanno torto quegli interpreti che hanno ritenuto di vedere emergere già in Aristotele consistenti anticipazioni della futura teoria relazionale dello spazio così come viene prospettata con particolare chiarezza in Leibniz[25]. Si tratta invece di una differenza semplicemente irrimediabile, ed è giusto che sia così.
Infine, il richiamo al problema della continuità e in generale dell’intero assolve una funzione determinante nel bloccare verso l’interno e verso l’esterno quel processo di relativizzazione reciproca del luogo e del corpo, del contenente e del contenuto, che si apre in modo ovvio a questo punto.
Ciò che è luogo rispetto ad un corpo che contiene, è corpo rispetto a un luogo da cui è contenuto.
Ma questo processo incontra, verso l’interno, un limite nel raggiungimento di interi costituiti di parti continue e, verso l’esterno, nel raggiungimento della totalità stessa.
Abbiamo detto: l’acqua nell’anfora: ma una goccia di quest’acqua dovrà avere un luogo, e ciò per tutte le gocce così come per le gocce di cui constano le gocce? Abbiamo spiegato che così non è.
Verso l’esterno, le anfore diventano sempre più grandi fino ad un contenente che da nessuna altra cosa può essere contenuto. Questo contenente assoluto è il cielo: esso è infatti il tutto – «e il tutto non è in nessun luogo»[26]. Perciò Aristotele dice che tutte le cose sono nel cielo![]() [27].
[27].
Prima di stringere le considerazioni fin qui sviluppate nella sintesi di una definizione, dobbiamo compiere un ultimo passo. Infatti il tema della relativizzazione, che noi abbiamo richiamato nel contesto della questione dell’intero e della parte, si presenta in Aristotele prevalentemente nella prospettiva del tema del movimento.
La connessione tra la nozione di luogo e quella di movimento, che era già presente all’inizio della discussione, si ripresenta ora con particolare forza, poiché non si afferma soltanto che la realtà del movimento implica quella del luogo, ma piuttosto che la questione del luogo non si porrebbe nemmeno se non vi fosse movimento. Questa osservazione non ha lo stesso senso della precedente: in essa si sostiene infatti che qualora tutte le cose fossero in quiete, noi non ci interrogheremmo intorno al luogo per il semplice fatto che esse non ci apparirebbero in un luogo. Il movimento diventa allora una condizione per districare la determinazione locale della cosa dalla cosa stessa: cosicché è certamente possibile affermare che, nel senso della considerazione aristotelica, le cose ci appaiono in un luogo solo nel momento in cui lo abbandonano[28].
Il tema del movimento viene ora riproposto nel quadro dell’impostazione più complessa che siamo venuti delineando. Non solo infatti si può muovere il corpo, ma anche l’altro corpo che lo contiene e il cui limite interno è il suo luogo. Il vaso è un luogo trasportabile [29] – da poppa a prua, per esempio, sulla navicella che risale la corrente del fiume.
Naturalmente le condizioni che abbiamo fissato discutendo la problematica dell’intero e della parte si faranno valere anche nel caso del movimento, e in particolare la condizione della contiguità.
Osserva Aristotele: «Se l’oggetto è in continuità con il suo contenente, esso non si muove nel contenente, ma insieme con questo; se invece è diviso, si muove in questo: e tanto se si muove il contenente, tanto se non si muove, esso tuttavia si muove» [30]
Dunque il pesce si muove dentro l’acqua dell’anfora che viene trasportata da poppa a prua o lasciata dove si trova sulla navicella che risale la corrente del fiume – non invece la goccia nell’acqua, ma l’acqua con l’anfora, se questa viene mossa.
Questa precisazione chiama direttamente in causa la relatività del movimento: l’affermazione incondizionata di questa relatività minaccia la decisione intorno a ciò che può essere detto realmente in moto oppure in quiete e sembra condurre a una vera e propria dissoluzione della nozione di luogo e di essere in un luogo.
Dobbiamo allora prendere atto che il limite della nostra immagine guida sta proprio in quella affermazione che alludeva alla mobilità del luogo e che poco fa ci è sembrata ancora pertinente. Ma essa lo è solo per mettere in evidenza una nozione relativa di luogo che esige, a suo stesso sostegno, una nozione assoluta.
Non dobbiamo dire soltanto che il vaso è un luogo trasportabile, ma piuttosto: «Come il vaso è un luogo trasportabile, così anche il luogo è un vaso intrasportabile»[31].
Grande sapienza dei filosofi! E noi, muniti di questa sapienza, siamo ormai in grado di comprendere la definizione aristotelica del luogo nella sua ultima forma: |
«Il luogo è il primo limite immobile del contenente»[32].
Avevamo già detto e fatto valere nel corso della discussione che il luogo è il limite del contenente. Ora si aggiunge, come integrazione necessaria, che questo limite è il primo, incontrato risalendo lungo la catena dei contenenti, che non si muova in senso assoluto.
Dall’acqua all’anfora, dall’anfora alla navicella, dalla navicella al fiume – sino all’intero immobile.
Risalendo lungo la catena dei contenenti, siamo destinati ancora una volta ad arrivare sino al cielo.
6. Riconsiderazione dell’intera problematica da un nuovo punto di vista
Abbiamo così detto in parole che cosa è il luogo. Questo era fin dall’inizio il nostro scopo: mostrare che la nozione ovvia del luogo diventa un problema nel momento in cui vogliamo dare di essa una effettiva determinazione razionale, nel momento in cui vogliamo concettualizzarla, e quindi dare di essa una formulazione verbale.
Dobbiamo allora sottoporre quella nozione, le sue possibili attribuzioni, i vari modi di concepire il rapporto del luogo con i corpi, alla prova del pensiero argomentante, che tenta di aggredire ogni proposta definitoria per saggiarne la solidità. Lo scopo era quello di pervenire alla fine a una definizione del luogo logicamente in ordine, dalla quale non possano essere dedotte tesi contradditorie. La chiarificazione che viene qui perseguita deve mettere capo a una formulazione verbale dell’essenza che resista a ogni possibile confutazione argomentativa. La chiarezza è qui il risultato di una teorizzazione che si è venuta costruendo di passo in passo.
Il luogo è il primo limite immobile del contenente. E anche noi vorremmo proprio poter esclamare con Aristotele, all’inizio della quarta sezione, nella quale quella definizione viene finalmente raggiunta: «Orbene, che cosa mai sia il luogo, ecco come potrebbe diventare chiaro!»[33].
Ma con quale effettiva convinzione possiamo realmente fare nostra questa frase? Certamente, nel corso della nostra lettura, abbiamo imparato a riconoscere il problema, a notarne la rilevanza, a coglierne le diramazioni e le complicazioni. La questione del luogo, che in precedenza ci sembrava di scarso peso, è esplosa nella nostra testa – e poi siamo anche riusciti a seguire la complessa opera di ricomposizione, e quindi a renderci conto delle motivazioni interne delle tesi che cominciano a prendere positivamente consistenza nell’esposizione di Aristotele fino alla proposta della definizione conclusiva.
Eppure dobbiamo confessare che, per evitare che si disperda quel tanto o poco che ci è sembrato di aver compreso, ci tocca quasi trattenere il respiro.
Perciò vorremmo ritornare sui nostri passi, da un lato ripensando alle tesi aristoteliche e al loro modo di procedere, dall’altro riprendendo da capo e in modo più libero queste nostre riflessioni sul luogo.
Ancora prima che sulla definizione proposta o sui momenti che conducono a essa, vi sono dubbi che riguardano la direzione nella quale si è subito orientata la chiarificazione filosofica. Come abbiamo osservato or ora, essa prospetta la nozione da chiarire come una nozione che deve essere liberata dalle sue impurità, sottraendola alle ovvietà degli impieghi correnti e integrandola saldamente nel contesto di una teoria. Ciò che si cerca fin dall’inizio è una giustificazione razionale, anche là dove l’esperienza della spazialità non vede alcun problema. Perciò da questa esperienza si prendono subito le distanze, mirando invece all’essenza che l’argomentazione ha il compito di mostrare e circoscrivere.
Il dubbio riguarda proprio questo modo di intendere il problema, di proporlo e di costruirlo. L’attenzione filosofica non potrebbe forse indugiare più a lungo nell’ambito di considerazioni che precedono le proposte razionalizzatrici e che non per questo sono prive di un’autentica portata concettuale? E realmente necessario impostare il compito della chiarificazione come se esso dovesse necessariamente mettere capo a una definizione?
Del resto abbiamo già potuto segnalare anche in Aristotele la presenza di uno spunto significativo in questa direzione, benché sovrastato da una dimensione argomentativa nettamente prevalente.
Nel bel mezzo del dibattito aporetico, Aristotele sembra interrompere il flusso delle argomentazioni, come se fosse assalito da un ricordo improvviso. Aristotele si ricorda dei giochi linguistici correnti, delle parole che ricorrono in essi indicando determinazioni locali. E tra queste, soprattutto, dell’in. Si ricorda di luoghi come anfore e vasi.
«Il lavoro del filosofo consiste nel mettere insieme ricordi per uno scopo determinato».
In questa frase di Wittgenstein[34], il legame tra la filosofia e la memoria non ha il senso dell’acquisizione di un’evidenza razionale, di un sapere profondo che coincide con il sapere intorno all’essenza, nello spirito della filosofia platonica. Ci si richiama al ricordo soprattutto per il fatto che nel ricordo ciò che è già oscuramente presente nella nostra mente viene portato alla luce, volendo nello stesso tempo sottolineare che ricordarsi non significa qualcosa di simile a inventare o escogitare, e nemmeno propriamente concatenare l’un concetto all’altro, non significa «fare un ragionamento». Beninteso, deve esservi uno scopo particolare, un tema determinato che attrae i nostri ricordi filosofici; e la determinatezza dello scopo ci guida nel «mettere insieme» questi ricordi, cioè nel dare a essi un ordine, nello stabilire nessi, nel rintracciare percorsi, nuove vie della riflessione.
I ricordi di cui consta la filosofia, infine, non sbucano dal nulla ma, come del resto accade per i ricordi in genere, vi deve essere una motivazione interna che renda conto del loro sorgere. Così, se Aristotele si rammenta anzitutto dell’in, ciò è coerente con il presupposto del luogo come nozione oggettiva, quindi con la centralità che la cosa assume per la sua elucidazione fino agli esiti conclusivi nei quali la teoria del luogo si ricongiunge con una teoria dello spazio del mondo e infine con una teoria dell’universo. Nel quadro di una ricerca oggettivamente orientata, come è quella aristotelica, il luogo deve esserci già fin dall’inizio – e ci si rammenta dell’in proprio perché questa paroletta lo presuppone.
Il nostro dubbio iniziale può trovare ora una formulazione più decisa: il problema della chiarificazione può essere proposto modificando l’atteggiamento stesso della ricerca, imprimendo a essa un orientamento soggettivo anziché oggettivo, così da illustrare non già che cosa il luogo in se stesso sia, ma in che modo a partire da determinazioni soggettive si pervenga alla posizione oggettiva. La nozione del luogo, anziché essere presupposta, deve allora addirittura essere soppressa e la sua chiarificazione può realizzarsi dinamicamente mostrando come essa si formi, come essa sorga e che cosa essa divenga. I concetti si formano.E noi vogliamo esaminare i passi di questa formazione.
Perciò quelle determinazioni soggettive che Aristotele segnala solo di scorcio, per sottolinearne l’irrilevanza o la non pertinenza a causa della dimensione di soggettività che esse comportano, diventano i punti di forza di un nuovo inizio.
Il nostro primo passo consiste nel fare regredire la nozione del luogo a quella del qui. Noi ci siamo rammentati del qui.
Ma che senso può mai avere questo stravagante conflitto tra parole così piccole? Possiamo seriamente sperare di illustrare in questo modo le impegnative prese di posizione che abbiamo or ora compiuto? L’espressione «qui», certo, non designa in se stessa alcun luogo, essendo il suo senso solo soggettivamente determinato. Ma a questa determinazione soggettiva può essere associata una determinazione obbiettiva.
La nozione di luogo è dunque anche in questo caso ovviamente presupposta.
Una simile osservazione critica trae la sua apparente ovvietà dal fatto che, se mi venisse chiesto di parafrasare il senso della frase «io sono qui», forse sarei tentato di rispondere che essa dice che una determinata persona si trova a una certa ora in un edificio di una città lombarda, ecc. La frase «io sono qui» direbbe dunque all’incirca che c’è una determinata cosa in un luogo determinato del pianeta terra.
Se una risposta come questa fosse realmente pertinente, l’obiezione avrebbe una sua evidente ragione d’essere. Ma è certo soltanto che quella parafrasi opera un’obbiettivazione dell’espressione, ma non è affatto – come potrebbe credere una filosofia del linguaggio infarcita di pregiudizi – un’esplicitazione del suo senso.
Quando operiamo quella parafrasi, infatti, presupponiamo un orizzonte di conoscenze implicite, per quanto rozze, che sono tuttavia sufficienti a realizzare una localizzazione in qualche modo «obbiettiva». Ma si può sostenere che questo orizzonte può essere indebolito sino alla sua soppressione senza che per questo venga necessariamente meno il significato della parola «qui». Che la nozione di luogo sia già costituita, che essa abbia già preso forma, non è affatto una condizione necessaria per il suo impiego.
Anche un bambino ha il senso del qui – ma questo senso non può affatto essere illustrato attraverso l’idea di una concatenazione di luoghi che deve dare per presupposta una nozione, per quanto rozza, di spazialità geografica e persino astronomica.
L’espressione «senso del qui» è del resto impiegata in modo intenzionalmente ambiguo. Con essa noi vorremmo richiamarci non tanto al significato della parola, quindi al versante linguistico del problema; vorremmo invece alludere al sentimento che sostiene quel significato. Ciò non rappresenta in realtà una psicologizzazione della questione, come una simile terminologia potrebbe certamente far sorgere il sospetto. Abbiamo invece essenzialmente di mira ciò che si può trarre da esempi di impiego concreto della parola.
Io sono entrato una volta in un’aula dicendo: eccomi qui! E nessuno può aver pensato che io abbia inteso dire: ecco G.P. che sta occupando un luogo determinato sul pianeta terra. Infatti, con quella frase io non ho voluto dare un’informazione, e in particolare non un’informazione intorno al luogo. Non ho fatto questo. Ma intendevo fare qualcosa. Sarei potuto entrare nell’aula zitto zitto – come faccio di solito. Del resto, che io fossi lì lo hanno visto tutti. Ma intendevo manifestare la mia presenza, anzi operare di essa un rafforzamento:come se, dicendo questo, mi mettessi al riparo dal rischio di passare inosservato.
Naturalmente può anche accadere che dicendo «qui», questa parola mi inchiodi nel luogo nel quale ora mi trovo. Infatti, non si tratta di negare che essa possa avere un impiego tale da presupporre il luogo, ma soltanto di riconoscere che vi è un impiego più primitivo nel quale l’orizzonte spaziale oggettivo, lo stesso sapere che vi sono luoghi e che noi stessi siamo in un luogo, può essere interamente ridotto, così da contrarre quell’orizzonte sino a una sorta di ultimo residuo.
Il qui non designa affatto un luogo. In generale, questa parola non ha alcuna funzione deittica, e nemmeno opera per integrare e completare un’indicazione, ma esplica una funzione essenzialmente espressiva.In essa la soggettività intende non solo rendere manifesta la sua presenza, ma soprattutto imporla ad altri: come se dal fondo della scena avanzasse imperiosamente sul proscenio. Nulla sarebbe perciò più erroneo che interpretare la riduzione dell’orizzonte spaziale oggettivo come una sorta di riduzione alla pura interiorità. La presenza di cui stiamo parlando non è affatto la presenza di sé a se stesso, tutta volta verso l’interno: al contrario, è proprio una presenza esteriore, corposa ed imponente, che dal qui si fa guardare.
È appena il caso di dirlo: ad un’interpretazione del qui dovrà certo far seguito un’interpretazione del là, sviluppata in stretta coerenza con l’impostazione precedente. Considerate come designazioni locali, queste parole hanno in comune la circostanza che né l’una né l’altra determinano propriamente un luogo. L’unica differenza – irrilevante da un punto di vista obiettivo – consisterebbe nel fatto che l’una designa un luogo vicino, l’altra invece un luogo lontano dall’io. Ma noi non abbiamo fatto valere un’interpretazione del qui in quanto luogo vicino all’io o addirittura da esso occupato.
La soggettività occupa un luogo? Ciò sembra ovvio: eppure può anche suonare falso, come se quella espressione comportasse una staticità, una pesantezza assai poco pertinente. Perciò noi abbiamo mostrato la necessità di adottare un punto di vista diverso in cui venga posto l’accento, piuttosto che sul luogo come nozione obiettiva, sul proporsi della soggettività che manifesta il suo esserci. Il qui è quel luogo prima del luogo nel quale la soggettività stessa si fa avanti.
Tenendo conto di questa linea dell’interpretazione e assumendo il punto di vista che comporta, appare subito chiaro il sussistere di una profonda differenza che riguarda anzitutto la funzione.
Ciò che ci apprestiamo a sostenere è che, mentre nel caso del qui la funzione espressiva prevale su quella deittica, il là si contrappone al qui proprio per il fatto che in esso la funzione deittica diventa dominante.
Il là è una parola anzitutto indicativa.
Ma ciò non vuol dire certamente che passiamo d’un balzo al luogo come nozione obbiettiva, come se a esso fosse senz’altro rivolta la designazione. In realtà noi ci manteniamo, inizialmente, all’interno di quella soggettivazione estrema che ci aveva indotto a portare a coincidenza il qui con la soggettività stessa. Nei suoi dintorni, di fronte a essa, c’è la cosa, ed è proprio la cosa che è ora puntata dal là:non invece il luogo che essa occupa, dal momento che questa nozione non è ancora costituita, ma è incorporata nella cosa-là. A questo livello del problema, l’essere-là appartiene alla cosa come una determinazione a essa essenzialmente inerente, cosicché ciò che viene indicato con la parola o con il gesto è un’unità tangibile e percepibile, nella quale la determinazione locale è ancora fusa e indistinta. E tuttavia cominciamo a intravedere come, a partire da questa condizione di indistinzione, si venga a prospettare la nozione obbiettiva del luogo e conseguentemente quella connessione concettuale tra la cosa e il luogo che ci era parsa così piena di oscurità e di enigmi nella nostra introduzione aristotelica al problema.
La nozione del luogo e la sua connessione con la cosa deve certamente apparire profondamente oscura se la discussione prende le mosse da formulazioni obbiettive: se il luogo senz’altro c’è, allora deve essere in qualche modo concepito come una entità indipendente. Ma che cosa mai può voler dire percepire soltanto un luogo? Alla pretesa legittima che esso debba essere percepito sembra far da contrappeso il dubbio altrettanto legittimo che esso non possa affatto esserlo: la nozione di luogo comincia così a fluttuare tra lo statuto di oggetto del pensiero e quello di oggetto della percezione. Il dilemma tra la «corporeità» e l’«incorporeità» del luogo ha in realtà le sue motivazioni profonde nella stessa impostazione del problema.
Ma ora abbiamo assunto lo stile di una ricerca soggettivamente orientata, riportando la discussione indietro sino a un’interpretazione del là. Tema dell’indicazione, abbiamo detto, è la cosa stessa; e abbiamo precisato: la cosa che contiene l’essere-là nell’unità delle sue determinazioni concrete. E non vi possono certamente essere dubbi sul modo in cui viene operata la discriminazione del riferimento locale: il suggerimento che era già presente in precedenza, secondo il quale senza il movimento il luogo non potrebbe apparire, riceve il suo giusto senso solo nel momento in cui viene ripreso e strettamente integrato nel contesto della nostra impostazione. Nella considerazione del movimento, l’essere-là si presenta come mera designazione relativo-soggettiva di un rapporto locale mutevole, e ciò può accadere soltanto se al tempo stesso viene effettuata la separazione, nel là, della cosa dal luogo e se di conseguenza viene acquisito lo sfondo di oggettività in forza del quale possiamo dire: vi sono luoghi, ed essi sono occupati da cose (e io stesso, naturalmente, occupo un luogo).
Eppure si potrebbe ancora chiedere: che ne è del problema a cui abbiamo or ora accennato della percezione del luogo? Possiamo dire realmente di vedere un luogo – per esempio, quel luogo da cui si è mossa la cosa che poco fa lo occupava?
Rispondo di no: e ciò può sembrare davvero strano. Ma se rispondo di sì, mi si potrà chiedere ancora di dire che cosa vedo quando dico di vedere un luogo, di descrivere le sue fattezze. Ha delle fattezze il luogo? E come posso dire di vedere qualcosa, se ciò che io vedo non ha delle fattezze?
Anzitutto «là» indica quella cosa. Poi indica il luogo. Ma non è affatto chiaro allora che cosa venga propriamente indicato.
Il presentarsi di queste domande che, per molti versi, ci riportano in prossimità delle nostre difficoltà iniziali e sembrano addirittura rendere conto, da un diverso punto di vista, delle loro ragioni, mostra che vi è ancora qualche punto importante che resta da chiarire. Questo chiarimento, inoltre, deve essere ricercato proprio sul terreno a cui siamo ora pervenuti dopo aver effettuato il passaggio obbiettivante richiesto dalla considerazione del movimento. E forse, più che alla parola, dovremmo pensare al gesto:io chiedo: «dove?» e un tale stende la mano. Mi dirigo dunque in quella direzione.
Tuttavia può accadere che, dopo un certo tratto, io mi arresti imbarazzato e mi volga indietro nuovamente interrogando. Sto forse cercando il luogo e non lo trovo? Noi diremmo invece che quel gesto non determinava a sufficienza il luogo. Sarebbe perciò inutile iterarlo, come se si potesse segnare a dito qualcosa che non c’è o, in questo modo, portarlo all’esistenza. Invece il luogo c’è quando, per esempio, un mattone viene posto in terra, e io senz’altro lo raggiungo: il mattone, il luogo.
In modo ovvio, e nello stesso tempo singolare si ripresenta la tensione dell’identità e della differenza del luogo e della cosa, ripetendo in una nuova forma, dopo la costituzione del luogo come nozione obbiettiva, il problema che era già presente all’origine. L’inerenza reciproca della cosa e del luogo si manifesta nel fatto che la cosa può essere considerata come una sorta di materializzazione del luogo, come un là materializzato.Prima il là era una determinazione della cosa, ora la cosa e una determinazione del là.
Ciò non significa soltanto che le cose possono assolvere la funzione di contrassegni di luoghi. In realtà la nostra affermazione è più impegnativa, poiché questa funzione deve essere intesa, nel senso dei nostri sviluppi, come un’operazione che, determinando il luogo, lo pone anche in essere.
Anche adottando un punto di vista che, invece di mirare alla definizione, cerca di seguire la via della formazione del concetto, la relazione tra la cosa e il luogo si manifesta in tutta la sua importanza. L’una nozione tende a rifluire nell’altra. Eppure, seguendo questa via, sembra proprio che riusciamo a evitare che una simile connessione si converta in pura e semplice confusione concettuale. In particolare diventa chiaro che il luogo deve essere materialmente determinato: questa determinatezza materiale è la sua condizione costitutiva. Naturalmente l’impiego di una cosa come contrassegno di un luogo rappresenta nulla più di un esempio in cui questa condizione può essere assolta. Mentre ciò che le nostre considerazioni intendono mettere in rilievo è che il luogo ha bisogno di essere materialmente determinato – consista poi questa materializzazione in una qualunque azione di determinazione concreta, come il piantare un paletto nel terreno, l’erigere un recinto o semplicemente il proporre l’immagine di un recinto. Attribuire a questi gesti la capacità di determinare luoghi dipende a sua volta dal riconoscimento che all’essenza del luogo, come siamo tentati di dire, appartiene la delimitazione e la chiusura, e di conseguenza un centro e un confine.
E come se il nostro pensiero del luogo non potesse fare a meno di questa materializzazione e pensando al luogo subito balenasse nella nostra mente un cerchio tracciato sulla sabbia. Ma anche esprimendoci così, continuiamo a mantenere la nostra distanza di sicurezza rispetto a una psicologizzazione della nozione. Ciò che dobbiamo ammettere invece è che, per quanto sia stato superato il piano di estrema soggettivazione da cui abbiamo preso le mosse, ci stiamo ancora muovendo all’interno di un’obbiettivazione di primo livello e ciò significa che in questa configurazione del problema sono ancora presenti elementi di soggettività così come sono attive ed operanti le regole interne dell’esperienza nella quale la nozione di luogo è ancora immersa.
Sottolineare questo punto è particolarmente importante nel momento in cui ci apprestiamo a effettuare il passaggio dal luogo allo spazio.
Questo passaggio segue il movimento interno di un concetto che ha ancora nell’esperienza le proprie radici. Perciò non si tratterà di proporre, astrattamente, lo spazio come la totalità dei luoghi.In tal caso «luogo» sarebbe una qualunque porzione dello spazio ed è chiaro che l’esserci del luogo non avrebbe nulla a che fare con recinti e paletti, così come sarebbe del tutto irrilevante il richiamo al problema della chiusura e della delimitazione. Del resto occorre porre con particolare forza l’accento sul fatto che la nozione della spazialità non è presupposta a quella del luogo, ma al contrario che il pensiero dello spazio sorge da una nozione di luogo non ancora separata dal sentimento della spazialità circoscritta -una nozione in rapporto alla quale l’essere nel luogo ha un senso concreto:noi ci sentiamo in un luogo, sto per dire, come in un’anfora, come in una cavità che ci accoglie.
Ciò che lo spazio e viene detto anzitutto attraverso ciò che è il luogo in forza di una logica oppositiva affatto elementare.
Al chiuso si contrappone l’aperto, al dentro il fuori: e così lo spazio è ciò che si apre, sconfinato, al di là del luogo. Tra luogo e spazio vi è una sorta di opposizione: il luogo è nello spazio come l’oasi è nel deserto. Ma anche una connessione intrinseca: lo spazio lo si scorge dal luogo, il luogo è presupposto quando parliamo dello spazio come l’aperto e senza confine.
Certamente siamo qui molto lontani dalla purezza dei concetti, entrambe le nozioni non sono affatto prive di risonanze emotive e di inclinazioni immaginative latenti. Esse tuttavia – ed è questo che ora ci preme mettere in evidenza – ineriscono in ogni caso ad uno schematismo elementare sul quale è opportuno indugiare un poco.
Si tratta naturalmente, ed ancora una volta, di un cerchio, o più precisamente di un cerchio all’interno di un altro – se vogliamo dare rappresentazione alla cosa che istituisce il luogo determinando il centro e prospettando al tempo stesso il confine.
Questa rappresentazione del luogo
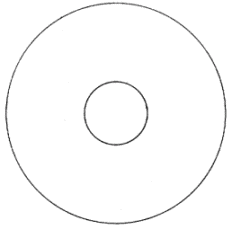
non ci abbandona: con la sua ostinata e imbarazzante semplicità segue l’intero andamento delle nostre considerazioni. Ciò che genera imbarazzo in essa e soprattutto l’evidenza con la quale esibisce la relatività del rapporto, quindi la possibilità dell’iterazione dei cerchi verso l’interno e verso l’esterno. Il problema aristotelico del rapporto di contenente e contenuto sembra così nuovamente riproporsi nonostante la distanza dell’impostazione di principio.
Tuttavia, l’interpretazione che noi daremmo di quella rappresentazione, da un lato rende interessante questo richiamo alle nostre discussioni iniziali, dall’altro mostra che il percorso che abbiamo seguito conduce a conseguenze profondamente differenti.
C’è certo qualcosa di seducente in una filosofia dello spazio ispirata dall’idea delle scatole cinesi, che sono del resto esse stesse una sorta di riflessione concreta sul concetto della spazialità. Ciò che in essa fuorvia è tuttavia la staticità nella quale viene proposto il rapporto tra luogo e luogo e, del resto, tra luogo e spazio; e così anche il fatto che si ripresenta, sia pure attraverso l’immagine del contenitore assoluto, l’idea dello spazio come la totalità dei luoghi. Questa totalità deve essere in qualche modo presupposta come una totalità compiuta, tutti i luoghi debbono essere già dati e segnati tutti i confini.
Non è questo, in realtà, il senso in cui abbiamo parlato dell’apertura dello spazio; e la chiusura del luogo non può essere intesa come se esso fosse circondato da alte mura.
La nostra interpretazione dello schematismo elementare, e dunque anche della rappresentazione proposta tenderà ad accentuare invece la componente dinamica. Perciò osserveremo subito che fuori del luogo non significa per nulla, da subito, nello spazio, ma vorremo quasi dire, attenendoci ai modi del discorso corrente: nei dintorni del luogo, nelle sue vicinanze.Se dunque intorno al cerchio che rappresenta il luogo viene tracciato un altro cerchio, esso non indicherà i confini di un luogo che contiene il precedente, ma andrà inteso piuttosto come una sorta di limite: di qui comincia il lontano.
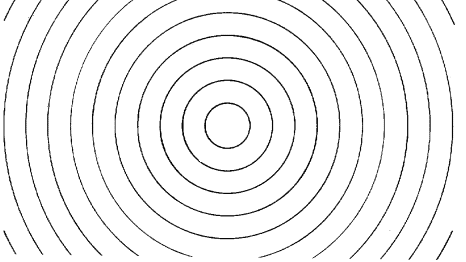
E allora tutti quei cerchi che potremmo tracciare iteratamente alluderanno a un progressivo allontanamento, essi dovranno essere intesi come rappresentazione di una lontananza che sempre più si allontana.
Lo spazio che viene scorto dal luogo è tutto meno che un grande contenitore: in rapporto a esso non si fanno valere soltanto le differenze del chiuso e dell’aperto, ma anche del vicino e del lontano.Il tema del vicino ci riporta al luogo, quello del lontano allo spazio:e non si tratta certamente di una contrapposizione che rimanda a un puro apprezzamento, tendenzialmente obbiettivo, della distanza tra luoghi. L’apertura che abbiamo riconosciuto allo spazio si arricchisce invece del senso del «sempre-più-lontano» e dunque del dinamismo di cui questo senso contiene l’evocazione. Lo spazio è il movimento della lontananza.
E interessante infine considerare anche la possibilità inversa, verso l’interno del luogo. Ciò che accade allora lo possiamo trarre direttamente dalla struttura stessa dello schema e della rappresentazione che abbiamo proposto. Si vede subito che potremmo tracciare cerchi non solo intorno al confine del luogo, ma anche dentro questo confine, operando una progressiva restrizione che ha termine quando viene incontrata, al suo centro, la cosa stessa. Questo potrebbe essere un buon modo di mostrare che delle tre nozioni che sono state fin qui in gioco, la cosa, il luogo, e lo spazio, in rapporto alle quali abbiamo ritenuto di dover marcare soprattutto l’opposizione tra il luogo e lo spazio, il luogo può essere soppresso, poiché la cosa può apparire come punto finale della progressiva contrazione del luogo. Di qui, dalla cosa intesa come ultimo luogo o luogo minimo, come da un sasso gettato nell’acqua, lo spazio inizia il suo movimento.
È importante rendersi conto che vi sono obbiettivazioni di diverso grado. Al grado inferiore, ciò che è stato obbiettivato può essere ancora variamente attraversato da tensioni emotive e immaginative, mentre il processo dell’obbiettivazione può spingersi oltre verso il superamento più completo di ogni residuo del vissuto. Ma sarebbe del tutto sbagliato ritenere che se aumenta il grado dell’obbiettivazione si pervenga per ciò stesso a una realtà di grado più elevato, vorremmo dire, a una realtà più reale.Potremmo dire invece che la realtà stessa è in qualche modo sempre una realtà sfuggente, una realtà che va sfumando nell’una o nell’altra direzione, nella direzione del pensiero o nella direzione opposta del vissuto.
In rapporto al problema del luogo e delle comuni determinazioni locali, ciò significa in particolare che la dimensione della realtà non viene affatto tolta per il semplice fatto che le nostre caratterizzazioni appaiono sotto la tensione delle funzioni dell’immaginazione. Per esempio, non si accetterà affatto come ovvio che differenze come quelle designate dal sopra e dal sotto siano indicative di una relazione puramente soggettiva, mentre a esse va certamente attribuita, al di là di qualunque pretesa di una giustificazione «naturale», una determinata forma di obbiettività e di irrelatività.
Del resto proprio questa obbiettività rende possibile il movimento dell’immaginazione: essa non saprebbe che farsene di determinazioni locali intese come mere relatività soggettive – l’immaginazione ha bisogno invece di qualcosa di simile a una contrapposizione autentica nella quale, per esempio, i poli del sopra e del sotto non possano affatto essere arbitrariamente scambiati. Queste differenze sono differenze reali, fanno parte della nostra realtà. Anche se resta inteso che, a un grado di obbiettivazione più elevato, potrebbe venire meno lo stesso impiego sensato delle parole «sopra» e «sotto», senza che ciò implichi una sorta di incremento della realtà: essa inclina ora in direzione del pensiero, della teoria.
Lo stesso può dirsi dell’opposizione tra il dentro e il fuori, tra il chiuso e l’aperto, di cui abbiamo messo in rilievo l’aderenza alla nozione di luogo. E tuttavia è chiaro che queste determinazioni potrebbero essere intese in modo puramente relativo, e sembrerebbe anzi logico considerarle così. Non è forse vero che ogni entrare è anche un uscire? Posso entrare in un luogo senza nel contempo essere uscito da un altro? È singolare come una simile logica si incontri con l’idea dello spazio come inscatolamento di luoghi – mentre si trovi in urto con gli impieghi linguistici correnti che in realtà non sorgono affatto dai capricci del caso, ma aderiscono alla dimensione della spazialità concretamente esperita. Dobbiamo allora sottolineare che, al di là degli impieghi relativi possibili di quelle opposizioni, fuori deve significare alla fine: a cielo aperto.Cosicché anche noi, nonostante tutto, potremmo dire: tutte le cose sono nel cielo.
Più precisamente: tutte le cose stanno tra cielo e terra, dal momento che, all’interno delle nostre considerazioni, se ci esprimessimo in quel modo non chiameremmo in causa l’idea di una totalità obbiettivamente proposta, ma l’ambiente stesso della nostra vita. Il tema del cielo ci riporta così a quello della terra.Ed è certo strettamente pertinente al nostro argomento interrogarci almeno per un istante su ciò che può significare all’interno di questi sviluppi la parola «terra».
Se qualcuno dice «la terra» subito qualcosa di rotondo e di vagamente sospeso a mezz’aria mi si para dinanzi. Affiorano qui certamente dei ricordi abbastanza lontani. Ci siamo subito ricordati del pianeta.Eppure dovremmo riuscire a ridestare ricordi molto più profondi. Dovremmo ricordarci di una geografia arcaica, di quella geografia che ha inizio nei racconti di coloro che sono andati e tornati da terre molto lontane.
La terra a cui essi fanno ritorno non poteva non avere il carattere di terra centrale, dunque di luogo.Di qui è iniziato il viaggio, sempre più lontano, andando di terra in terra. Ma questo impiego del termine al plurale esibisce fin dall’inizio la possibilità di una modificazione essenziale di senso, stando alla quale si dirà «la terra», semplicemente, in un singolare che non ammette plurale. E anche in questo caso questa parola non è ancora usata come nome di un pianeta.
Sarebbe semplice e logico, in apparenza, poter dire: tutte le terre sono la terra. Ma questo pensiero della totalità non è affatto fondato nel vuoto raccoglimento operato dal «tutti». Concretamente, la terra si costituisce nella possibilità dell’andare sempre più lontano di terra in terra, che è un autentico movimento di allontanamento e non un percorso tra l’indifferenza dei luoghi.
Anche in questo caso si conferma la tendenza del pensiero, che ha le sue giustificazioni effettive nelle funzioni obbiettivanti, a ridurre opposizioni che sono per l’immaginario, ma anche in generale per il pensiero invischiato nell’esperienza, essenzialmente irriducibili. Si potrebbe osservare: che differenza «concettuale» potrai pretendere di stabilire tra il vicino e il lontano? Il lontano non è altro che il vicino del vicino. La lontananza si riduce a una vicinanza semplicemente iterata.
Invece, per rendere conto del modo in cui la terra si costituisce come totalità, abbiamo bisogno di una interpretazione che la consideri in stretta unità con una nozione pregnante di lontananza. E interessante in proposito richiamare quello che è quasi un luogo comune dell’immaginazione mitica: nelle terre più lontane essa pone esseri mostruosi ed eventi straordinari, che non è dato trovare nei dintorni del luogo. Allontanarsi non significa dunque soltanto entrare e uscire da un luogo all’altro, ma avventurarsi in un cammino irto di pericoli inauditi, lungo il quale tende a venire meno ogni regola e norma. Se dunque si parla di confini della terra – dove la terra è intesa come totalità – ciò non accade certamente perché si prenda partito per la finitezza di contro all’infinità, ma il procedere verso questi tremendi confini assume il senso di un allontanamento dal reale verso l’irreale, ancor più che dal noto verso l’ignoto. Sfingi e ircocervi non sono in un luogo, ma ai bordi dello spazio.L’andare sempre più lontano è un approssimarsi a quei confini nei quali la realtà sconfina.
Abbiamo così rievocato un arcaico sentimento della spazialità. Ma tutto ciò che cosa mostra? Che interesse può avere per noi richiamare l’attenzione su una simile condizione appartenente a un passato anche troppo remoto? In queste domande sarebbe giusto cogliere lo spunto di una polemica: perché mai, mentre ci siamo ricordati anzitutto del pianeta, abbiamo subito ritenuto di non doverne tenere conto? Si affaccia qui il sospetto che, alla fine, una tendenza fastidiosamente regressiva si manifesti, in modo più o meno aperto, nei nostri discorsi.
Riprendiamo allora la nostra discussione proprio a partire di qui: tutti ci ricordiamo ora del pianeta. Ma intanto non possiamo certamente non fare notare che la terra e il pianeta non sono affatto la stessa cosa, al di là di ogni richiamo alle fantasticherie del mito. La terra e il pianeta hanno proprietà molto differenti. Per esempio: l’una è piatta; l’altro, invece, e sferico. O più precisamente: la terra non è affatto piatta, ma essa ha le sue montagne e le sue pianure, che possiamo percorrere nei nostri andirivieni terrestri, talora scendendo, talora salendo nello spazio compreso tra cielo e terra.
La terra, intesa così, è il grande teatro della nostra vita.
Certamente, il sapere intorno alla terra ricaccia in un passato irrecuperabile, tra le molte altre cose, anche il senso mitico della lontananza che ancora permane nei viaggi di esplorazione, ma come un senso da confutare e da superare in un progressivo consolidamento della realtà stessa. E come cambia l’atmosfera del viaggio se esso è accompagnato dall’enigma della terra oppure dal sapere rasserenante della rotondità planetaria!
Forse dovrei scusarmi di definire rasserenante questo puro e semplice dato di fatto: la terra è rotonda. Eppure, questa rotondità toglie l’angoscia di un viaggio che avanza in un deserto infinito, verso l’orrore dei confini. L’andare sempre più lontano – sul rotondo – è anche un ritornare. Allontanandomi, mi avvicino. Viaggiando, sto quasi fermo: resto in luogo.
Certo, la rotondità non appartiene fin dall’inizio all’esperienza della terra: nella storia del problema, la percezione viene indubbiamente per ultima. All’interno della tematica platonica essa viene proposta nel quadro di un possibile sistema della natura fantasticato sotto il fascino delle perfette proporzioni: e poi ragionamenti e osservazioni effettive sono in qualche modo entrati – con nostra meraviglia e soddisfazione – in concordanza con ciò che era certamente il frutto di un ragionamento bastardo. Infine la rotondità è diventata, nell’esperienza dell’astronauta, un fatto percettivo concreto. Noi sappiamo tutto questo. E perciò viviamo sulla terra nella permanente consapevolezza di una dimensione «cosmica», nella quale la terra è anzitutto un pianeta e la nozione della spazialità è di conseguenza profondamente mutata. Perché allora ostinarsi a parlare dello spazio come di uno spazio compreso tra cielo e terra? Una simile nozione di spazialità rozzamente fenomenologico-antropologica non ha più alcuna ragione d’essere.
Questa osservazione coglierebbe nel segno se all’idea di spazio «cosmico» non fosse in alcun modo applicabile lo schematismo strutturale intorno allo spazio e al luogo che sta alla base dell’intera nostra discussione: se dunque, giunti a questo punto, essa dovesse operare una svolta rinnovando interamente i suoi termini.
Eppure una simile svolta non sembra affatto necessaria. Il punto essenziale lo abbiamo già suggerito: lo spazio cosmico è in ogni caso lo spazio di una esperienza possibile. Lo è naturalmente anche per noi, uomini comuni, che siamo destinati al massimo a viaggiare sul rotondo.
Io, per esempio, non ho nessuna difficoltà a immaginare la terra in questo modo, cioè a immaginare l’esperienza della terra come di un pianeta – non ho nessuna difficoltà a immergermi in questa fantasticheria astronautica. Anzi, quando guardo un mappamondo, mi sento quasi mancare la terra sotto i piedi – mi sento, appunto, nello spazio. E ora volgo lo sguardo verso la terra. Essa è là.Ed è importante notare che non possiamo mai esprimerci così in rapporto alla terra che non è un pianeta. Invece ora ha certamente senso dire: la terra è là.Dunque, essa è una cosa. Mentre la terra che non è un pianeta non ha mai carattere di cosa. Prima o poi dobbiamo accorgerci di questo: noi viviamo sopra una cosa.
Perciò la differenza è profonda: ora non vi è più né il cielo né la terra, nel senso in cui ne parlavamo prima, e nemmeno vi è un sopra e un sotto, cosicché sembra del tutto priva di fondamento quella distinzione che prima ritenevamo di poter addirittura sottrarre all’ambito delle pure relatività soggettive. Ma subito si deve notare che la nostra fantasticheria astronautica è una fantasticheria concreta e ognuna delle parole dì cui ci serviamo per descriverla ha un senso concreto. Perciò, quando diciamo che non c’è un sopra e non c’è un sotto, queste espressioni negative rimandano alle proposizioni affermative corrispondenti e hanno un criterio del senso che rinvia alla terra in quanto non è affatto un pianeta.
Lo spazio terrestre si è modificato nello spazio cosmico, ma anche questo appartiene all’ambito di un’esperienza possibile. Perciò lo schema al quale in precedenza abbiamo fatto ricorso non viene affatto soppresso, ma proprio nel passaggio dallo spazio terrestre allo spazio cosmico, esso sembra presentarsi in tutta la sua semplicità, quasi che proprio in questa immagine della terra nello spazio gli elementi di quello schema vengano liberati da confusi dettagli, da particolari minuti e insignificanti. Ora vi è la terra, e soltanto la terra: cioè, la cosa, il luogo minimo; e di qui, lo spazio aperto.
12. Il pensiero dello spazio suddiviso
Nello sviluppo della discussione che abbiamo condotto fin qui è certamente rimasto in ombra quel diverso modo di considerare lo spazio che era affiorato nel corso della nostra digressione platonica. Ci siamo mossi piuttosto sulla linea di prevalenti motivi aristotelici, sia pure liberamente reinventati. Numerose formulazioni aristoteliche ci sono sembrate poter ricevere un senso, in modo talvolta inatteso, anche in una profonda modificazione di prospettiva teoretica. L’orientamento delle nostre riflessioni è stato comunque quello di delineare il costituirsi di una nozione di spazialità in stretta connessione con la cosa materiale concretamente data nell’esperienza, tentando anche di mostrare fino a che punto può essere spinto questo ambito di considerazioni che si mantiene coscientemente e coerentemente all’interno di una dimensione fenomenologico-antropologica. In Aristotele invece questa dimensione, inevitabilmente presente in una problematica che è appena ai suoi inizi, è già prospettata in vista del suo superamento, ed è proprio in questo aspetto che consiste la profondità e la portata della sua esposizione. In realtà, per quanto possa essere singolare e un poco fuorviante l’impiego di una simile terminologia, ciò che potremmo chiamare spazio fisico – distinguendolo dallo spazio «cosmico» nel senso or ora illustrato -potrebbe essere caratterizzato negativamente proprio dal fatto che esso non è lo spazio di un’esperienza possibile. Lo spazio fisico è invece lo spazio pensato in connessione necessaria con il problema di una teoria della materia.
Ma vi è anche un altro modo di pensare lo spazio – allo spazio fisico si può contrapporre lo spazio geometrico, oppure, come noi preferiamo dire, lo spazio-estensione.Questa differenza potrebbe essere suggerita richiamando l’attenzione su due modi possibili di rispondere alla domanda intorno alla caratteristica spaziale delle cose: da un lato, possiamo richiamarci alla loro possibilità di localizzazione – ed è questa la risposta alla quale fin qui ci siamo essenzialmente attenuti. Ma si può anche dare una risposta che non fa menzione del luogo, ma dell’estensione.Le cose sono estese. Oppure, come anche si dice: esse partecipano all’estensione.
Io credo che la seconda risposta richieda assai più spiegazioni della prima: essa non si presenta senz’altro comprensibile, altrettanto ovvia ed evidente. Su che cosa infatti intendo propriamente richiamare l’attenzione quando affermo che le cose sono estese? E non richiede forse di ricevere qualche giustificazione il parlare di partecipazione delle cose all’estensione? Che rapporto sussiste tra le cose e l’estensione, se il verbo «partecipare» ci sembra adatto ad esprimerlo? La risposta a domande come queste non è per nulla a portata di mano, e si è persino tentati di ricondurre la seconda risposta alla prima, come se dire che le cose sono partecipi dell’estensione fosse solo un modo inutilmente complesso di affermare la loro possibilità di essere in un luogo. Invece occorre sottolineare con forza che la seconda risposta non è affatto equivalente alla prima: essa mostra invece una diversa inclinazione da cui considerare il problema dello spazio, secondo la quale la nozione di luogo non sembra esplicare alcuna funzione. Più precisamente: non sembra esplicare una funzione la cosa nella sua materialità specifica, la cosa intesa come un plenum materiale, come pienezza.
Ora, ci sembra interessante avviarci alla conclusione mostrando in breve che l’impianto concettuale che ci è servito da fondamento e da guida alle nostre riflessioni è in grado di rendere conto del problema dello spazio-estensione e di fornire in rapporto a esso i primi necessari chiarimenti.
Cominceremo con una annotazione che avremmo potuto proporre anche in precedenza, ma che abbiamo evitato di fare perché sarebbe parsa del tutto marginale.
Più volte abbiamo fatto notare che la cosa e il luogo sono nozioni che possono rifluire l’una nell’altra. Ora aggiungiamo l’osservazione secondo la quale vi è fra esse un vero e proprio gioco delle parti: l’una può svolgere il ruolo dell’altra. Ciò significa che, in questo scambio, o la cosa o il luogo resta in ogni caso sulla scena.
Una simile osservazione è certamente destinata ad apparire irrilevante finché non si fa notare che vi è anche un altro modo di confluenza delle due nozioni che ha un senso interamente diverso e che implica la loro dissoluzione reciproca.
Con ciò la discussione si apre su uno degli altri grandi temi che appartengono all’area del problema dello spazio: tutte le nostre considerazioni precedenti rimandavano, come abbiamo notato or ora, alla cosa considerata come pienezza, come materia.Ora deve invece essere riconsiderato il tema della forma. In particolare, chiamando in causa questo tema cercheremo di mostrare in che modo possa avvenire il passaggio dall’una all’altra prospettiva del problema della spazialità.
Abbiamo già notato in precedenza che qualunque impiego complesso ed elaborato della parola forma rimanda a un senso elementare che può essere attinto e illustrato proprio ricollegandosi alla cosa in quanto oggettività della percezione. La forma viene infatti percepita come essenzialmente inerente a essa, cosicché possiamo dire che la tendenza all’informe può essere considerata come una tendenza alla perdita dell’individualità e della stabilità che caratterizzano le cose. Esse debbono potersi contraddistinguere. Perciò hanno necessariamente una forma. Questa parola allude dunque alla distinzione di un contorno che può essere tastato con la punta delle dita o seguito con lo sguardo. Tenendo conto di ciò si comprende subito ciò che a tutta prima può sembrarci solo un’affermazione oscura: la forma è anzitutto forma chiusa.
Questo problema della chiusura della forma, che potrebbe trovare elaborazione sul piano di una fenomenologia della percezione, deve essere qui prospettato piuttosto come una relazione di ordine concettuale. Al concetto della forma spetta la chiusura: e ciò non significa che non potremmo usare la parola «forma» in modo da indicare figurazioni qualsiasi, aperte o chiuse che siano. Quella affermazione deve essere intesa infatti in modo da implicare ancora nel tema della forma il riferimento alla pienezza della cosa. Appare allora chiaro che non sarebbe lecito parlare di una messa in forma se non vi fosse anche la determinazione di una sagoma e di un contorno. La pienezza deve essere in qualche modo rinchiusa e circoscritta, e se lo fosse incompletamente vi sarebbe non tanto una forma aperta, quanto piuttosto una cosa incompleta, come se l’oggetto plasmato dall’orafo affondasse in parte nell’oro ancora incandescente.
Ma la chiusura è anche una determinazione essenziale del luogo.Perciò possiamo sostenere che la forma contiene un richiamo sia alla cosa che al luogo: e anche che l’una nozione si dissolve nell’altra in modo tale che il risultato di questa reciproca dissoluzione sia l’emergenza della forma. Sulla scena vi è ora soltanto la forma.
Ciò sembra intanto poter essere inteso come una riaffermazione di osservazioni precedenti. Come è fatto il luogo? – ci siamo chiesti una volta. E abbiamo già risposto all’incirca in questo modo: là vi sia una cosa. Ora la togliamo da quel luogo, e tuttavia la sua sagoma è ancora presente nella nostra mente. Quel luogo che prima era occupato dalla cosa è fatto così.
Ma in realtà noi intendiamo mostrare che il problema della forma può essere formulato in modo tale che della cosa e del luogo non rimanga più di un lontano ricordo, benché possa essere inizialmente proposto in inerenza a essi. Mentre tutta la tematica precedente poteva essere riunita sotto il titolo lo spazio e la cosa si assume ora un diverso orientamento secondo il quale lo spazio e la forma debbono essere concettualmente correlati senza mediazioni l’uno all’altra. Questa correlazione viene effettuata, nell’esperienza, attraverso la mediazione della cosa. Escludere questa mediazione, allontanando dalla nozione della forma l’immagine della cosa significa allora pensare la forma mettendo interamente da parte il suo rapporto con la pienezza, e quindi anche con l’opposizione del vuoto e del pieno.Questa opposizione è ovunque presente nello spazio percepito: lo spazio circostante è fatto di vuoti e di pieni, e là dove ci sono i pieni ci sono anche le cose. In questo contesto si addice certamente una nozione della forma come contorno che delimita la pienezza.
Ma non è forse possibile intendere la forma in modo interamente indipendente da questo rapporto? Pensiamo a un disegno raffigurante un ambiente, dal quale fossero cancellati a poco a poco tutti quei segnali visivi che hanno il compito di rappresentare la differenza tra il vuoto e il pieno. Fino a un certo punto riusciremo ancora a scorgere sagome di oggetti, dunque cose e luoghi, forme nell’accezione elementare della parola. Ma quando la differenza tra il vuoto e il pieno è stata interamente tolta, ci troveremo allora alla presenza di un semplice grafismo, di un reticolato di linee dal quale sarebbe tolto ogni riferimento alla realtà in genere: non vi sarebbero dunque più sagome, con il loro rimando a cose e luoghi. Le linee che prima contrassegnavano contorni sono diventate ora linee che operano una suddivisione dello spazio e che in questo modo determinano forme.La parola forma ha ora un senso interamente diverso: essa significa null’altro che parte dello spazio.Con ciò viene proposta l’idea dello spazio come di una totalità omogenea che può essere differenziata soltanto attraverso una partizione. Essa contiene tutte le forme, e anche nessuna.
Lo spazio-estensione è il pensiero dello spazio suddiviso.Ed è, nello stesso tempo, lo spazio pensato dal punto di vista della forma.
Il tema della parte e dell’intero, che non è certamente rimasto estraneo alle nostre discussioni iniziali, mostra ora di assolvere una funzione decisiva nella determinazione di questo nuovo momento della problematica dello spazio. E ad esso si giunge superando la dimensione dell’esperienza, ma non al punto che non sia possibile scorgere ancora la continuità di un percorso che riconduce a concetti ricchi di contenuto.
Una rottura effettiva, che ha anche il senso di un radicale mutamento nell’impostazione del problema, si ha invece quando si coglie nell’impiego metaforico della parola «luogo» la possibilità di una generalizzazione concettuale. Per esempio, si può parlare del luogo occupato da una persona all’interno di un albero genealogico – per rammentare di sbieco una nota immagine leibniziana. La parola «spazio» potrebbe allora essere impiegata per indicare un sistema ordinato qualunque, e di conseguenza «cosa» un elemento del sistema e «luogo» una posizione all’interno di esso, la cui determinazione deve essere in linea di principio puramente relazionale.
Le nostre riflessioni sul luogo si arrestano poco prima che venga effettuato questo passaggio decisivo che, per molti versi, può essere concepito come un superamento ed una soppressione della tematica propria della spazialità: poco prima che la tematica dello spazio si svuoti in quella della relazione.
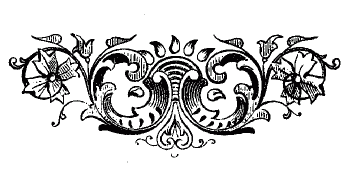
Note
[1] Aristotele, Fisica, IV, 208 a 30. Si fa riferimento alla tr. it. di A. Russo, Laterza, Bari 1968.
[2] ivi,208 a 33.
[3] ivi,208 a 35.
[4] ivi,209 a 25.
[5] ivi, 209 a 18.
[6] ivi,209 a 9.
[7] Platone, Timeo, 33 b. – Si fa riferimento alla tr. it. di C. Giarratano, Platone, Opere complete, voi. VI, Laterza, Bari 1971, p. 361 e sgg.
[8] ivi,63 a.
[9] ivi, 49 c.
[10] ivi,48 d. È evidentemente fonte di confusione la traduzione «lieu» proposta da A. Rivaud in Platon. Oeuvres complètes, Belles Lettres, Paris 1985, voi. x, p. 166 e sgg.
[11] ivi, 52 b.
[12] ivi, 49 e.
[13] ivi, 53 e.
[14] Nella discussione della posizione di Platone viene implicata anche quella degli atomisti. Su questo punto si veda J. Moreau, L’espace et le temps selon Aristote, Editrice Antenore, Padova 1965, capp. I-II.. In questo stesso testo potranno essere considerati i commenti alle citazioni aristoteliche esplicite del Timeo platonico (in particolare, p. 22 e sgg.). Sull’argomento si può leggere con interesse la tesi latina di Bergson, Quid Aristoteles de loco senserit, disponibile anche in traduzione italiana in H. Bergson, Opere 1889-1896, a cura di P.A. Rovatti, L’idea di luogo di Aristotele, tr. it. di F. Franco Repellini, Mondadori, Milano 1986, p. 345 e sgg.
[15] Fisica, IV, 209 a 33.
[16] ivi,209 b 2.
[17] ivi,209 b 23.
[18] ivi,209 b 28.
[19] ivi,210 a 24.
[20] ivi,208 b 3.
[21] ivi,210 b 10.
[22] ivi,V, 226 b 20 e VI, 231 a 22-23. Cfr. J. Moreau, op. cit., p. 35.
[23] ivi, 211 a 30.
[24] ivi, 212 a 5.
[25] Cfr. J. Moreau, op. cit., p. 41.
[26] Fisica, IV, 212 b 15.
[27] ivi, pp.212 b 18.
[28] J. Moreau, op. cit., pp. 41-42.
[29] Fisica, IV, 209 b 29.
[30] ivi,211 a 35.
[31] ivi,212 a 15.
[32] ivi,212 a 20:
![]()
[33] ivi,pp. 210 b 30. L’enfasi, aggiunta dal traduttore, non è in realtà inopportuna.
[34] Ricerche filosofiche, oss. 127.

