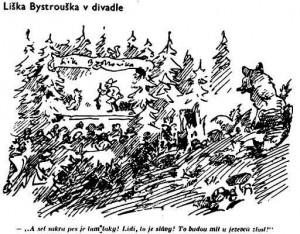La letteratura è stata sempre un campo ideale per pensare alla Natura, della quale non ha fatto solo un oggetto di contemplazione o di ambientazione delle diverse fabulae, ma anche l’occasione per una riflessione in grado di distanziarsi da essa quel tanto necessario a far sentire l’uomo in sicurezza (la Natura, come la cronaca tristemente insegna, è una forza che si cerca spesso di dominare, ma non sempre si riesce a controllare). Questo post vuol presentare due esempi di siffatto distanziamento, mostrando il procedimento che ha reso possibile trasformare la Natura e i suoi fenomeni in strumenti retorici. Proprio la retorica antica insegna, nella teoria come nella pratica (ma io mi occuperò solo della pratica), a sfruttare la Natura a fini diversi da quelli contemplativi o di una sua raffigurazione pittorica.
Semplificando un poco il discorso, direi che la Natura in quanto fenomeno complessivo si caratterizza sostanzialmente per due tratti. Il primo è la ciclicità – in Natura tutto si ripete uguale, a regolare distanza di tempo, nella successione degli anni e delle stagioni. In questa ripetizione i singoli si possono perdere, ma poco importa. Per la Natura, l’affermazione e la sopravvivenza del genere e della specie contano più dell’affermazione e della sopravvivenza dell’individuo, che pure incarna nella sua generazione quel genere e quella specie. D’altra parte, se guardiamo le cose dal punto di vista del singolo individuo, questi trova una ragione d’essere proprio nell’affermarsi del genere e della specie, affermarsi che passa solo in minima parte attraverso l’affermazione di sé e solo in minima parte coincide con essa – l’affermazione di sé può essere perciò un mezzo, ma non è mai un fine. Ciò è fonte di rassicurazione per l’uomo (le cose assumono così un senso, anche quando i destini individuali sembrino insensati), ma è anche fonte di preoccupazione e di timore (l’uomo è fortemente individualista e tende a sopravvalutare se stesso; la cultura occidentale nel suo complesso esalta questo culto dell’individualità).
Il secondo tratto caratteristico, che poi in realtà è solo in parte differente e differenziabile dal primo, consiste nella ripetitività – specie animali e piante, in una data situazione, si comportano sempre allo stesso modo, fatti salvi, come abbiamo imparato negli ultimi cento anni ca., i pochi casi di variazione genetica o di lento adattamento a mutate circostanze ambientali. Anche questo è tranquillizzante, ma nello stesso tempo è fonte di timore e di preoccupazione, e per le stesse ragioni indicate prima: l’idea offre una certa sicurezza, perché si sa come comportarsi quando si incontrano i diversi fenomeni di Natura, e si sa come si comporteranno essi; ma questo è anche la negazione dell’individualismo e del libero arbitrio, poiché le scelte comportamentali dipendono ora più dall’appartenenza del singolo a un determinato genere o specie, che non dalla sua volontà.
Di queste idee offro qui due esempi.
Partiamo dal ciclo della vita: la prima, notissima affermazione, si trova in Omero, Iliade VI, vv. 119ss. Diomede incontra sul campo di battaglia un guerriero a lui sconosciuto, con il quale pensa di combattere, e gli chiede con ampio giro di parole chi sia. Il guerriero è Glauco, figlio di Ippoloco, che così risponde (vv. 145-149): “Tidide magnanimo, perché chiedi chi io sia? Come è la stirpe delle foglie [in greco, γενεὴ], così è quella degli uomini. Delle foglie il vento ne può gettare a terra alcune, ma altre la selva [noi diremmo: la forza intrinseca della Natura] ne mette fuori di nuove, e fa primavera. Così è anche per gli uomini: una generazione nasce, una muore”. È la γενεὴ¸ la stirpe, quello che conta; il destino dei singoli in questa linea si può anche perdere. Glauco vanta un’ascendenza che risale fino a Sisifo e a Bellerofonte, e di essa si compiace (vv. 150-206); ma proprio questa ascendenza lo obbliga a dover essere degno dei suoi avi e superiore quindi a tutti coloro che vengano da Efira o dalla Lidia dai ricchi pascoli, come dice ai vv. 207-210. Nel complesso della battuta di solito si enfatizza la prima parte del discorso e della similitudine (l’immagine della foglia che si fa simbolo di precarietà, Leopardi e Ungaretti docent), perdendo di vista, credo, il complesso del passo. Quello che dice Glauco è che chi è lui, come singolo, conta solo relativamente, perché il suo destino di singolo è relativamente ininfluente: poco importa che muoia per mano di Diomede o di qualche altro eroe (secondo la tradizione, morirà ucciso da Aiace, lottando per conquistare le armi di Achille; ma questo avviene fuori dallo spazio narrativo dell’Iliade); quello che Glauco sa è che, se deve morire in battaglia, morirà per mano di un eroe, combattendo eroicamente; e nella stirpe di Sisifo e Bellerofonte verrà rimpiazzato da qualche altro guerriero, pronto a sua volta a lanciarsi eroicamente in battaglia se appena se ne darà l’occasione, e a morirvi se sarà necessario, ma combattendo eroicamente contro qualche grande guerriero. Il che è dote di Glauco, ma è dote anche della sua stirpe. Ogni discendente di Sisifo e Bellerofonte è fatto così e non può che essere fatto così, e andare quindi incontro a identico destino, se necessario, proprio perché discende da Sisifo e da Bellerofonte; così come le foglie dell’albero sono foglie di quell’albero, che potranno anche essere prima o poi scosse dal vento, ma che sanno di essere sostituite nella primavera successiva da altre foglie, diverse eppure simili a loro, pronte a resistere eroicamente fino a quando non siano scosse a loro volta dal vento. Mimnermo è, per quanto ne sappiamo, il primo che ha riutilizzato la similitudine e ne ha fatto qualcosa di diverso; come spesso avviene in letteratura, questo mutamento ha poi condizionato la lettura del passo omerico – ma questa è una vicenda che qui non ci interessa.
Più utile è forse mostrare un’altra manifestazione, in pieno Novecento, dello stesso concetto, e creare così una catena da collegare a Omero, affiancandola, se non addirittura sostituendola, a quella tradizionale. Mi rifaccio a qualcosa che non ha diretta relazione con il testo omerico, ma proprio per questo è ancora più importante, perché dimostra come Omero non abbia fatto altro che applicare per primo un sentire che è dell’umanità, indipendentemente dalle epoche e dalle collocazioni culturali e geografiche. Si tratta di una fortunata serie a fumetti, divenuta poi un romanzo per ragazzi di qualche successo e infine una composizione musicale in grado di valicare i limiti e i confini di tempo, di spazio e di lingua (da lì ne ho ricavato notizia). Da aprile a giugno dell’anno 1920, su un quotidiano edito a Brno e intitolato Lidové noviny, venne pubblicata una striscia pressoché giornaliera, a firma di Rudolf Těsnohlídek [1882-1924] e illustrata da Stanislav Lolek [1873-1936], che aveva nome “La volpe Bystroushka” (Liška Bystrouška). Ne riproduco qui una vignetta:
L’anno dopo la striscia divenne un romanzo per ragazzi che, dai dati ricavabili via internet, risulta godere di un certo successo editoriale ancora oggi:
Nel 1924 il romanzo fu trasformato in opera lirica, autore di libretto e musica Leoš Janáček, che usò il titolo “Le avventure della volpe Bystroushka” (Příhody lišky Bystroušky). Come è successo a quasi tutto il patrimonio artistico ceco, musicale e no, la sua diffusione in Europa avvenne attraverso la Germania e la traduzione in tedesco. A tradurre il testo di Janáček fu Max Brod, amico, biografo ed esecutore testamentario (infedele) di Kafka, che chiamò l’opera “La piccola volpe astuta”; e con questo nome essa è nota in Italia, dove si è vista più volte. È la storia di una volpe, Bystroushka appunto, catturata da un guardiacaccia che, mentre stava dormendo nel bosco, è stato svegliato da una piccola rana cui la volpe dava la caccia e che, per sfuggire all’agguato, gli era saltata sul naso. La scelta del guardiacaccia di prendere la volpe con sé e portarla a casa per farne dono alla moglie rompe la normalità della Natura, dove è usuale che vivano rane e volpi e che le prime siano vittime delle seconde. Il guardiacaccia, che è un uomo e agisce con mentalità tipicamente umana, vuole invece imporre un proprio ordine alle cose, prendendo una decisione che sovverte le regole; non si limita a uccidere la volpe, fatalità possibile e prevedibile in Natura, ma, colpito dalla bellezza dell’animale, pensa di poterlo addomesticare. Non andrà così: la volpe, che è davvero astutissima, alla fine mette disordine in tutta l’abitazione del guardiacaccia; riconquista la libertà; e nel bosco trova un bel volpacchiotto al quale si unisce. La striscia a fumetti e il romanzo finiscono qui, ricomponendo un’unità che era stata spezzata dall’intervento umano. Janáček aggiunge invece due scene, in una delle quali la volpe rimane ugualmente uccisa, abbattuta da altri cacciatori. Nella scena finale, a un anno esatto di distanza dall’inizio, si ripete la situazione di partenza: il guardiacaccia si trova ancora a dormire nel bosco, più stanco e più vecchio (ma anche più saggio). Svegliato di nuovo da una rana, si accorge della presenza di una bellissima volpe dalla coda argentata, che riconosce come la figlia della precedente, della cui morte è al corrente; fa per catturarla, ma, fattosi riflessivo, la lascia andare, e si tiene piuttosto vicina la rana, che subito gracida: “Non sono la stessa, non sono la stessa. Era mio nonno, era mio nonno. Mi hanno parlato di voi, mi hanno parlato di voi”.
Riporto qui il preludio dell’opera, che descrive la vita sotterranea della foresta in termini propri alla temperie tardoromantica; in fondo al post lascio invece il link per la suite in due tempi, ambedue marcati “Andante”, che Janáček ricavò dall’opera (per i diritti di copyright rinvio alla pagina di youtube che ha reso l’incisione di pubblico dominio).
La Natura si ripete nelle diverse generazioni (più rapide quelle della rana: due in un anno; più lente quelle di una volpe: una sola; lentissime, a paragone, quelle dell’uomo, che a un anno di distanza è ancora lo stesso individuo). Il singolo può sentirsi ed apparire effettivamente unico e irripetibile: Bystroushka è davvero bellissima e intelligentissima, come vuole il titolo tedesco dell’opera. Ma alla Natura poco importa; importa che a primavera ci siano una volpe e una rana. In questo quadro, l’uomo è l’elemento che stona, perché non sa inserirsi con semplicità entro quest’ordine e vuole imporre un proprio ordine. Esperienza, vecchiaia, amarezza (parallelamente alla storia principale si inseriscono, nelle vignette del fumetto come nelle scene dell’opera, anche delle riflessioni tutte giocate sul piano dell’esperienza umana del guardiacaccia, della sua famiglia, dei suoi amici) insegnano a volte la giusta lezione – l’uomo deve saper accettare di essere parte di un tutto che ha andamento ciclico e che sempre si rinnova, senza intervenire su di esso. Queste considerazioni le fa, da par suo, applicandole alla vita, alla filosofia e all’arte, ma sempre partendo dal testo di Janáček, anche un romanziere e saggista come Milan Kundera, il cui padre – musicologo – era stato allievo di Janáček. In Italia le ha pubblicate Adelphi (I testamenti traditi), e ad esse quindi rinvio. C’è, come si vede, una catena, diversa e complementare da quella che comunemente si associa al passo omerico dal quale siamo partiti, ma che mi sembra possa funzionare come commento non banale della similitudine famosa e come suo completamento. A dimostrazione, fra l’altro, anche di una delle ragioni essenziali per lo studio dei classici, ossia il loro carattere archetipico rispetto a molte parti del sentire e del pensare moderno, perfino quando esso non sia direttamente derivato da loro.
Vengo al secondo esempio promesso. Fin qui, ho parlato di ciclicità. Ora vorrei sottolineare la ripetizione immancabile dei comportamenti, che ovviamente è già implicita nella ciclicità (queste distinzioni sono più di comodo che reali, come ho detto all’inizio). Parto anche qui da un passo famoso: nella II egloga di Virgilio, Coridone vuole convincere Alessi dell’inevitabilità e dell’eternità del suo amore, ricordando come esso risponda a una legge di Natura. Siamo sul finire della suasoria, e Coridone esprime il concetto con una catena ben nota (vv. 63-65): Torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam, / florentem cytisum sequitur lasciva capella, / te Corydon, o Alexi: trahit sua quemque voluptas. Coridone segue e seguirà sempre Alessi con la stessa ovvietà, insistenza e naturalezza con la quale ogni animale è attratto dal cibo preferito, al quale dà la caccia e che prima o poi, si immagina, raggiunge. Alle spalle della struttura c’è, come sempre nelle Bucoliche, un passo di Teocrito, da Virgilio completamente rifatto. Si tratta dell’idillio X, vv. 30-31, dal titolo I mietitori. Buceo e Milone stanno mietendo un campo di grano, il primo con meno lena del dovuto. Il secondo lo irride: è amore che lo infiacchisce, e per di più per una ragazza che non vale tanto. Su invito dell’amico, Buceo canta una canzone (Milone risponderà con un’altra, di carattere ironico): O graziosa Bombìca, sei chiamata da tutti Sira, magra, arsa dal sole, da me soltanto del color del miele. Anche la viola è nera, anche il giacinto segnato dalle lettere, eppure nelle corone sono i primi ad essere scelti. La capra va dietro al citiso, alla capra va dietro il lupo, la gru segue l’aratro, e io per te son diventato folle. Come Buceo ha detto precedentemente, non solo Pluto è cieco: lo è anche Eros, e non riflette mai su quello che fa (vv. 19-20). Messi a confronto i due testi, in Teocrito manca la gnome conclusiva, che si ricava semmai dal contesto; non c’è nemmeno la situazione struggente dell’egloga virgiliana (in Teocrito siamo all’interno di un canto, in un idillio dal tono scherzoso; in Virgilio la sequenza proposta è una forma di convincimento, in un’egloga di carattere drammatico); la successione degli animali è meno strutturata in Teocrito, chiasmo e poliptoto non sono strettamente connessi. Ma a me interessa soprattutto questo: la leonessa va a caccia, come il lupo e, a modo suo, la capretta, ognuno alla ricerca di quanto è per loro normale e naturale inseguire e raggiungere. Coridone crea una catena di similitudini dove un termine del confronto – quello di Natura – si impone come certo e reale, proprio per quei caratteri che, lo dicevo all’inizio, sono tipici del mondo di Natura. Per l’uomo le cose vanno diversamente: Alessi non è lì e non sarà persuaso dalla suasoria che neppure sente, non verrà mai raggiunto da Coridone, che di lì a pochi versi riconosce questa verità nell’amaro finale dell’egloga. Ora vorrei leggere poche righe di un racconto russo, autore Nikolai Leskov [1831-1895], titolo Una lady Macbeth del distretto di Mtsensk [1865]. Anche in questo caso a portarmi al testo è stata una composizione musicale, l’omonima opera che ne trasse Dmitrij Šostakovič [1906-1975] nel 1934, libretto suo e di Alexander Preis. Così traduce Laura Micheletti: Il puledro rincorre la giumenta, il gattino cerca la gattina, il colombo si precipita dalla colombella. Soltanto da me nessuno si affretta. Il vento accarezza la betulla, col suo tepore il sole la riscalda; per tutti c’è un sorriso. Soltanto da me nessuno si affretta, nessuno avvolgerà con il suo braccio il mio corpo, nessuno accosterà le sue labbra alle mie, nessuno accarezzerà il mio petto, nessuno mi sposserà con le sue focose carezze. Come si vede, la struttura è meno precisa nella forma, ma identica nella concezione di fondo. Questi sono i pensieri di Katerina Izmailova, la protagonista del racconto, donna piacente e malmaritata, che in assenza del marito soffre di solitudine (ma non è che il marito le sia di gran compagnia), e si avvolge sempre di più in una spirale di autoerotismo – è tarda sera, Katerina è nella sua stanza, in attesa non sa bene nemmeno lei di che (o di chi), convinta di una ripetitività della Natura che condanna lei sola all’essere diversa. Katerina dalla catena si chiama fuori: tutti rincorrono e raggiungono qualcosa; soltanto io non sono rincorsa e raggiunta da nessuno. Ebbene, alla fine non sarà così. Appena finito il ragionamento, alla finestra della donna batte Sergej, un lavorante al servizio del marito, che ha già avuto occasione di farsi notare anche da Katerina. Braccia, labbra, carezze: non mancherà nulla, e altro ancora (anche se, ovviamente, questo è per entrambi l’inizio della fine: il romanzo ottocentesco, si sa, è un genere moralista).
© Massimo Gioseffi, 2017
Leoš Janáček, Suite dall’opera “La piccola volpe astuta”